I rom di romania PDF

| Title | I rom di romania |
|---|---|
| Author | Giulia Succi |
| Course | Storia Dell'Europa Orientale M-Sto/03 |
| Institution | Università degli Studi di Trieste |
| Pages | 14 |
| File Size | 319.5 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 33 |
| Total Views | 129 |
Summary
Libro che traccia la storia dei rom di Romania dal 1800 ad oggi...
Description
Alessandro Pistecchia I ROM DI ROMANIA La ricostruzione delle vicende dei rom d’Europa è stata a lungo legata intorno al dibattito dell’Indian connection, cioè l’ipotesi secondo cui esiste una parentela tra la lingua romanes subcontinente indiano. L’Indian connection rischia però di creare confusione, soprattutto se la ricerca riguarda popolazioni presenti in Europa da molti secoli. Infatti la costruzione delle singole comunità rom, si mantiene distinta da quella dei gagé ma allo stesso tempo è diversificata da una comunità all’ altra. Per studiare le popolazioni zingare è necessario tenere conto di questa presenza costante dell’altrui in esse , e della loro capacità di manipolare a scopi interni ciò che viene dall’esterno. Nei secoli i rom hanno trovato posto a cavallo tra le frontiere, dove gli era permesso vivere con i parametri dei sistemi romanes e gli incessanti spostamenti dovuti soprattutto a motivazioni economiche e a migrazioni forzate ne hanno segnato il carattere transnazionale dei rom europei. PARTE I I ROM A NORD DEL DANUBIO La connessione indiana e l’approdo alle terre romene Nell’ 800 iniziano le ricerche sulla provenienza dei rom e si ipotizza la cosidetta Indian connection, in realtà pero la e le profonde tra i gruppi rischiavano di rendere sterili i risultati e così si preferì dire che gli zingari erano un conglomerato composto da gruppi diversi. o dall’ Asia Minore alla Tracia per poi giungere in Romania, Grecia, Serbia, e e questo lo sappiamo grazie a degli del tempo che ne attestano la presenza nei monasteri e presso i grandi boiari. C’è anche un'altra versione che ipotizza che l’ingresso dei rom nelle terre romene fosse conseguente alle invasioni tartare ma, le diverse soluzioni abitative, lo statuto giuridico dei rom è diverso da quello dei tartari e inoltre sono presenti nella lingua romanes e (la parola zingaro deriva dalla parola greca tigani). La diffusione dei rom nelle terre romene è un processo di lungo periodo ed è conseguenza delle i e e alla loro sopravvivenza. Nel XIV e XV secolo i rom si spostano dalla Moldavia e Valacchia alla e ciò era dovuto al fatto che in Transilvania i rom vivevano una più elevata e avevano la possibilità di economici locali, che favorivano una sedentarizzazione spontanea e la nascita di villaggi.
Dal
L’istituzione della schiavitù nei Principati Alla fine dell’800 si sviluppano i movimenti d’indipendenza nazionale e con essi cresce il nazionalismo. In questo frangente storico gli zingari si pongono come attori comprimari rielaborando e rinegoziando la propria posizione nei congronti dei gagé. Un momento chiave di questo processo è la dezrobire cioè l’abolizione della nei Principati danubiani, che comportò conseguenze sia riguardo alla loro nuova distribuzione nei territori che nella struttura interna alla comunità. I rom non erano stati posti in schiavitù da subito e le ipotesi sul tema sono diverse, tra queste l’idea di schiavitù come sopravvivenza della posizione come paria nel sistema indiano delle caste. Altri autori hanno insistito sul ruolo dei i, che avrebbero sui sottoposti per era un processo graduale di trasformazione da una posizione di dipendenza di raggruppamenti considerati stranieri per le abitudini e la lingua- nel e secolo i nobili e il clero cercarono di i dai principi locali in una sorta di . Da una dipendenza fisica si giunse a un d
consderata un bene mobile. Agli zingari venne ma i nobili non avevano il diritto di giudicare e uccidere i loro schiavi. Dal XVII e XVIII secolo i termini rob e tigan divennero equivalenti e si acquisiva lo status di schiavo anche attraverso il matrimonio di una persona libera con uno in schiavitù. La schiavitù provocava fughe ma c’erano anche casi di arruolamenti spontanei di gruppi disperati per l’estrema indigenza e di robi noi per il legame parentale stabilito. Nelle terre romene anche in seguito ai matrimoni, gli zingari non venivano assimilati con il gruppo dominante. C’erano 3 categorie di schiavi zingari, suddivisibili in sottogruppi individuabili rispetto all’occupazione tradizionale. Vi rano i Robi domnesti (del principe), i robi manastiresti (del monastero) e i robi boieresti (nobili locali). i zingari dei nobili godevano di una maggiore autonomia e riuscirono a conservare lo stile di vita nomade. Questi schiavi provenivano da doni, eredità, cessioni, prigionieri di guerra o se si fossero trovati senza proprietario. Tra gli schiavi dei principi troviamo: gli aurari (che cercavano l’oro e potevano avere una vita nomade in cambio di un tributo annuale), i lingurari=artigiani del legno, i laiesi=fabbri, gli ursari e i netoti (gruppi nomadi estremamente selvatici e inassimilabili). Queste attività principali erano completate da strategie economiche complementari in carico alle donne come la mendicità e la produzione di accessori e capi di abbigliamento. Il rischio maggiore per questi schiavi era quello di essere ceduti ai monasteri, qui infatti gli schiavi vivevano i condizioni più dure e una dipendenza molto stretta e le cause della loro cessione erano: per l’espiazione dei peccati, come compenso per le funzioni religione, come compensazione per una condanna da scontare. Gli schiavi dei monasteri erano per lo più servitorio braccianti. I braccianti vivevano in una condizione di sfruttamento atroce e sistematico e le fughe verso la Transilvania erano molte. I vatrasi=servitori erano la categoria considerata maggiormente assimilata e romenizzata, perché avevao uno stile di vita stanziale e una bassa percentuale di individui parlante il romanes. Alle politiche inclusive e assimilatorie i rom rispondevano in diversi modi: innanzitutto nomadizzando nella stagione estiva cercando piazze vantaggiose, poi la posizione sociale inferiore e il diffuso sospeto delle autorità contribuirono alla genesi di villaggi ai margini della città abitate solo da zingari. La struttura interna di alcuni gruppi prevedeva la presenza di uomini di alto rango con funzioni speciali di mediazione per la riscossione dei tributi, questi si chiamavano vataf o bulibasa e il loro compito era raccogliere i tributi e spesso assumeva il ruolo di giudice nella risoluzione delle controversie. L’emancipazione la schiavitù era stata già riconosciuto dalla costituzione del generale Kiseleff del 1815. L’emancipazione ha inizio con la rivoluzione greca innescata dalle Philiki Hetairia del 1821 e con la conclusione del conflitto russoturco che portò, dopo la forma del Trattato di Adrianopoli, all’occupazione militare russa dei Principati che portò all’instaurazione del Regolamento Organico. Con questo regolamento c’è innanzitutto una trasformazione interna(nasce l’Assemblea Generale, il Consiglio dei Ministri, un’apparato militare di stampo nazionale). Le disposizioni del Regolamento che riguardano la minoranza zingara soo: l’interdizione all’allontanamento dai villaggi stabiliti come residenza, l0obbligo al ricorso alla giustizia ordinaria, ai sacramenti di battesimo e matrimonio, il pagamento di tributi, la disposizione di ammende oecuniarie in caso di fuga. Il Regolamento stailisce anche un ruolo piu forte dello stato nella prescrizione degli scambi e della gestione dei robii. In Regolamento non era un tentativo di ammodernamento della condizione dei rom maè il primo esperimento formale e codificato della lotta al nomadismo. Il processo di emancipazione si realizza gradualmetne acompagnato dalle mozioni legislative e dalla nascita e il consilidamento del movimento abolizionista, che nei Principati si orienterà nel più vasto quadro dell’ammodernamento della società (influenzato dalle idee europee), necessario per avvicinarsi a quel sistema.
Gli agenti della modernizzazione proponevano una rivoluzione dall’alto mettendo in discussione i privilegi dei boiari e negli anni 30 ci furono delle iniziative come quello di Teodor Diamant che creò un dispositivo edilizio unitario che favorisse la concentrazione di servizi e mutui rapporti tra gli abitanti (Falansterio di ScaieniPrahova),oppure Ion Campineanu che rinuciò all’eredità dei propri schiavi e gli concesse lo status di uomini liberi. Felix Colson propose invece l’emancipazione introducendo l’idea del risarcimenti statale ai proprietari di schiavi. Negli anni 40 le richieste di emancipazione si moltiplicarono einfatti il poeta Cezar Bolliac incitò con un appello tutti gli intellettuali alla lotta contro questa condizione. Anche Kogalniceanu , il massimo promotore e riformatore, vede l ablizione della schavitù come il punto di partenza per procedere alle successive rivendicazioni politiche, all’indipendenza e all’unità dei principati, e attraverso una descrizione della realtà di Iasi, scatena nel lettore un senso di ingiustizia che deve essere superata. Anche gli intellettuali dall’estero criticano la schiavitù e questa uestione diventa un problema politico eurpeo. In età romantica entrò il tema del buon selvaggio nella letteratura e nel teatro con le opere di Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi e Ion Heliade Radulescu. Alecu Russo impostò invece la propria campagna abolizionista sull’idea che la schiavitù non fosse redditizia per l’economia dei principati e cosi il governo valacco nel 1837 intraprese un processo di colonizzazione dei terreni incolti assegnandoli ai rom che gli dovevano un tributo, sotto il controllo di un direttore generale. Negli anni 40 e 50 il movimento abolizionista venne sostitutio dall’opera di periodici e quotidiani impegnati nella lotta per l’abolizione della schiavitù e questo contribuì alla formazione di un opinione pubblica con un atteggiamento fortemente critico verso le vecche istituzioni. Bisogna ricordare anche le strategie di opposizione dei rom sottoposti a schiavitù che consistevano nella fuga, nella conservazione di un identità distinta e nella preservzione della lingua e della cultura. L iter legislativo che porterà all’emancipazione si sviluppa in 3 decenni: -il Regolamento Organico del 1831/32 con cui i principati si impegnavano a combattere la piaga del nomadismo acquisendo gli schiavi e fissandoli in alcuni alloggi e assimilandoli ai contadini -Nel 1840 in Valacchia l’Assemblea limio il potere dei Monasteri e in Moldavia vennero adottate misure protettive per limitare gli abusi e l Stato si propone come compratore . nel 1844 in Moldavia si procede all’emancipazione degli schiavi . -nel 1855 con il principe Grigore Alexandru Ghica viene sancito l’affrancamento definitivo degli schiavi dei boiari e nel 1856 avviene lo stesso in Valacchia. L’abolizione della schiavitù ebbe un eco soprendente anche nella letteratura degli anni 60 del 19 secolo e Bogdan Petriceicu Hasdeu con l’opera Raxvan si Vidrapuo essere considerato il creatore del dramma storico romeno: Razvan è un rom emancipato che riesce a scalae la gerarchia sociale. All’emancipazione dei rom seguirono delle politiche che miravano alla sedentarizzazione e all’eliminazione del nomadismo ad es con la riforma agraria del 1864 si cerco di trasformare i rom in piccoli proprietari ma queste politiche si rivelarono fallimentari e l’urbanizzazione porterà alla nascita di zone marginali zingare e avrà luogo la seconda migrazione verso l’Europa e l’America, di cui saranno protagonisti i calderai, i sensali, i fabbricatori di setacci e spazzole, gli artigiani, gli ammaestratori di orsi e i minatori. I nuovi magiari della Transilvania La Transilvania era un territorio conteso tra turchi e asburgo. Dal 1663 la dinastia asburgica inizia a imporre il proprio dominio sulla Transilvania (diventerà definitivo dal 1688) e inizierà una serie di riforme per la modernizzazione sociale e istituzionale del paese. I rom dell’impero erano rimasti esclusi dalle trasformazioni economiche e sociali ma la consistenza della comunità in Transilvania la diffidenza per i gruppi nomadi della popolazione autoctona, spinse Maria Teresa e intervenire. Il progetto prevedeva intanto la sedentarizzazione dei gruppi nomadi che avrebbe consentito a un maggiore controllo su questi gruppi e al reclutamento alle armi
degli uomini. Con il decreto del 1761 Maria Teresa dispone la sostituzione della denominazione zingaro con quella di nuovo magiaro e avvia la norma circa gli obblighi militari e di formazione professionale dei giovani, programmando un sistema di accesso ad attività lavorative nei settori manifatturiero e artigianale. Inoltre Maria Teresa proibì l uso degli abiti tradizionali, l uso del romanes ,mette al bando il sistema giuridico tradizionale per la risoluzione delle controversie interne, regolamenta gli scambi matrimoniali. Nel 1782 l atto De Regulatione Zingarorum continua la limitazione di qualsiasi manifestazione culturale specifica dei rom, promuove la cristianizzazione forzata con l obbligo della frequenza delle funzioni religiose principali. In questo modo il sacerdote divenne il referente della buona condotta degli zingari ed era responsabile della loro educazione. La scuola invece doveva risanare i costumi e controllare la moralità dei gruppi. PARTE II POLITICHE ROM: LE RADICI DELLA QUESTIONE NELLA GRANDE ROMANIA I rom nella Grande Romania interbellica Con la fine della 1GM la Romania acquisisce nuovi territori (Bucovina, Bessarabia, Transilvania, Banato, Crisana e Maramures) e con essi la minoranza rom ivi presente. L’85% di questi si attestava nel contesto rurale, il restante 15% viveva nei centri urbani. Nonostnte l’incremento dei gruppi minoritari, emerge una tendenza alla diminuizione della presenza rom rispetto ai censimenti precedenti e questo accadeva per diversi motivi: -l’affrancamento dalla schiavitù porta a migrazioni verso occidente -i rom negavano la propria identità come strategia di difesa da politiche di esclusione -il processo di assimilazione e della politiche di assimilazione messe in atto gli anni precedenti Rispetto all’organizzazione sociale e la struttura interna, il periodo interbellico segna una trasformazione per i rom (che sembra portare ad una loro assimilazione): la comunità appare sempre più come un insieme eterogeneo la lingua romanes viene a poco a poco abbandonata vengono abbandonati alcuni mestieri tipici a causa della concorrenza dei prodotti di fabbricazione industriale, della diffusione della musica radiofonica e della musica moderna e delle campagne promosse dalle società di protezione degli animali. Alcuni rom, grazie alle riforme agrarie che assegnarono proporzioni di terreno, diedero vita a un processo di integrazione nell’economia del villaggio e alla nascita di una classe di piccoli proprietari di etnia rom. Infatti perdendo il monopolio nell’esercizio dei mestieri tradizionali, i rom iniziano a cercare nuovi sbocchi e strategie di sussistenza che spingono molti individui al lavoro agricolo sia come proprietari che come braccianti e lavoratori stagionali. Un'altra attività che si diffonde in questo periodo è quella del commercio ambulante. Nonostante il processo di assimilazione e l’avvio di provvedimenti restrittivi tra il ’33 e il ‘34, alcuni gruppi nomadi continuavano ad opporsi alle politiche descritte conservando lo stile di vita tradizionale, emblematici sono i casi in cui il governo romeno assegnava abitazioni e terreni e le comunità rom continuavano a vivere in degli accampamenti e riservavano gli spazi chiusi agli animali. Negli anni ’30 le associazioni rom cercheranno di inserirsi nel sistema politico dei gagé attraverso dei loro rappresentanti. Questi però non furono rappresentativi di quelle comunità e il compromesso portò a scelte discutibili, campagne demagogiche e a scontri virulenti.
Tra istituzioni e cittadini, tra città e campagna Negli anni ’30 la popolazione non rom iniziò a inviare delle lettere alla polizia, ai dipartimenti sanitari, agli amministratori comunali in cui chiedevano dei provvedimenti (espulsione, evacuazione, sgombero dalle periferie delle città) contro gli zingari perché preoccupati del contagio di malattie , dalla contaminazione culturale dovuta ai comportamenti amorali, alla freqeunza dei furti e del disturbo della quiete pubblica inoltre cercarono di combattere alcuni mestieri esercitati dagli zingari (ursari). Le istituzioni romene cercarono di prendere dei provvedimenti, cercarono di stanzializzare i gruppi e con la riforma agraria assegnarono loro la terra, ma i terreni in questione erano improduttivi e soprattutto lo stile di vita richiesto era troppo distante dalla loro storia culturale (infatti molti continuarono con i propri mestieri artigianali , specie i fabbri, anche perché molto richiesti nelle campagne). Le conseguenze di questi provvedimenti furono: -la seconda grande dispersione del popolo zingaro in Euopa: Serbia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Polonia, paesi baltici, Italia, Francia, Germania..) - all’urbanizzazione che portò alla marginalizzazione sociale dei rom nelle città L’inizio dei pregiudizi verso gli zingari risale al Medioevo, infatti il mestiere del fabbro aveva un valore esoterico e diabolico e associando la metallurgia alle divinità rappresentative del male, i calderai alimentavano l’immaginazione popolare verso lo zingaro stregone. Inoltre gli ursari, gli attori , i musicanti, gli acrobati, le cartomanti ecc, secondo la mentalità del’epoca, tutti uniti dalla mobilità spaziale necessaria all’esrcizio degli stessi, ma questo stile di ita errabondo portava queste persone ad avere rapporti con sconsciuti, ad andare incontro ai pericoli della strada. Queste persone erano considerati degli emarginati, persone che erano state bandite dal proprio villagio e che per questo erano costretti e vagare.
La questione nomade La questione nomade interessò le amministrazioni locali, gli attivisti e le elites. Già nel XVI secolo di moltiplicarono i provvedimenti di espulsione provocando migrazioni forzate e fughe e dando inizio al nomadismo congiunturale. Nella Romania post bellica i rom sono oggetto di politiche di assimilazione e a tentativi di sedentarizzazione. Il tentativo di limitare il nomadismo è legato sia ai risultati insoddisfacenti della riforma agraria dell 800 sia alle rivolte ontadine del 1907. Nel 1921 ci fu un'altra riforma agraria, vennero redistribuiti i lotti dei latifondisti ai contadini, questi appezzamenti però non garantivano una produttività soddisfacente in assenza di credito e infrastrutture. La nuova classe di piccoli proprietati non riusci a trarre benefici da questa nuova condizione e i contadini tornarono ad essere dipendenti dai vecchi proprietari, dovendo pagare anche delle indennità, mentre cresceva la pressione fiscale. La diffusione del sistema della renda (=cessione temporanea del diritto di sfruttamento di un bene, in cambio di un pagamento) incise anche sulle scelte economiche dei rom romeni. In questo periodo i gruppi erano frammentati in altrettanti sottogruppi e questo è emblematico della difficoltà dei rom ad accettare elites in grado di rappresentarli e tutelarne i diritti. L’associazionismo dei rom di Romania Gli avvenimenti del primo dopoguerra e la crisi politica successiva ai trattati condussero alla più grande tragedia dei rom d’Europa che ne ha messo a rischio l’esistenza stessa. Nella prima metà del XX secolo fiorirono movimeni con rivendicazioni politiche in diversi paesi dell’Europa orientale: in Bulgaria ci fu un movimento di protesta per l’abrogazione della legge dell’assemblea nazionale che negava il diritto di voto agli zingari. Negli anni 20 in URSS ci furono dei tentativi di organizzazione politica su base etnico-razziale: prese vita l’Unione Panrussa degli Zingari. Vennero aperte tre scuole con insegnamento in lingua romanes, venne inaugurato il Teatro Romen , venne pubblicato il libro l’Alba dei rom e nel ’27 nacque l’Unione degli Zingari
della Bielorussia (i rom erano stati riconosciuti come minoranza nazionale). Questi esperimenti vacillano tra la volontà di riconoscere i propri diritti come minoranza e una pressione verso la lotta al nomadismo. Il modello di organizzazione politica di base che rom e sinti hanno adottato è dinamica e sempre adattabile al contesto e in contatto con i gagé. Infatti le relazioni con i gage sono necessarie alla sopravvivenza e allo svolgimento dei mestieri e occupazione. Quindi è normale che si siano sviluppati dei tentativi di associazionismo. Negli anni ’30 viene a galla anche un altro problema: infatti la lotta al nomadismo e la conseguente sedentarizzazione si scontra con i disagi degli abitanti della cit...
Similar Free PDFs

I rom di romania
- 14 Pages
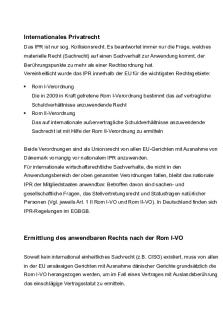
IPR Rom I-VO - IZVR
- 5 Pages

Romania - APUNTES
- 1 Pages

LP ROM
- 6 Pages

TEMA 0. La Romania
- 3 Pages

Leaflet ROM
- 2 Pages

RANGE OF MOTION ROM
- 1 Pages

ROM (Range Of Motion
- 7 Pages

ROM-MMT Handout
- 14 Pages

SATUAN ACARA PENYULUHAN ROM
- 11 Pages
![[P37] - Simulación Memoria ROM](https://pdfedu.com/img/crop/172x258/gm3nz16v73n7.jpg)
[P37] - Simulación Memoria ROM
- 3 Pages

PENGUKURAN ROM EKSTREMITAS SUPERIOR
- 25 Pages

GAL, Memoria ROM, CPU
- 24 Pages

Memorias rom - Caracteristicas
- 1 Pages

Sistemul bugetar in Romania
- 14 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu
