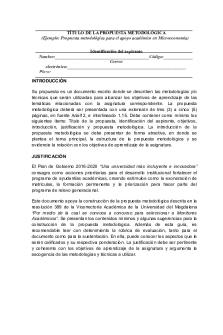Ricerca metodologica PDF

| Title | Ricerca metodologica |
|---|---|
| Author | Francesco Torre |
| Course | Scienze e tecniche psicologiche |
| Institution | Università degli Studi di Torino |
| Pages | 23 |
| File Size | 489 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 83 |
| Total Views | 159 |
Summary
Download Ricerca metodologica PDF
Description
Kuhn usa il termine rivoluzione scientifica per identificare i passaggi da una visione teorica all’altra nelle scienze. Che cosa cambia in una determinata disciplina, a seguito di queste rivoluzioni? Si produce un cambiamento dei problemi da proporre all’indagine scientifica e dei criteri con i quali la professione stabiliva che cosa si sarebbe dovuto considerare come un problema ammissibile o con una soluzione legittima esso. Cosa intende Kuhn per paradigma? Con questo termine egli designa una prospettiva teorica: condivisa e riconosciuta dalla comunità di scienziati di una disciplina; fondata sulle acquisizioni precedenti della disciplina stessa; che opera indirizzando la ricerca in termini sia di individuazione e scelta dei fatti rilevanti da studiare, sia di formulazione di ipotesi entro le quali collocare la spiegazione del fenomeno osservato, sia di approntamento delle tecniche di ricerca empirica necessarie. Senza un paradigma una scienza è priva di orientamenti e di criteri di scelta. Un definisce scienza normale quelle fasi di una disciplina scientifica durante le quali predomina un determinato paradigma, che risulta ampiamente condivisa dalla comunità di scienziati. ! Fino a che punto possiamo parlare di paradigmi nelle scienze sociali? Kuhn fa notare come il paradigma sia un elemento caratterizzante delle scienze mature, in questa prospettiva le scienze sociali in quanto prive di un unico paradigma largamente condiviso dalla comunità scientifica, si troverebbero in una collocazione preparadigmatica, salvo forse per l’economia. Quanto detto per le scienze sociali viale per la sociologia, sembra difficile individuare un paradigma condiviso dalla comunità dei sociologi. Esiste un’altra interpretazione del pensiero di Kuhn, si tratta di una ridefinizione del concetto di paradigma, nel quale restano tutti elementi della definizione originaria salvo uno, il carattere della condivisione da parte della comunità scientifica. In questo modo si apre la possibilità di compresenza, all’interno determinata disciplina, di più paradigmi; e la sociologia diventa, da preparadigmatica, disciplina multiparadigmatica.! Sono due i quadri di riferimento di fondo che hanno storicamente orientato fin dal suo nascere la ricerca sociale: la visione empirista e quella umanista. Si tratta di due visioni organiche e fortemente contrapposte della realtà sociale e dei modi per conoscerla, che hanno generato due blocchi coerenti e fra loro fortemente differenziati di tecniche di ricerca. Per confrontare adeguatamente due paradigmi appena nominati cerchiamo di capire come si rispondono agli interrogativi fondamentali di fronte ai quali si trova la ricerca sociale. Questi possono essere ricondotti a tre dimensioni fondamentali: la realtà sociale esiste? È conoscibile? Come può essere conosciuta?, In altre parole e senza, conoscenza e metodo.! La questione ontologica È la questione del “che cosa”. Ci si interroga cioè se i fenomeni sociali siano “cose in se stesse” oppure “rappresentazioni di cose”. ! La questione epistemologica È la questione del rapporto fra il “chi” e il “che cosa”. Essa riguarda la conoscibilità della realtà sociale e pone l’accento sulla relazione fra studioso e realtà studiata. ! La questione metodologica È la questione del come, riguarda quindi la strumentazione tecnica del processo cognitivo. ! IL POSITIVISMO La sociologia nasce sotto gli auspici del pensiero positivista, i fondatori sono Comte e Spencer. Per Comte l’acquisizione del punto di vista positivista rappresenta in ogni scienza il punto terminale di un itinerario che ha precedentemente attraversato gli stadi teologico e metafisico. Tale itinerario non si realizza simultaneamente in tutte le discipline: esso si è imposto prima nelle scienze della natura inorganica come l’astronomia, la fisica e la chimica; successivamente in quelle della natura organica, come la biologia. Per arrivare infine alla materia più complessa, la società, portando così alla nascita di una nuova scienza, la sociologia. Le scienze della società non sono diverse da quelle della natura quindi si usa il metodo scientifico. ! Il primo tentativo di declinare questa prospettiva teorica globale in termini di ricerca empirica è stato quello di Durkheim, critica Comte per il fatto di aver trattato non di cose, ma di concetti. Durkheim invece fa un effettivo sforzo di tradurre i principi del pensiero positivo in prassi empiriche e la sua prassi empirica è basata sul FATTO SOCIALE. Questi fatti sociali, anche se non sono entità materiali, hanno tuttavia le stesse proprietà delle cose del mondo naturale. E da ciò derivano due conseguenze, da una parte i fatti sociali non sono soggetti alla volontà dell’uomo e
1 di 23
dall’altra, proprio come fenomeni del mondo naturale, funzionano secondo proprie regole e possiedono una struttura deterministica che l’uomo attraverso la ricerca scientifica può scoprire. Il modo di procedere di questa conoscenza nel positivismo è fondamentalmente induttivo, intendendo per induzione il passaggio dal particolare all’universale.! Ontologia: realismo ingenuo. Questa posizione discende tutto quanto abbiamo detto sulla codificazione della realtà sociale e può essere sinteticamente espressa mediante due proposizioni: esiste una realtà sociale oggettiva, esterna all’uomo; questa realtà è conoscibile la sua reale senso. Epistemologia: dualista e oggettivista. Viene affermata la possibilità della conoscenza grazie a due fatti: lo studioso l’ho detto studiato sono considerati entità indipendenti (dualismo); lo studioso può studiare lo getto senza influenzarlo o esserne influenzato (oggettività).! Metodologia: sperimentale e manipolativa. I metodi e le tecniche della ricerca positivista sono prelevati dipeso dalle scienze naturali, nella versione dell’empirismo classico.! NEOPOSITIVISMO E POSTPOSITIVISMO Le teorie vengono a perdere l’impronta cogente delle leggi deterministica e per assumere il connotato della probabilità. Il momento cruciale di questo cambiamento può essere individuato nel passaggio dalla fisica classica a quella quantistica. Le teorie scientifiche non sono più destinate a spiegare i fenomeni sociali mediante schemi di natura logica necessitante, e alla legge deterministica si viene a sostituire la legge probabilistica, che implica elementi di accidentalità, la presenza di disturbi e fluttuazioni. Un elemento importante entrato nel pensiero scientifico nella sua evoluzione dall’iniziale modello positivista È la categoria di falsificabilità, assunta come criterio di validazione empirica di una teoria. Essa stabilisce che il confronto prateria e ritrovato empirico non può avvenire impositivo, mediante la prova che la teoria è confermata dai dati; ma si realizza soltanto in negativo, con la nonna falsificazione della teoria da parte dei dati, mediante cioè la constatazione che i dati non contraddicono l’ipotesi, e che quindi sono connessa semplicemente compatibili. L’idea è che l’uomo non può conoscere, ma solo congetturare. Fermo restando che la realtà esiste indipendentemente dall’attività conoscitiva e dalla capacità percettiva dell’uomo, l’atto del conoscere resta condizionato dalle circostanze sociali e dal quadro teorico nelle quali si colloca. Perde le certezze, ma tuttavia non ripudia il fondamento empirista. Le procedure operative, le modalità di rilevazione dei dati, operazioni di misurazione, le elaborazioni statistiche non subiscono variazioni di fondo.! Ontologia: si presume l’esistenza di una realtà esterna all’uomo, ma è solo imperfettamente conoscibile. ! Epistemologia: Per quanto riguarda la questione della relazione studioso-studiato, il dualismo nel senso di separazione e non interferenza fra le due realtà non è più sostenuto. Nel processo conoscitivo viene valorizzato il modo di procedere della deduzione, attraverso un meccanismo di falsificazione delle ipotesi. Metodologia: le fasi operative della ricerca sono ancora fondamentalmente quelli che furono impostate dal neo positivismo, tuttavia è presente un’apertura i metodi qualitativi.! INTERPRETATIVISMO ! Weber vuole salvare l’oggettività della scienza sociale sia nei termini della sua “avalutatività”, cioè indipendenza da giudizi di valore; sia in quelli della possibilità di arrivare a enunciati aventi un qualche carattere di generalità, pur partendo da un orientamento verso l’individualità. Affermata l’avalutività come prima condizione per l’oggettività delle scienze sociali, restano da definire i temi della seconda condizione, intesa come capacità di arrivare a formazioni dotate di qualche carattere di generalità. Le scienze sociali si distinguono dalle scienze naturali non per l’oggetto ma per il loro orientamento verso l’individualità. Orientamento che soprattutto di metodo e per Weber il metodo è quello del comprendere.! Non intuizione ma interpretazione: intendere lo scopo dell’azione, cogliere le dimensioni di proposito e di intenzionalità dell’agire umano. E anche la componente di immedesimazione della dell’altro, presente nel Verstehen, è finalizzata ad un atto di interpretazione razionale. ! Se il punto di partenza è rappresentato da un individuo e dal senso soggettivo della sua azione, come è possibile arrivare a una conoscenza oggettiva con carattere di generalità? A questo problema risponde la concezione Weber del tipo ideale. I tipi ideali forme di agire sociale che possono venir riscontrate in maniera ricorrente nel modo di comportarsi degli individui umani,
2 di 23
uniformità tipiche di comportamento costituite attraverso un processo astrattivo. Sono ideali nel senso che sono delle costruzioni mentali dell’uomo, svolgono una funzione euristica nel senso che indirizzano la conoscenza. Le uniformità che il ricercatore persegue e individua nella sua interpretazione della realtà sociale, non sono leggi ma connessioni causali o per meglio dire enunciati di possibilità: se accade A, allora il più delle volte si verifica anche B. Alle leggi causali di impianto positivista dotate di generalità e obbligatorietà si contrappongono dunque enunciati, connessioni, segnati dei caratteri della specificità e possibilità.! Ontologia: costruttivismo e relativismo. Il primo perché il mondo conoscibile è quello del significato attribuito dagli individui. Il secondo perché questi significati, variano fra gli individui. Non esiste una realtà sociale universale valida per tutti gli uomini, ma ne esistono molteplici, in quanto molteplici e diverse sono le prospettive con le quali gli uomini vedono interpretare i fatti sociali. ! Epistemologia: non dualismo e oggettività. Tende a scomparire la separazione fra studioso e oggetto dello studio, così come quella fra ontologia ed epistemologia. Nel perseguire il suo obiettivo, che è quello della comprensione del comportamento individuale, la scienza sociale può servirsi di astrazione e generalizzazione: i tipi ideali ed enunciati di possibilità. ! Metodologia: interazione empatia tra studioso e studiato. L’interazione fra studioso e studiato nel corso delle fasi empirica della ricerca non è più valutata negativamente, ma rappresenta l’opposto alla base del processo conoscitivo. Se lo scopo è quello di pervenire alla comprensione del significato attribuito al soggetto la propria azione, le tecniche di ricerca non possono che essere qualitative e soggettive. ! La radicalizzazione di entrambi gli approcci può avere gravi conseguenze. L’estremizzazione dell’approccio positivista pone le premesse per un processo di riduzione progressiva della portata della ricerca, inaridendola sul dato empirico e limitandola a una pura descrizione dello stesso. Mentre all’opposto l’estremo il soggettivismo pone in discussione l’esistenza stessa della scienza sociale, escludendo la possibilità di generalizzazioni sovraindividuali e affermando che la realtà è una pura costruzione cognitiva. Un recente sviluppo del paradigma interpretativo ha posto le basi del cosiddetto post modernismo che si esprime in una sorta di rifiuto della visione tradizionale della scienza, intesa come ordine e razionalità, semplicità e generare disabilità, a favore del paradosso, della contraddizione e della opacità, dell’esaltazione delle differenze. ! RICERCA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (schema p.63)! Le differenze tra la ricerca quantitativa e qualitativa possono essere compresa e meglio se si separano le quattro fasi della ricerca empirica: disegno della ricerca, rilevazione delle informazioni, analisi dei dati, produzione dei risultati.! Impostazione della ricerca 1) rapporto teoria-ricerca: Nel caso della ricerca quantitativa ispirata al paradigma neopositivista, il rapporto è strutturato in fasi logicamente sequenziali, in questo quadro assume importanza l’analisi sistematica della letteratura: è infatti questa fornire le ipotesi teorica da cui partire. Nella ricerca qualitativa che discende dal paradigma interpretativo, la relazione fra teoria e ricerca è aperta, interattiva. Il ricercatore qualitativo spesso respinge volutamente la formazione di teorie prima di cominciare il lavoro sul campo, vedendo in ciò un condizionamento che potrebbe inibire la capacità di comprendere il punto di vista l’ho studiato studiato. Da questa impostazione deriva anche un diverso uso dei concetti. I concetti sono gli elementi costitutivi della teoria teoria, e nello stesso tempo sono essi a permettere alla teoria di essere sottoposta a controllo empirico, mediante la loro operativizzazione, cioè la loro trasformazione in variabili empiricamente osservabili. Nell’approccio neopositivista la chiarificazione dei concetti e la loro operativizzazione in variabili avvengono ancora prima iniziare la ricerca.! 2) Rapporto con l’ambiente: partendo dal presupposto che gli individui si comportano in modo differente quando sanno di essere osservati, l’approccio neopositivista non sembra preoccupato di questo problema, egli non ritiene che il problema della reattività del soggetto possa rappresentare un ostacolo di base. La ricerca qualitativa viceversa pone il requisito dell’approccio naturalistico ovvero un intervento sulla realtà nella quale il ricercatore si astiene da qualsiasi manipolazione, stimolazione o interferenza nei confronti della realtà stessa, la quale viene studiata nel corso del suo naturale svolgersi. I due modi di fare ricerca trovano illustrazione tipica e opposte nelle tecniche dell’esperimento e dell’osservazione partecipante. Nell’esperimento il ricercatore manipola la realtà sociale in maniera completa, arrivando a
3 di 23
costruire una situazione artificiale. All’opposto nell’osservazione partecipante il ricercatore si limita a osservare quello che accade nella realtà sociale, talvolta inibendo anche quel minimo intervento che sarebbe costituito da interrogazioni-interviste ai soggetti osservati. Inoltre Il ricercatore quantitativo assume un punto di vista esterno al soggetto studiato, proprio dell’osservatore scientifico e neutrale e distaccato; egli inoltre studia ciò che lui come ricercatore sembra importante. Il ricercatore qualitativo si colloca invece il più possibile internamente al soggetto d’analisi, nella prospettiva di vedere la realtà sociale con gli occhi dei soggetti studiati. Da questo deriva che nell’impostazione quantitativa individuo studiato viene considerato come passivo; e anche quando non lo si può considerare tale, si fa di tutto per ridurre al minimo la sua interazione con il soggetto studiante. Sul versante qualitativo, viceversa, la concezione della ricerca come interazione implica naturalmente un ruolo attivo del soggetto studiato.! Rilevazione 1) Disegno della ricerca: sono tutte quelle scelte di carattere operativo con le quali si decide come e quando si raccolgono i dati. Nel caso quantitativo il disegno della ricerca è costruita a tavolino prima di iniziare la rilevazione ed è rigidamente strutturato e chiuso. Nella ricerca qualitativa è invece destrutturato, aperto, idoneo a captare l’imprevisto, modellato nel corso della rilevazione.! 2) Rappresentatività: nella ricerca quantitativa il ricercatore preoccupato della generalizzabilità dei risultati, e l’uso del campione statisticamente rappresentativo è l’esito più evidente di questa preoccupazione. L’opposto vale per il ricercatore qualitativo, che mette al primo posto la comprensione, anche a costo di perdersi all’inseguimento di situazioni atipiche e di meccanismi non generalizzabili.! 3) Strumento di rilevazione: nella ricerca quantitativa tutti soggetti ricevono lo stesso trattamento, perché l’obiettivo finale della raccolta di informazione è la matrice dei dati. In quella qualitativa non si ha questo obiettivo di standardizzazione, anzi la disomogeneità delle informazioni è un suo fatto costitutivo dato che il ricercatore assume informazioni diverse secondo i casi, con diverso livello di approfondimento a seconda della convenienza.! 4) Natura dei dati: nella ricerca di orientamento quantitativo essi sono affidabili, precisi, rigorosi, univoci; il termine per definire sinteticamente questi attributi è hard. In quella qualitativa non si pone il problema dell’oggettività dei dati, preoccupandosi invece della loro ricchezza e profondità, vengono definiti soft.! Analisi dei dati 1) Oggetto dell’analisi: nella ricerca quantitativa sono le variabili mentre in quella qualitativa l’individuo. 2) Obiettivo dell’analisi: in quella quantitativa spiegare la variazione (varianza) delle variabili mentre in quella qualitativa comprendere soggetti. 3) Tecniche matematiche statistiche: in quella quantitativa un uso intenso mentre in quella qualitativa non si usano.! Risultati 1) Presentazione dei dati: in quella quantitativa su usano tabelle, in quella qualitativa testi, interviste. ! 2) Generalizzazioni: la tabella narrazione sono due forme di presentazione elementare e in un certo senso frammentata dei risultati. La conclusione della ricerca deve andare oltre la semplice esposizione di distribuzioni di variabili o illustrazioni di casi. L’itinerario che conduce a queste sintesi è chiaro nella ricerca quantitativa, ed è costituito da un processo che porta, attraverso lo studio delle relazioni fra variabili, all’enunciazione di rapporti causali tra le variabili stesse. Nell’approccio qualitativo è più difficile trovare degli itinerari di sintesi delle informazioni suffi cientemente generale condivisi da ricercatori tuttavia indicano nell’individuazione dei tipi la via per raggiungere questi obiettivi di sintesi. ! 3) Portata dei risultati: generalizzabilità (al limite nomotetica) nella ricerca quantitativa e specificità (al limite idiografica) in quella qualitativa. ! LE CINQUE FASI DEL PROCESSO DI RICERCA L’itinerario tipo che un ricercatore sociale segue nella realizzazione di una ricerca consiste in un percorso ciclico che inizia la teoria, attraversa le fasi di raccolta e analisi dei dati, e alla teoria ritorna. La 1 fase è quella della teoria, la 2 è quella delle ipotesi, il passaggio fra la prima la seconda avviene attraverso un processo di deduzione. La teoria è generale mentre l’ipotesi è specifica. La 3 fase è quella della rilevazione empirica, o per meglio dire della raccolta dei dati, e
4 di 23
ad essa si arriva tramite il processo di operativizzazione e cioè di trasformazione delle ipotesi informazioni empiricamente osservabili (classificazione, ordinamento, misurazione e conteggio). Il primo passaggio del processo di traduzione empirica dei concetti consiste nell’applicarli a oggetti concreti, farli diventare cioè proprietà di oggetti, degli specifici oggetti studiati che chiamiamo unità di analisi. Il secondo passaggio per rendere operativo il concetto di proprietà consiste nel darne una definizione operativa, nello stabilire cioè le regole per la sua traduzione in operazioni empiriche. Il terzo passaggio consiste nell’applicazione delle regole sopracitate ai concreti casi studiati: è questa la fase dell’operativizzazione in senso stretto. Chiamiamo variabile la proprietà così operativizzata. ! % % % concetto—>proprietà————— > variabile ! % % % % % % operativizzazione ! Terminata la raccolta del materiale empirico, si passerà alla 4 fase, quella dell’analisi dei dati che sarà preceduta da un intervento di organizzazione dei dati rilevati. La 5 fase è quella della presentazione dei risultati, alla quale si arriva attraverso un processo di interpretazione delle analisi statistiche condotte nella fase precedente. Infine il rice...
Similar Free PDFs

Ricerca metodologica
- 23 Pages

Ricerca
- 5 Pages
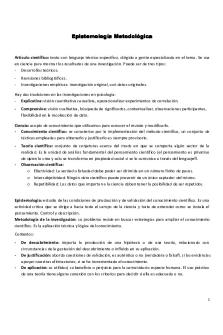
Epistemologia Metodologica I
- 15 Pages

Elaborato ricerca
- 5 Pages

Giappone - ricerca
- 3 Pages

Ricerca Bibliografica
- 11 Pages

Ricerca obiettivo
- 2 Pages

RIcerca Cyberbullismo
- 16 Pages

Riassunti \" La ricerca sociale\"
- 32 Pages

Ricerca-della-felicità
- 3 Pages

duomo milano ricerca
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu