Informatica documentale riassunti capi. 1 PDF

| Title | Informatica documentale riassunti capi. 1 |
|---|---|
| Course | Informatica documentale |
| Institution | Università degli Studi di Macerata |
| Pages | 24 |
| File Size | 254.1 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 60 |
| Total Views | 137 |
Summary
Riassunto completo informatica documentale...
Description
Informatica documentale Cap.1 L’archivio Antonio Romiti come altri autori analizzano la definizione di archivio e in particolare egli arriva a definire l’archivio come un complesso di scritture che legate da un vincolo naturale, sono prodotte da entità pubbliche o private nell’espletamento delle loro attività. Luciana Duranti invece arriva alla conclusione che da tutte le enunciazioni si evincono le stesse caratteristiche dell’archivio, lei lo definisce come l’insieme di documenti redatti e ricevuti da una persona fisica o giuridica nel corso delle sue attività come loro strumento, i documenti redatti sono conservati. Il documento archivistico è un documento prodotto o ricevuto da una persona fisica o giuridica denominata soggetto produttore, nell’ambito di un’attività pratica, amministrativa o giuridica. Ilo documento nasce come necessità per lo svolgimento delle attività e una volta creato entra a far parte dell’archivio per volontà del soggetto produttore che decide di conservarlo. L’archivio può contenere documenti giuridici( una cosa che porta con se la rappresentanza di un fatto o di un atto avente rilevanza giuridica) e di documenti amministrativi( che è la rappresentazione del contenuto di atti delle pubbliche amministrazioni, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa , tra questi anche gli atti di diritto privato).
Vincolo Archivistico Il documento archivistico è legato all’attività giuridica, amministrativa e al suo soggetto produttore, l’insieme delle relazioni logiche che esistono tra i documenti di un archivio prende il nome di vincolo o nesso archivistico, esso è naturale e originario, nasce spontaneamente senza una precisa volontà del soggetto produttore e si forma nel momento in cui vengono prodotti i documenti. Tale vincolo è l’elemento costitutivo del archivio. Antonio Romiti fa una classificazione in 5 tipi di vincoli:
Vincolo archivistico interno, che attiene al nesso esistente nella documentazione realizzata e conservata dall’entità produttrice Vincolo archivistico esterno che si propone nel rapporto tra l’unità produttrice,le unità referenti e l’archivio prodotto Il vincolo istituzionale esterno che può essere individuato nel collegamento che intercorre tra l’entità produttrice dell’archivio e la realtà istituzionale a livello territoria.e nel quale tale soggetto opera Vincolo istituzionale interno che si sviluppa nel rapporto tra l’entità produttrice e le realtà sociali che sono in collegamento con essa
Per riordinamento dell’archivio si fa riferimento al principio secondo il quale si restituisce ai documenti l’ordine originario che il soggetto produttore aveva creato.
Registrazione, classificazione e fascicolazione
Sono fondamentali le operazioni di registrazione(determina l’ingresso dei documenti nella memoria dell’ente produttore e permette di identificarli con un codice univoco, comprensivo del numero e della data di registrazione e di descriverli con un insieme di metadati funzionali allo svolgimento delle successive attività di ricerca, tale operazione viene svolta grazie al sistema di gestione informatica dei documenti), classificazione( è l’operazione logica con la quale si riconduce ciascun docuemtno a una voce precisa del piano di classificazione o titolario di archivio che è un sistema precostituivo di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi delle competenze dell’ente, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti. Il piano di classificazione deve essere ordinato secondo la suddivisione in gruppi omogenei di categorie, classi e sottoclassi)e infine la fascicolazione dei documenti( che consiste nel riunire in un’unica entità i documenti riguardanti uno stesso procedimento amministrativo o riferiti a una stessa attività, affare, un fascicolo può essere diviso in sottofascicoli, il tipo di fascicolo più noto è quello che contiene i documenti di un procedimento amministrativo il quale è costituito da una serie di atti e operazoni collegati in relazione a un unico effetto. Nell’archviio arrivano i fascicoli del personale, che riguardano i dipendenti, quelli d’impresa che riguardano il rapporto tra un ente e uuna persona giuridica).
Le tre età del’archivio L’archivio possiede tre fasi distinte, la prima è quella in cu l’archivio si forma con la documentazione delle attività( archivio corrente); la seconda fase corrisponde all’archivio di deposito del quale fa parte la documentazione relativa ad affari esauriti ma non ancora destinata alla conservazione permanete e alla consultazione da parte del pubblico. In questo caso l’archivio non più necessario viene spostato in una nuova sede. L’archivio storico è definito come il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati alla conservazione permanente per garantire in forma adeguata la consultazione al pubblico, fino a quando i documenti restano nell’archivio essi sono soggetti alla consultazione da parte di soggetti aventi un interesse legittimo. L’archivio dunque è un’unità inscindibile, anche la commissione cibrario nel 1870 ha rifiutato la distinzione tra archivi amministrativi e storici, ma tale volontà di non fare distinzioni viene ripresa anche d Giorgio Cencetti nel 1939.
Selezione o scarto archivistico Nella definizione di archivio storico si fa riferimento all’operazione di scarto archivistico che deve precedere il passaggio dei documenti dallo stato di disponibilità per eventuali esigenze pratiche del soggetto produttore allo stato di bene consultabile oppure se il documento viene considerato inutile, tuttavia non ci sono criteri per stabilire se un documento è considerato inutile o rilevante. Inoltre nella commissione dello stato vi sono coloro i quali sono addetti alla vigilanza sulla corretta tenuta degli archivi, coloro che collaborano alla conservazione e gestione degli archivi. Le proposte di scarto degli archivi invece sono a carico del responsabile degli archivi di deposito. Si parla di scarto quando vi è quell’atto secondo il quale viene intaccato il vincolo archivistico in quanto la distruzione di alcuni documenti seppur ritenuti inutili spezza quella catena di relazioni naturali che esistono tra gli atti formati da un ente durante lo svolgimento delle sue attività. Antonio romiti sostiene che con il termine selezione bisognerebbe far riferimento al
processo secondo cui vengono determinate le sorti della documentazione. Le operazioni di scarto sono necessari e pertanto è necessario anche stabilire dei piani di conservazione per capire il tempo minimo e massimo di conservazione dei documenti. Paola Carucci definisce massimario di scarto lo strumento che consente di coordinare lo scarto e indica secondo una classificazione dei documenti quali tenere e quali no
Accesso e fruizione L’archivio è per definizione la memoria dell’ente e la documentazione conservata deve essere ordinata. L’accesso al patrimonio documentario conservato è stato assicurato attraverso la predisposizione dei mezzi di corredo sia nella fase di archivio sia in quella di formazione a opera del soggetto produttore(di questo gruppo fanno parte i mezzi di corredo coevi costituiti dal piano di classificazione, piano di conservazione dell’archivio, registro di protocollo, rubriche) , sia in quella successiva della conservazione permanente( in questo gruppo rientrano gli strumenti di ricerca elaborati a posteriori che comprendono gli elenchi di versamento o di deposito che possono essere più o meno dettagliati). L’inventario è lo strumento fondamentale per eseguire le ricerche in archivio, esso è costituito da un’introduzione generale comprendente un cenno storico e tutte le informazioni dell’archivio. Stefano vitali rileva che se l’archivio nel proprio ordinamento originario, riflette l’ente produttore l’inventario non può che essere una rappresentazione fedele di quell’ordinamento.
Standard di derivazione archivistica per permettere lo sviluppo di strumenti che permettano la diffusione del patrimonio culturale anche in vie telematiche, per conseguire questo risultato il consiglio internazionale degli archivi (ICA) ha promosso l’elaborazione di sistemi di descrizione archivistica basati su standard condivisi dalla comunità professionale, tali standard sono:
ISAD nel 1990 l’ICA(International council on archives isitui una commissione con l’intento di elaborare uno standard che facilitasse l’accesso e lo scambio di informazioni sul patrimonio archivistico, nacque cosi la prima edizione di standard internazionale per la descrizione di un fondo archivistico generico, denominato ISAD. Questo standard si applica alla documentazione archivistica riordinata e destinata alla conservazione permanente, di fondo archivistico come insieme di parti articolate a più livelli gerarchici, al quale è possibile associare una descrizione a più livelli. ISAAR che contiene le regole per elaborare record d’autorità archivistici, queste regole sono organizzate in 3 aree informative per un totale di 10 elementi descrittivi, essere servono anche per monitorare il rapporto tra soggetti produttori e la documentazioni da essi prodotta Lo standard ISDIAH è stato rilasciato nel 2008 dall’ICA come standard di descrizione dei soggetti conservatori, gli elementi dell’ISDIAH sono organizzati in 6 aree, ma solo 3 sono obbligatorie tra cui identifier, authorised forms of name, location and addresses element Norme italiane per l’elaborazione dei recordi di autorità archivistica di enti, persone che si chiama NIERA, esse sono le norme elaborate nell’ambito del sistema archivistico nazionale(SAN) con l’obiettivo di creare uno standard descrittivo italiano derivato da ISAAR. EAD che è lo standard elaborato nel 1998 dalla society of american archivists, in collaborazione con la library of congress con l’obiettivo di fornire alle istituzioni archivistiche un formato di
interscambio delle descrizioni attraverso ilo web. Tale standard utilizza la comunicazione fisica dei dati EAC che è nato nel 2001 come formato standard basato sul linguaggio di marcatura XML, per rendere le descrizioni dei soggetti produttori di archivi accessibili attraverso internet. Esso assicura la compatibilità con lo standard ISAAR
L’impiego diffuso degli standard ha portato alla realizzazione del sistema informativo unificato della soprintendenze italiane e ha portato alla realizzazione del sistema guida generale degli archivi di stato italiani. Questi sistemi sono stati integrati nel portale del sistema archivistico nazionale nato nel 2001 e gestito dall’istituto centrale per gli archivi, il portale si autodefinisce aggregatore nazionale di risorse archivistiche .
Capitolo 2 IL DOCUMENTO INFORMATICA Le azioni previste dall’agenda digitale europea sono basate sul presupposto che è possibile utilizzare dei documenti informatici al posto di quelli cartacei rispettando dei criteri prestabiliti:
Stabilità, un documento è una rappresentazione statica di un atto o fatto accaduto e il documento non va modificato dopo che è stato creato dall’autore. Nel documento informatico la stabilità è rappresentata dall’immodificabilità della sequenza binaria Autenticità, un documento è autentico se può provare di essere ciò che dichiara di essere senza aver subito modifiche,essere stato prodotto o inviato dal soggetto che apppare con il prodotto o inviato al momento dichiarato. Il requisito dell’autenticità attiene alla capacità di ricondurre un documento informatico al suo autore, il requisito della stabilità e include il requisito di creare le firme elettroniche. Accessibilità che è la capacità di ricercare e acquisire un documento informatico archiviato nel rispetto delle regole della privacy. Per soddisfarle occorre agire a livello organizzativo, procedurale, archviistico e tecnologico, infatti non è necessario solo applicare il nome del file senza però altri attributi ma è necessario identificare unicamente e distintamente il nome de file in modo da trovarlo facilmente. Intelligibilità e possibilità di utilizzo, un documento viene prodotto per avere una memoria di determinati atti percio deve essere leggibile da chiunque ne abbia bisogno. Esso deve dunque possedere la caratteristica di riproducibilità, trasferibilità e intelligibilità Localizzazione e datazione, il luogo e la data sono informazioni che devono essere indicate nel documento per permetterne la riferibilità a un periodo specifico
FORMATO ELETTRONICO Un documento informatico è una sequenza memorizzata su uno più dispositivi media, però la sua rappresentazione necessita la disponibilità di un apparato hardware o software in grado di accedere
all’unità di memorizzazione. Per la produzione di documenti informatici si privilegiano formati elettronici che abbiano caratteristiche specifiche quali:
Indipendenza dalle piattaforme tecnologiche per non avere vincoli di natura informatica o economica Apertura e standardizzazione intese come disponibilità delle specifiche tecniche in forma accessibile Non proprietario cioè non appartenente a un solo fornitore che ne detiene i diritti d’uso Robustezza che indica la probabilità, in caso di corruzione di un file, di recuperarlo Accuratezza(capacità di rappresentare un contenuto informatico digitale con una qualità adeguata) e usabilità(fa riferimento alla facilità di accesso, trasferimento e gestione dei file) Stabilità intesa come compatibilità con l versioni precedenti e quelle future Sicurezza come protezione da virus Inammissibilità di macroistruzioni(istruzioni che il software esegue automaticamente al momento della rappresentazione del documento, visualizzando i risultati come se fossero stati digitati direttamente dall’autore) all’interno del file Capacità di memorizzare nel file strumenti e dettagli tecnici necessari per la rappresentazione del contenuto informativo. I differenti tipi di documenti sono: PDF, formato sviluppato da adobe systems e certificato ISO, realizza la rappresentazione dei documenti informatici in modo affidabile e indipendente dalle piattaforme tecnologiche. Il documento pdf non può essere firmato in modalità narrativa e in conformità alle specifiche ETSI PadES PDF/A versione limitata del pdf certficato standard ISO, è stato progettato da adobe systems con l’obiettivo di soddisfare i requisiti della conservazione a lungo termine TIFF è utilizzato per la memorizzazione delle immagini ODF è il formato standard ISO gestito dall’OASIS, che è un organismo di certificazione riconosciuto ed indipendente. OOXML basato sul linguaggio XML XML è un formato di testo flessibile derivato da SGML, che presenta la caratteristica di essere sia human che machine TXT è un formato di testo pure RFC standard di riferimento per i messaggi di posta elettronica
FIRMA ELETTRONICA Essa è definita nell’art 3 punto 10 del regolamento EIDAS ed è intesa come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. Secondo l’art 25 del regolamento a una firma elettronica non possono essere negatici gi effetti giuridici, dunque non può essere discriminata rispetto ai documenti cartacei. L’italia ha modificato l’art 21 del CAD dichiarando che il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito di forma scritta e sul piano probatorio è valutabile in giudizio, per poter attribuire una valenza giuridica a un documento con firma elettronica è necessario conservare e archiviare ai bit che rappresentano il contenuto digitale anche le informazioni che qualifica il processo di firma in termini di qualità, sicurezza e integrità. La creazione di una firma elettronica presuppone che il firmatario possieda dati unici e che sia possibile dimostrare che alla data della firma tali mezzi erano in suoi possess , la firma può essere generata anche attraverso un processo di identificazione elettronica . un esempio di firma
elettronica sono l’user e password( di almeno 8 caratteri) per accedere a un sito, si fa la registrazione di un soggetto al sito che acquisisce i suoi dati di identificazione, li autentica direttamente e registra le informazioni che permettono di attribuirgli la paternità dell’atto prodotto. L’OTP è invece one time password. La forma più sicura di firma elettronica viene prodotta attraverso l’identità digitale rilasciata nell’ambito dello SPID, oppure la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi e la tessera sanitaria elettronica.* ai sensi del regolamento EIDAS per identificazione elettronica si intende il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica, mentre per autentificazione si intende il processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, i mezzi di identificazione elettronica sono definiti dal regolamento EIDAS come unità di materiali e immateriali contenenti dati di identificazione personale e utilizzate nei processi di autenticazione per l’accesso ai servizi online. Per regime di identificazione elettronica si intende un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche I processi di identificazione informatica e autenticazione eseguiti con l’uso combinato delle credenziali di accesso e di un dispositivo OTP, che genera automaticamente un codice utilizzabile solo per una transazione. Per effettuare un pagamento elettronico, dopo l’identificazione del correntista con le sue credenziali il sistema obbliga a inserire un codice che può essere generato solo dall’OTP del cliente.
SISTEMA PUBBLICO DI GESTIONE DELL’IDENTITà DIGITALE(SPID) A seguito del regolamento EIDAS ch emira alla creazione d i un’unione europea digitale disciplinando l’interazioni elettroniche che coinvolgono cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e favrendo l’accettazione da parte di ogni singolo stato membro , l’italia ha istituito il sistema pubblico di gestione dell’identità digitale(SPID) che è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati i quali identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l’accesso in rete. Ad oggi sono gestori dell’identità digitale società come Poste Italiane S.p.A. mentre le università, le regioni e istituti nazionali hanno già aderito allo SPid rendendo i loro sistemi online accessibili tramjite identità digitale europea. L’art 3 del codice dell’amministrazione digitale riconosce a tutti i cittadini ealle imprese il diritto di assegnazione di un’identità digitale con la quale accedere e utilizzare i servizi pubblici erogati i n rete, mentre il regolamento del 2014 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni8 ad integrare i loro sistemi informativi con la piattaforma SPID entro il 31 dicembre 2017. Lo spid si articola su tre livelli:
Il primo livello considerato basso in cui i l gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di identificazione informatica e autentificazione a un fattore( password). Questo livello è applicabile nei casi in cui il danno causato da un utilizzo inproprio dell’identità digitale abbia un basso impatto per le attività del cittadino, del’impresa Secondo livello significativo, in cui il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di identificazione informatica e autenticazione a due fattori, le cui chiavi private sono custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti dell’art 3 del regolamento eidas. Questo livello è adatto a tutti i servizi per i quali un utilizzo improprio dell’identità digitale può provocare un danno consistente . Terzo livello definito elevato in cui il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di identificazione informatica e autentificazione a due fattori, basati su certificati digitali, le cui chiavi private sono custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti d cui all’allegato 3 del regolamento eidas. Questo è il livello attribuibile a quei servizi che p...
Similar Free PDFs

Informatica Documentale
- 33 Pages

Informatica-documentale-Slides
- 77 Pages

Informatica 1 actividad 1
- 8 Pages

CAPI DI Vestiario- Materiali
- 2 Pages

Tr2 informatica aplicada 1
- 7 Pages

Informatica 1 - appunti
- 4 Pages
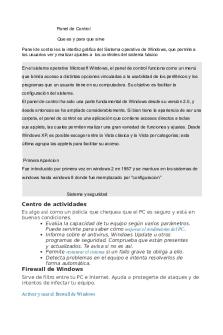
Informatica
- 8 Pages

Trabajo Informatica Basic 1
- 9 Pages

Actividad numero 1 Informatica
- 6 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






