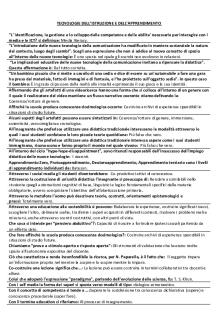Tecnologie radicali - Greenfield PDF

| Title | Tecnologie radicali - Greenfield |
|---|---|
| Author | Eleonora Marconi |
| Course | Psicologia e comunicazione |
| Institution | Sapienza - Università di Roma |
| Pages | 41 |
| File Size | 646.5 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 359 |
| Total Views | 610 |
Summary
1 Capitolo 2: DELLE COSE A Copenaghen, un autobus che viaggia con due minuti di ritardo trasmette la sua posizione e il numero di passeggeri alla rete semaforica municipale, che allunga la durata del semaforo verde in ciascuno dei tre incroci successivi in modo che recuperi un di tempo. A Davao, nel...
Description
1 Capitolo 2: L’INTERNET DELLE COSE A Copenaghen, un autobus che viaggia con due minuti di ritardo trasmette la sua posizione e il numero di passeggeri alla rete semaforica municipale, che allunga la durata del semaforo verde in ciascuno dei tre incroci successivi in modo che l’autista recuperi un po' di tempo. A Davao, nelle Filippine, una webcam non protetta inquadra il magazzino di un fast food, permettendo a chiunque sia dotato del suo indirizzo di tenere sott’occhio tutto ciò che entra o esce. A San Francisco, un giovane ingegnere spera di « ottimizzare » la sua vita grazie a dei sensori che monitorano la sua frequenza cardiaca, la respirazione e il ciclo del sonno. Ciò che accomuna situazioni cosi diverse tra loro è una concezione dei dispositivi in connessione che oggi ci viene venduta come « internet delle cose », e in cui una trama di percezioni in rete avviluppa ogni spazio, ogni luogo, ogni cosa e ogni corpo presenti su questa Terra. L’esperto di tecnologie Mike Kuniavsky la descrive come un modo di esistenza in cui « la calcolabilità e la comunicazione dei dati sono incorporati e distribuiti all’interno del nostro ambiente nella sua interezza ». E’ preferibile definirla per ciò che essa è: la colonizzazione della vita quotidiana da pare dei processi di elaborazione delle informazioni. Come lo smartphone, l’internet delle cose non è una singola tecnologia, quanto piuttosto un caotico assemblaggio di protocolli, regimi di percezione, capacità e desideri. Tutto ciò che collega i diversi dispositivi, i servizi, i fornitori e le performance implicate in tale assemblaggio è il tentativo di rendere sensibili per la rete, e disponibili per l’analisi e l’elaborazione, le situazioni della vita quotidiana. Il tentativo di rendere il corpo uno strumento, di monitorare il suo comportamento e di ricavare da queste forme di indagini delle conoscenze finalizzare all’azione è noto come quantified self; la volontà di rendere visibile in rete lo spazio domestico si chiama smart home e quando questo sforzo si estende su scala municipale prende il nome di smart city. Ognuna di queste dimensioni mette in luce un particolare aspetto di quella sfida che l’internet delle cose costituisce per noi, e ognuna di esse ha qualcosa di specifico da insegnarci. Nella sua dimensione più intima, l’internet delle cose si manifesta in forma di sensori biometrici indossabili: dispositivi che raccolgono le varie tracce del nostro essere nel mondo per farle osservare e analizzare dalla rete. Il più semplice di questi è poco più di un pedometro digitale connesso in rete. Usando lo stesso genere di microaccelerometro elettromeccanico che troviamo nello smartphone, questo tipo di contapassi riesce a misurare la distanza complessiva percorsa e a fornire una stima delle calorie bruciate nel corso dell’attività. I modelli più sofisticati misurano la frequenza cardiaca, la respirazione, la temperatura cutanea e persino il livello di traspirazione dati biologici grezzi dai quali possono essere dedotti stati spico-emotivi di ordine più complesso e più difficili da definire, come lo stress, la noia o l’eccitazione. Se i dispositivi biometrici indossabili sono finalizzati a una rigorosa padronanza di sé, la colonizzazione dell’ambiente domestico da parte di analoghi prodotti o servizi in rete è destinata a fornire un altro tipo di esperienza: la comodità. L’obiettivo manifesto della smart home è di mettere il più possibile in cortocircuito il processo di riflessione che si situa tra il riconoscimento di un proprio desiderio e la sua realizzazione attraverso il mercato. L’apoteosi di questa tendenza è un dispositivo attualmente commercializzato da Amazon: il Dash Button. Molti dei ritrovati dell’internet delle cose non sono altro che oggetti più o meno convenzionali a cui è stata aggiunta una connettività in rete, dopodiché i progettisti si sono sforzati
2 di immaginare un uso possibile per quella connettività. Il Dash Button è l’esatto opposto: un oggetto che non avrebbe mai fatto la sua apparizione nel mondo senza internet. Amazon definisce il Dash Botton come un dispositivo connesso tramite Wi-Fi che permette di acquistare i prodotti preferiti premendo un semplice pulsante. Ogni Dash Botton è associato a un prodotto a scelta, selezionato durante il processo di configurazione. Quando il prodotto sta per terminare, basta premere il Dash Botton per essere sicuro di non rimanere senza. Si tratta quindi di un dispositivo elettronico elaborato, collegato a un marchio specifico e dedicato a una funzione unica. I vantaggi si distribuiscono in maniera diseguale: si potrà pure acquistare il detersivo in tempo ma Amazon ottiene molto di più. Amazon acquisisce dati sulla temporalità e sulla localizzazione dei bisogni, sulla frequenza e intensità. Questi dati non sono privi di valore, in quanto rappresentano un’evidente risorsa, un asset al quale si ricorrerà secondo i rispettivi termini e condizioni, non esclusa la possibilità di utilizzarli per sviluppare modelli comportamentali in grado di cartografare il territorio dei nostri desideri, in modo da sfruttarli ancor più efficacemente in futuro. Una volta di più, l’obiettivo di un dispositivo come il Dash Button è di consentire all’utente di effettuare transazioni commerciali eliminando il più possibile la mediazione del pensiero cosciente, ivi compresi i brevi momenti di riflessione richiesti dal gesto di digitazione di un ordine attraverso il touchscreen di un telefono o di un tablet. E’ possibile vedere nella recente spinta industriale verso la smart home l’ultima versione di un tentativo coerente e consapevole di trasformare gli spazi intimi e privati in luoghi caratterizzati da incessanti upgrade tecnologici, servizi in abbonamento e perpetui rifornimenti di beni di consumo. Questa strategia si è incentrata sui cosiddetti altoparlanti intelligenti, gli smart speakers. Si tratta di prodotti come Amazon Echo e Google Home, che dovrebbero funzionare come hub digitali per la casa. La loro forma non riflette il loro scopo o la loro modalità di funzionamento: Amazon Echo è un cilindro e il suo Echo Dot non è altro che lo stesso cilindro ridotto a disco, mentre Google Home si presenta come un oggetto ovoidale e smussato. In ogni caso, la forma di questi altoparlanti non è molto importante, visto che la loro funzione principale è quella di operare come portale e presenza materiale di un servizio, nello specifico un « assistente virtuale » griffato. Google, Microsoft, Amazon e Apple offrono ciascuno un proprio assistente con tecnologie di riconoscimento vocale, ma altri concorrenti e nuovi operatori commerciali si saranno affacciati sul mercato quando questo libro sarà stato pubblicato. Generalmente, questi assistenti hanno nomi, voci e caratteri femminili, il che si basa presumibilmente su una ricerca condotta in Nord America secondo la quale la maggior parte degli utenti, indipendentemente dal genere, preferisce interagire con donne. L’assistente di Apple si chiama Siri, quella di Amazon Alexa, Microsoft decide di chiamare Cortana il suo agente. Almeno per il momento, Google ha deciso di non dare alcuna identità personale e di genere al proprio assistente, nemmeno sotto la forma di un nome: si chiama semplicemente Google. Questi assistenti obbediscono agli ordini in quanto hub di controllo della casa in rete. L’assistente fornisce un front-end accessibile e facile da usare rispetto a un insieme di comandi che altrimenti potrebbero essere disseminati in diversi punti dell’abitazione, includendo al proprio interno i comandi dell’illuminazione e dei dispositivi di intrattenimento, le funzionalità di sicurezza e i sistemi di climatizzazione; grazie a una serie di Api può coinvolgere servizi commerciali offerti da terzi. Di primo occhio, questi dispositivi sembrerebbero innocui. Attendono pazientemente alla periferia della nostra attenzione e, senza avanzare mai pretese esplicite, si rivolgono a noi nel modo più naturale possibile, con un tono sempre colloquiale. I dettagli del loro concreto funzionamento rivelano però quale sia il loro senso reale. L’assistente di Google funziona cosi: se gli si dice di
3 avere voglia di qualcosa di italiano, l’assistente risponderà suggerendo una serie di ristoranti italiani in cui prenotare un tavolo usando, per esempio, l’applicazione OpenTable. Questa scena è istruttiva perché illustra perfettamente il principio secondo il quale le scelte che gli assistenti ci offrono, vengono preselezionate secondo determinati presupposti di normalità, adeguatezza e valore. Gli assistenti virtuali sono costantemente all’ascolto di tutto ciò che viene detto in loro presenza. Trattandosi di interfacce ad attivazione vocale, devono stare continuamente all’erta per cogliere la wake-up word che può farli entrare in azione. La logica in opera è quella dell’appropriazione preventiva, vale a dire l’idea che per un fornitore di servizi sia bene impossessarsi di tutti i dati possibili e immaginabili, dal momento che non si può mai sapere quale vare potranno avere in futuro. Esattamente come il Dash Button, i prodotti connessi alla rete e destinati ai consumatori enfatizzano le proprie caratteristiche plug-and-play: cosi semplici da usare che si può portare a casa il prodotto, accenderlo per la prima volta e lasciare che si auto-configuri. Investendo su questo aspetto, i produttori hanno giustamente capito che la maggior parte delle persone non ha né tempo, né le conoscenze, né la propensione a gestire i dettagli della connessione del dispositivo a internet. Ma la spinta vero la comodità cancella spesso gli aspetti critici, e una delle questioni che viene troppo frequentemente rimossa all’interno della logica plug-and-play è quella della sicurezza in rete. E’ il caso, sopratutto, delle videocamere connesse in rete. Una webcam economica e plug-andplay, una di quelle che si producono con buoni profitti a Shenzhen e che si possono comprare per circa 10$, trasmette su internet esattamente come un modello di livello industriale che costa 10 o 15 volte tanto, ma, a differenza di questo, non possiede nemmeno i più rudimentali mezzi di controllo dei propri feed. Se si usa un motore di ricerca specializzato nell’internet delle cose come Shodan, infatti, si possono trovare centinaia di migliaia di dispositivi in tutto il mondo che trasmettono in modo non protetto. Questi feed possono essere trovati da chiunque li cerchi, e rendono visibili scene che probabilmente le persone vorrebbero trattare con maggior discrezione: coltivazioni illegali di marijuana, alloggi di basi militari, file di bambini nelle culle mentre dormono. Anche le videocamere che offrono maggiori garanzie tecniche di sicurezza sono spesso rese vulnerabili da quell’errore umano che consiste nel non cambiare la password predefinita dai dispositivi: un motore di ricerca russo è in grado di fornire i link di circa 73000 videocamere distribuite in giro per il mondo, in luoghi aperti o chiusi. Questo lassismo è diffuso in tutto l’universo dell’internet delle cose, e riguarda, oltre alle webcam, ogni tipo di oggetto che può avere una connessione alla rete. Qualsiasi dispositivo non protetto non espone solo alla rete globale i propri comandi: può anche essere utilizzato come punto di accesso per l’interno network locale e per qualsiasi altro dispositivo connesso, e offrire agli intrusi la possibilità di installare delle backdoor, di intercettare il traffico web, o di lanciare degli attacchi DoS (denial of service). Il prezzo della connessione è la vulnerabilità e il caso dell’internet delle cose non è diverso: ogni singolo dispositivo connesso in rete offre un’apertura, un accesso, ciò che la security community definisce un « vettore di attacco ». Queste migliaia di miliardi di vulnerabilità impossibili da cartografare evocano lo spettro di sciami di macchine zombie che marciano per « spammare » l’infrastruttura di internet e inondarla di traffico spurio, fino al punto da non poter più distinguere i
4 messaggi autentici. Si chiama distributed denial of service attack, o DDoS, e pur non essendo sofisticato, i suoi effetti possono essere devastanti. Tutta una serie di dispositivi in rete è stata dispiegata nello spazio pubblico per raccogliere informazioni: videocamere, celle di carico o altri dispositivi in grado di percepire la presenza di pedoni e veicoli, microfoni automatici per la rilevazione degli spari e altre grigie di sorveglianza a spettro audio, annunci pubblicitari e distributori automatici dotati di sensori biometrici, nonché i sistemi di microposizionamento noti come beacons, che interagiscono direttamente con gli smartphone. Il pedone medio è solo vagamente consapevole della presenza o dell’operatività di questi sensori. Visti dal marciapiede, essi appaiono come una profusione di involucri misteriosi e poco evidenti, appiccicati ai lampioni o alle facciate degli stabili. Con l’eccezione delle telecamere a circuito chiuso, questi dispositivi non hanno forme particolarmente appariscenti. Alcuni sono direttamente integrati nei muri, altri sono sigillati sotto il manto stradale e solo l’eventuale segno lucido della giuntura sulla pavimentazione o le scritte fluorescenti lasciate dal personale di servizio ne possono tradire la presenza. Molto spesso, non sono altro che mute scatole di policarbonato scuro dalla forma oblunga, attaccate come lamprede alla facciata di un edificio, difficili da notare. Tutti questi oggetti hanno un unico scopo: registrare tutto ciò che accade nello spazio pubblico e metterlo a disposizione della rete. Vista la crescente importanza del meteo nelle nostre vite, molti sensori urbani hanno lo scopo di raccogliere informazioni meteorologiche, misurando la temperatura, il livello di precipitazioni e la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento, nonché diversi indici della qualità dell’aria, come il livello di ozono o la quantità di pollini e polveri sottili. La messa in opera di un gran numero di questi sensori ha a che fare con le esigenze quotidiane dell’amministrazione municipale, come nel caso dei misuratori della fluidità media della circolazione o della velocità dei singoli veicoli; dei rilevatori dell’umidità e del PH del terreno che aggiornano le squadre di manutenzione circa la salute degli alberi e delle piante. Sistemi più recenti hanno l’obiettivo di raccogliere e aggregare configurazioni di fatti che possano essere utilizzate per la commercializzazione degli spazi urbani prospicienti le attività commerciali: la quantità di persone presenti a seconda degli orari, a che cosa sono interessate, e, dove possibile, le categorie demografiche o psicografiche di appartenenza. Un esempio di questo tipo di sistemi è Placemeter, un open urban intelligence platform che offri ai propri utenti la possibilità di vedere in tempo reale quante persone affollano un determinato luogo. Un numero sempre maggiore di sensori vengono installati nelle strade sotto l’impulso della citizen science e del desiderio di avere più dati rispetto alle dichiarazioni ufficiali di un governo sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento acustico o elettromagnetico. L’immagine che ne risulta è quella di un tessuto urbano che rigurgita informazioni senza soste e in cui ogni banale, singolo metro quadro di marciapiede produce una tale quantità di dati su chi vi passa e sulle attività che vi si svolgono. E’ possibile ritrovare la migliore e più esplicita formulazione di questa ideologia nella definizione di smart city fornita da quella multinazionale della tecnologia che è Siemens: « Tra qualche decina d’anni, le città saranno dotate di innumerevoli sistemi informatici autonomi e intelligenti in grado di conoscere perfettamente le abitudini e il consumo energetico di ogni utente e di fornire servizi ottimali. L’obiettivo di questo modello di città è quello di ottimizzare la gestione e il controllo delle risorse per mezzo di sistemi informatici autonomi ».
5 Attualmente, l’internet delle cose è la più tangibile e concreta manifestazione del nostro desiderio di misurare e controllare il mondo. E’ un dispositivo di cattura e in quanto tale non è altro che un mezzo al servizio di uno scopo. Lo scopo rimane la quantificazione dei processi della vita a ogni livello, la loro trasformazione in dati digitalizzati da analizzare, l’elaborazione di una simulazione proiettiva e l’addestramento di algoritmi di apprendimento automatico. L’emozione prevalente nell’internet delle cose è una malinconia che la attraversa a ondate. Il suo presupposto è un contesto fatto di attenzione continua ma frammentata, di sovraccarichi di coscienza, e di distanze tra persone temprate a suon di sensori, Api e script. La situazione più inquietante da affrontare causata da questo tipo di tecnologie è il problema di chi entra in possesso dei dati che si hanno disseminato nell’internet delle cose e del loro uso possibile.
1 Capitolo 3: REALTA’ AUMENTATA L’8 luglio 2016, di mattina presto, una giovane donna di nome Shayla Wiggins s’infila un paio di sandali, lascia la casa di sua madre, nel B & K Mobile Home Park di Riverton, in Wyoming, e cammina per un paio di isolati a sud, verso il punto in cui la State Highway 789 attraversa il Wind River. Giunge a una recinzione, la scavalca e si dirige verso la riva del fiume a est del ponte dell’autostrada. A questo punto nota qualcosa che affiora sulla superficie dell’acqua, a non più di dieci piedi dalla riva. Quello che ha visto si rivelerà essere il corpo di un uomo, in seguito identificato dallo sceriffo della contea di Fremont come Jeffrey Day, 28 anni, della contea di Arapahoe. E’ cosi che Shayla Wiggins è diventata la prima persona nella storia dell’umanità a scoprire un cadavere mentre si trovava in due luoghi contemporaneamente. A spingerla a uscire di casa, quel venerdì mattina, era stato Pokemon Go, un gioco di augmented reality (AR) - la realtà aumentata - lanciato due giorni prima con un successo senza precedenti. Come tutte le applicazioni AR, Pokemon Go fornisce ai propri utenti una serie di informazioni sul mondo e sugli oggetti che lo popolano, e le sovrappone al campo visivo in una rappresentazione grafica specifica e adattata al luogo; mentre, però, altre applicazioni utilizzano questa sovrapposizione per dare informazioni pratiche quali indicazioni stradali, notizie storiche ecc, Pokemon Go offre ai giocatori una realtà alternativa abitata da mostri di vario tipo. Per progredire nel gioco occorre catturare questi mostri, e per farlo bisogna trovarsi fisicamente nel luogo in cui la mappa del gioco ne segnala la presenza. L’enorme popolarità del gioco ha portato masse di persone in strada, disarticolando tutti gli schemi abituali dell’esperienza della città come in un trasgressivo sogno situazionista magicamente divenuto realtà. Nel corso dei suoi primi giorni di funzionamento, Pokemon Go ha attirato i giocatori in una serie di luoghi inappropriati, come il Memorial dell’11 settembre e il cimitero nazionale di Arlington, in cui qualsiasi attività ludica non può che essere vissuta come un atto irrispettoso. La possibilità di catturare mostri rari ha portato alcuni giocatori in luoghi estremamente pericolosi come il « Truce Village » a Panmunjom, l’Area di sicurezza congiunta all’interno della zona demilitarizzata tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) si differenziano per il diverso grado in cui la grafica digitale domina il campo percettivo. La VR è un’esperienza totalizzante che richiede di indossare un dispositivo che isola la persona dal resto del mondo visibile. Una volta immerso in questo ambiente, l’utente è psichicamente presente in una realtà completamente autonoma e graficamente ricostruita, e interagisce per lo più con oggetti che non esistono al di fuori di essa. L’AR fonde i propri impulsi e le proprie sovrapposizioni grafiche con il mondo cosi come lo percepiamo, senza bisogno di un equipaggiamento specifico. Attualmente, il livello che aumenta la realtà si presenta sullo schermo di un telefono o di un tablet, ma può anche essere sovrapposto su una finestra tradizionale, sul parabrezza di un veicolo, sulla visiera di un casco e persino su un leggero reticolo ottico da portare sul viso, come il Project Glass di Google. Gli antenati concettuali dell’AR sono i display informativi sviluppati per i piloti militari nei primi anni ’60, quando le performance dei velivoli nemici avevano cominciato a supe...
Similar Free PDFs

Tecnologie radicali - Greenfield
- 41 Pages

10)Radicali Liberi Aox
- 78 Pages

Greenfield Software (GFS) - v0.1
- 8 Pages

Tecnologie dell\'istruzione
- 14 Pages

Tecnologie dell\'istruzione
- 13 Pages

Linguaggi e nuove tecnologie
- 9 Pages

Tecnologie inclusione scolastica
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu