Tesina informatica giuridica a.a. 2015-2016 PDF

| Title | Tesina informatica giuridica a.a. 2015-2016 |
|---|---|
| Author | Ilaria Pagliuca |
| Course | Informatica e informatica giuridica |
| Institution | Università degli Studi di Perugia |
| Pages | 13 |
| File Size | 143.2 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 68 |
| Total Views | 126 |
Summary
tesina ...
Description
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Insegnamento di Informatica Giuridica.
Uomo e Macchina
0
L’ uomo del XXI secolo, descritto da Neil Postnam, è colui il quale si è trovato sommerso dal mondo telematico
e
videomatico,
che
concentra
l’
attenzione sui computer piuttosto che sulla vera identità umana.
Dalla metà del XX secolo in poi le persone hanno cominciato a considerare la tecnologia come un prolungamento aiutare
e
distaccare
del corpo umano, capace di
semplificare
i
l’uomo
antichi
Questa
da
rapporti,
tanto
valori
disciplina,
da
morali. dibattuta
tra scienziati e filosofi, manifesta aspetti teorici e pratici
oltre
che etici.
Nel
suo
aspetto
puramente informatico, essa comprende la teoria e le tecniche per lo sviluppo di algoritmi che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e un’attività intelligente, almeno in domini specifici. Non a caso, in questi ultimi anni si è sviluppata la teoria dell’Intelligenza Artificiale, secondo la quale ogni dominio della conoscenza può essere descritto tramite una teoria logico-matematica
1
basata su un’ipotesi non verificata e neanche verificabile. Possiamo dire infatti che l’Intelligenza Artificiale è l’abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti
che
vengono
descritti
come
appartenenti tipicamente alla mente umana: le cosiddette macchine della mente. Il significato di intelligenza, il rapporto mente cervello, la possibilità di costruire macchine capaci di pensare, diventano elemento di indagine di Alan Turing, creatore dei moderni calcolatori, e del
filosofo-studioso
di
psicologia
e
scienze
cognitive Jerry Alan Fodor. Il motivo di indagine è nato proprio dal problema di
dare
una
definizione
delle funzioni sintetiche
formale
ed
astratte
di ragionamento e di apprendimento dell'uomo che vengono realizzate e concretizzate appunto dalla tecnologia o meglio dalle macchine. La domanda al centro del dibattito è la seguente: “ I computer possono pensare?”. Ovviamente è un interrogativo che ancora non trova risposta a causa
di
opinioni
diverse
contrastanti.
2
e
soprattutto
Da ciò nascono le due grandi correnti di pensiero sullo studio dell’I.A.. La prima, meglio nota come ”intelligenza artificiale forte”, ritiene che un computer
correttamente
programmato
possa
essere dotato di una propria intelligenza tale da non distinguersi
da quella umana in nessun
particolare aspetto: essa vede al centro della teoria il pensiero del filosofo Thomas Hobbes, convinto del fatto che il ragionare non fosse altro che un insieme di calcoli eseguiti dal cervello; teoria
sostenuta
anche
dai
filosofi
del
funzionalismo, quella filosofia della teoria della mente, sviluppata da Hilary Putman nel 1950 e poi ripresa da Fodor verso gli anni Sessanta. In
breve
la
sua
"Teoria
computazionale
e
rappresentazione della mente", contenuta in "The Language of Thought" del 1975, è considerata la formulazione
per
funzionalista
dopo
antonomasia quella
della
iniziale
teoria
di Putnam
(sopra). Come quest'ultimo, Fodor si distacca dal comportamentismo e
dal
riduzionismo della teoria dell'identità, ed afferma la
possibilità
accettando
di
rifiutare
l'esistenza
di
stati
il dualismo pur mentali
che
generano il comportamento. In altre parole, egli
3
considera possibile lo studio scientifico della mente anche se diversamente da tutte le altre materie
scientifiche,
come
ad
esempio
le
neuroscienze. La seconda corrente sullo studio della I.A. viene considerata, invece, come “intelligenza artificiale debole”, in quanto sostiene l’impossibilità da parte di un computer
di eguagliare la mente
umana, riuscendo semmai soltanto a simulare alcuni processi cognitivi senza mai riprodurli nella loro completezza. Per
poter
arrivare
al
centro
della
nostra
discussione, bisogna innanzitutto fare un veloce excursus sulle origini e sull’evoluzione delle macchine. Partiamo dal XVII quando Pascal, per la prima volta, inventò una macchina capace di sottrarre e addizionare automaticamente, nata dalla volontà del filosofo di aiutare il padre nello svolgere un difficile lavoro di calcolo per l’amministrazione fiscale della società presso cui lavorava. Anche
se si
dice
che
comunque
la
teoria
dell’evoluzione della I.A. si evolva in modo distaccato dai progressi scientifici, importante è comunque il collegamento che essa ha con la
4
tecnologia, in particolare informatica. Solo nella seconda metà del XX secolo fu possibile creare dispositivi
di
calcolo
e
linguaggi
di
programmazione così precisi tanto da poter essere utilizzati anche durante le due guerre mondiali. Un punto di svolta nella materia lo ritroviamo in un articolo redatto nel 1950 sulla rivista “Mind”. L’articolo di Alan Turing, che riprendeva anche a grandi linee il criterio elaborato da Cartesio nel suo “Discorso sul metodo” del 1635, indicava la possibilità di creare un programma capace di far comportare un computer in maniera intelligente: “Possono
le
macchine
pensare?”
Propongo di indagare se sia possibile per le macchine avere un comportamento intelligente. Dovremmo cominciare definendo “macchina” e “ pensiero” nel loro significato più comune, ma sarebbe fuorviante.” (Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, Mind, 1950) Questa possibilità si esplica nell’ormai famoso “Test di Turing”, un criterio teso a determinare se una macchina sia o meno in grado di pensare. La soluzione proposta consiste nell’utilizzo di un modello
matematico
capace
5
di
simulare
il
processo di calcolo umano, scomponendolo nei suoi vari passaggi. Esaminiamo brevemente la condizione che deve venire a crearsi affinché questa sia riconosciuta come
intelligente.
Turing,
nell’articolo
sopra
citato, prende spunto da un gioco chiamato “gioco
supponendo
dell’imitazione”
la
compresenza di tre soggetti A, B, C e che quest’ultimo attraverso un interrogatorio debba arrivare ad identificare il sesso degli altri due soggetti.. A e B in questo caso hanno due compiti prestabiliti: B (uomo) deve aiutare C a capire, mentre A (donna) deve ingannarlo cercando di portarlo ad un’identificazione errata. Le risposte dei
due
soggetti
sono
date
in
maniera
dattiloscritte in modo tale che C non abbia alcun tipo
di
aiuto.
macchina. Se
Ora A
viene sostituita
dalla
il numero delle volte in cui C
indovina chi è uomo e chi è donna è simile a prima e dopo la sostituzione di A con la macchina, allora
la
intelligente,
macchina
stessa
dal
momento
sarà che
considerata sarebbe
indistinguibile da un essere umano. Logicamente non è stato mai verificato, e questo ha portato a diverse confutazioni da parte di scienziati e
6
filosofi, al punto tale da pensare che, forse, il problema della diatriba fosse proprio il Test di Turing. Viene a delinearsi in questo modo la teoria del filosofo
statunitense
John
Searle,
il
quale,
attraverso l’ esperimento della “scatola cinese”, cerca di dimostrare l’inutilità dell’assimilazione di una mente ad un computer, quest’ultimo non in grado di “pensare” come un essere umano. La descrizione di Searle illustra un’incapacità a valutare l’essenza dei processi cerebrali e non biologici che possono replicarsi.
Il suo diventa
così un esperimento mentale dove immagina una persona
sola
in
una
stanza.
Questa
riceve
dall’esterno dei foglietti di carta con delle scritte in cinese: egli comincia con l’assunzione che l’uomo nella stanza non capisce nulla, ma che comunque sarà in grado di ordinare, stabilendo una regola di associazione, i vari ideogrammi contenuti nei foglietti. L’uomo crea, in questo modo, l’apparenza della comprensione del cinese seguendo le istruzioni per manipolare i simboli, ma non arriva comunque a comprendere la lingua cinese. Questo esperimento, per Searle, è una confutazione alla teoria della macchina di Turing
7
e soprattutto è tesa contro quella corrente detta “intelligenza artificiale forte” (di cui sopra) in quanto poiché un computer non sa fare altro che quello che sa fare l’uomo, nessun computer, eseguendo un programma, arriverà a capire realmente
il
cinese.
dell'argomento
di
Il
Searle
punto è
la
centrale distinzione
tra sintassi e semantica. La stanza è in grado di combinare i caratteri secondo le regole, in altri termini la stanza si comporta come se seguisse regole sintattiche, ma secondo Searle, essa non conosce il significato di ciò che ha fatto, ovvero non ha contenuto semantico. I caratteri non rappresentano neppure simboli perché non sono interpretati in nessuna fase del processo. Come è avvenuto per il modello di Turing, anche all’argomentazione di Searle sono state mosse diverse critiche. Le più esponenti sono quelle che rientrano nella “risposta del sistema” e nella “risposta del robot”. Per quanto riguarda la risposta del sistema viene presa in considerazione la figura dell’uomo: l’uomo all’interno della stanza è assimilato ad un neurone
nel
cervello.
Questo
da
solo
non
comprende, ma contribuisce alla comprensione
8
complessiva. La persona non capisce, ma il sistema complessivo, cioè la stanza e l’uomo, sì. La risposta di Searle a questa critica appare comunque molto convincente, in quanto sostiene che nel caso in cui la persona memorizzi un intero libro
di cinese
non
cambierebbe
affatto
la
situazione tanto che l’uomo continuerà a non capire, ma riuscirà lo stesso ad organizzare i simboli secondo una regola operazionale: non c’è nulla nel sistema che non sia anche nell’uomo, e, in conclusione, se l’uomo continua a non capire la lingua neanche il sistema ne sarà in grado. Il
secondo
all’esperimento
grande di
filone
Searle
della
viene
critica
denominato
“risposta del robot”, supponendo appunto che al posto della stanza, il programma sia collocato in un robot libero di muoversi nell’ambiente. La domanda è se in questo modo il robot capisca il cinese o, come nel caso precedente, continui a seguire delle regole operazionali. Diverso sarebbe il caso in cui al robot sia collegata una mente umana: in questo caso ovviamente il robot sarebbe capace di pensare! Searle concorda con tale
affermazione,
convinto
del
fatto
che
teoricamente sia possibile creare un’intelligenza
9
artificiale, ma che questa non sarà più un semplice calcolatore dovendo possedere gli stessi poteri causali di un cervello.
CONCLUSIONI
Tuttavia, quindi, come dalla rude Pascalina del 1642, ci si sia concentrati, sempre di più, a creare delle macchine capaci di capire le esigenze e facilitare qualsiasi tipo di lavoro, cercando di creare una sorta di robot, che riuscisse a pensare in maniera propria senza l’aiuto dell’azione dell’uomo. Cosa ancora più importante è che l’uomo ha sempre cercato in qualche modo di capire
come
effettivamente
funzioni
il
suo
cervello, riproponendolo, con non troppi risultati sperati per lo meno fino a questo momento, all’interno delle macchine. Se da una parte c’è un forte stimolo a realizzare computer sempre più efficienti capaci di vedere, parlare e sentire, dall’altra c’è chi teme tutto questo,
ma,
(biochimico
come e
scriveva
scrittore
10
sia
Isaac
Asimov
nel
campo
fantascientifico che di divulgazione scientifica): “Quale modo migliore per celebrare la vittoria dell’intelligenza se non quello di trasmettere la nostra eredità ad un’intelligenza ancora più grande, creata da noi?” Quando si parla di Intelligenza Artificiale si pensa in genere alla mente di un uomo, ma sarebbe più opportuno ed utile riferirsi alla mente di un bambino o di un animale a seconda dell’ambiente nel quale il “robot” dovrà operare, in quanto si tratterà comunque di una macchina, che anche se completa,
perfetta
e
sofisticata,
verrà
considerata come un collaboratore dell’uomo e non “essere umano”.
BIBLIOGRAFIA
11
- “La singolarità è vicina”, Ray Kurzwell, APOGEO, 2005 - “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, 1950 - “Wikipedia”, Enciclopedia
12...
Similar Free PDFs

Informatica giuridica
- 66 Pages

Filosofia e Informatica Giuridica
- 24 Pages

Informatica Giuridica Finito
- 29 Pages

Nozione DI Sanzione Giuridica
- 2 Pages

Incapacità Giuridica
- 8 Pages

RPA AA - RPA AA
- 7 Pages

AA - metabolismo de aa
- 4 Pages

Tesina
- 11 Pages

Bilewicz 2006 2 - aa aa
- 12 Pages

Tesina
- 8 Pages

Tesina
- 15 Pages

Tesina
- 5 Pages
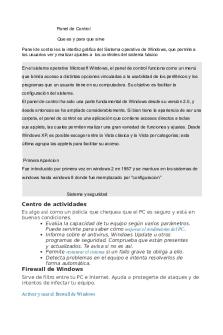
Informatica
- 8 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


