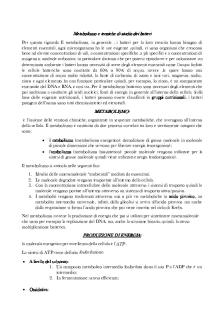2 Farmacologa cellulare e molecolare PDF

| Title | 2 Farmacologa cellulare e molecolare |
|---|---|
| Course | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA |
| Institution | Università degli Studi di Napoli Parthenope |
| Pages | 21 |
| File Size | 430.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 56 |
| Total Views | 167 |
Summary
RECETTORII farmaci per determinare i propri effetti devono interagire con proteine regolatrici suddivise in: ⁃enzimi (aspirina che inibisce le Cox) ⁃canali ionici (analgesici locali che inibiscono i canali per il Na) ⁃trasportatori (antidepressivi che inibiscono la ricaptazione di serotonine e norad...
Description
RECETTORI I farmaci per determinare i propri effetti devono interagire con proteine regolatrici suddivise in: ⁃ enzimi (aspirina che inibisce le Cox) ⁃ canali ionici (analgesici locali che inibiscono i canali per il Na) ⁃ trasportatori (antidepressivi che inibiscono la ricaptazione di serotonine e noradrenalina) ⁃ recettori. Questi ultimi sono proteine a basso peso molecolare (40 Kda). L'interazione di un farmaco con un recettore è reversibile per i legami ionici, ad idrogeno e forze di Van der Waals perché sono legami deboli, abbiamo Agonisti le cui proprietà sono affinità recettoriale (legame) ed attività intrinseca (effetti attivazione) ed Antagonisti le cui proprietà sono affinità recettoriale, mancanza di attività intrinseca, inibisce azione agonista bloccando sito di legame: ⁃ Agonisti reversibili che in seguito al legame farmaco-recettore determinano una cascata di eventi intracellulari (2° messaggero) che porta all'attivazione della cellula ⁃ Antagonisti reversibili rendendo impossibile il legame dell'agonista poiché esso blocca il sito di legame sullo "stesso sito dell'agonista" (antagonista competitivo) o su un "sito regolatorio" (allosterico) ⁃ Irreversibili: mentre l'interazione è irreversibile per il legame covalente perché è un legame forte. Un esempio è il legame dell'Alfa-Bungarotossina con il recettore nicotinico. ⁃ ⁃ Tra i principali Agonisti – Antagonisti abbiamo: (Acetilcolina – Atropina, Noradrenalina – Fentolamina, Istamina – Ranitidina). Le molecole che hanno effetto sui recettori sono amine biologiche (Adrenalina, Noradrenalina, Serotonina) e peptidi (Sostanza P, Angiotensina II, Ormoni) che andranno a determinare una serie di eventi a cascata attivando i recettori metabotropici Vi sono diverse teorie che spiegano l'interazione farmaco-recettore: ⁃ Teoria dell'occupazione: l'effetto di un farmaco è direttamente proporzionale al grado di occupazione del recettore. ⁃ Teoria dell'attività intrinseca: i farmaci hanno un affinità ed attività intrinseche proprie ⁃ Teoria del complesso ternario: il complesso farmacorecettore interagisce con una gprotein ⁃ Teoria del doppio strato: esistono 2 conformazioni del recettore a riposo o attivo. ⁃ L'efficacia di un farmaco è misurata grazie all'affinità recettoriale, n° molecole per sito e n° di recettori cellulari. Meccanismo competitivo: Ach e Curaro competono per lo stesso recettore, quantità eccessive di uno spiazzano l'altro. Blocco nicotinico: Succinilcolina (depolarizzante) non posso utilizzare inibitore colinesterasi ma devo aspettare il suo metabolismo. L'antidoto è una sostanza che si lega ad un'altra grazie a legami fisico-chimici e bloccano la sostanza in questione Classi di recettori: A seconda della topologia (localizzazione), troviamo: Recettori di membrana: per molecole che non riescono ad attraversare la membrana plasmatica dotata di un bilayer fosfolipidico ed abbiamo:
⁃ Recettori accoppiati ad una G-protein: recettori di membrana che trasducono informazioni di una vasta gamma di neurotrasmettitori ed ormoni formati da una singola catena polipeptidica che attraversa 7 volte la membrana plasmatica e sono accoppiati a G-Protein le quali sono formate da 3 subunità (alfa, beta e gamma) di cui solo l'alfa lega ed idrolizza il GTP in GDP consistendo in un eterotrimero che cambia conformazione in seguito all'attivazione (Stereoisomerismo). Essa è in grado di modulare l'azione di 2° messaggeri. ⁃ Si dividono in: ⁃ Gs stimolanti l'attività dell'adenilato-ciclasi la quale aum cAMP che interagisce con la PKA (protein chinasi cAMP dipendente) cha a sua volta fosforila enzimi, proteine strutturali, canali. La classica funzione della via cAMP/PKA è quella della mobilizzazione del glicogeno epatico dopo stimolo catecolaminergico. La noradrenalina che si libera dallo stimolo ipoglicemico, attiva i recettori adrenergici sugli epatociti e tramite una proteina G stimolatoria (Gs) mette in modo la produzione di cAMP tramite una adenilatociclasi che attiva la PKA che fosforila l'enzima glicogeno fosforilasi che a partire dal glicogeno arriva alla liberazione di glucosio. Al termine della sua azione l'cAMP viene inattivato in 5-AMP dalla Fosfodiesterasi. Stimolano anche l'enzima guanilato-ciclasi che produce cGMP che attiva la PKG che va a fosforilare proteine specifiche. ⁃ Gi che hanno attività opposta. ⁃ Gq che attivano l'enzima fosfolipasi C che da vita all'IP3 (inositolo trifosfato) e DAG (diacilglicerolo), il primo determina la fuoriuscita di Ca dal reticolo sarcoplasmatico, il secondo grazie a questo Ca attiva la PKC (protein-chinasi calcio-fosfolipidi dipendente). Esse hanno anche un'attività sui canali ionici, le Gs attivano i canli per il Ca, l'opposto le Gi. Un esempio sono i recettori muscarinici per l'Ach, recettori Alfa e Beta adrenergici, dopaminergici, 5HT2 serotoninergici, istaminergici, dell'ACTH, Prostaglandine, Vasopressina (metabotropici). ⁃ Recettori canale: sono complessi macromolecolari formati da subunità proteiche che si assemblano per determinare un canale idrofilico. Le subunità attraversano più volte la membrana plasmatica e l'apertura del canale è causata dal legame del ligando con il sito posto all'esterno della membrana producendo un rapido afflusso di ioni in entrata o in uscita. Neurotrasmettitori quali Ach, Serotonina, Glutammato (permeabili a Na e Ca), Gaba e Glicina (permeabili a Cl) si legano a recettori accoppiati a canali ionici. Un esempio è il recettore nicotinico per l'Ach (ionotropico) infatti esso è composto da 2 subunità ed occorreranno 2 molecole di Ach per attivarlo e dare vita al potenziale di placca in miniatura, anche i recettori Gaba A e i recettori 5HT3 serotoninergici. ⁃ Recettori per le citochine ⁃ Recettori con attività guanilato-ciclasica
⁃ Recettori intracellulari: per molecole lipofile che attraversano la membrana plasmatica come gli ormoni steroidei, tiroidei e le vitamine A e D. Gli ormoni steroidei dopo aver attraversato la membrana si legano ai recettori intracellulari attivandoli determinando una traslazione di questo dimero all'interno del nucleo modificando sequenze specifiche di DNA che attivano o inibiscono la trascrizione di determinati geni. Anche piccole molecole come l'ossido nitrico NO può svolgere l'attività di un 2° messaggero attraversando con facilità la membrana si legano a proteine citosoliche controllando sia la contrazione muscolare che la modulazione del rilascio di neurotrasmettitori.
Modulazione delle risposte recettoriali La riduzione di sensibilità è definita desensibilizzazione; un aumento è detto ipersensitizzazione. La perdita di un effetto farmacologico in seguito a trattamento con agonisti recettoriali crea tolleranza che può essere rapida (tachifilassi) o lenta (bradifilassi) La desensitizzazione può essere omologa o eterologa, variazione dell’affinità per il recettore o variazione del numero (down regulation=diminuzione recettori/ Up regulation=aumento recettori) Desensitizzazione per recettori accoppiati a proteine G: fosforilazione della serina da PKA oppure fosforilazione da B-ARK(GRK) tramite b-arrestina. Tale desensitizzazione è regolata dal fattore di trascrizione CREB ad opera di PKA regolata a sua volta da cAMP Desensitizzazione per recettori canale: modifica reversibile della struttura causata da interazione allosterica Desensitizzazione per recettori per fattori di crescita: riduzione affinità per il fattore di crescita, riduzione dell’attività tirosinchinasica e internalizzazione del recettore Desensitizzazione per recettori intracellulari: determinata dalla trascrizione di geni per gli stessi trasmettitori che possono ridurne il numero o aumentarne la degradazione
Recettori pre-sinaptici: a livello delle terminazioni nervose regolano il release di mediatore, a livello del corpo cellulare e dendriti dim l'attività elettrica (Iperpolarizzazione): ⁃ Autocettori: attivati dallo stesso mediatore ⁃ Eterocettori: attivati da un diverso mediatore ⁃ Come recettori possiamo trovare: ⁃ sostanze endogene (M1, Alfa, Beta, H1, 5HT2....) ⁃ enzimi (Aspirina blocca le Cox-1) ⁃ canali ionici (anestesia locale blocca canali Na) ⁃ acidi nucleici (antibiotici) ⁃ proteine strutturali (colchicina contro la gotta). Il recettore può essere silente (non si attiva). Particolari cellule del sistema nervoso come le cellule gliali hanno funzioni di supporto, metabolizzazione e ricaptazione del mediatore. TRASPORTO IONICO Canali ionici: complessi multiproteici che formano pori idrofilici attraverso modificazioni conformazionali delle proteine che formano dei canali attraverso i quali passano i flussi ionici. In base ai meccanismi di attivazione abbiamo: ⁃ - canali attivati da ligando (recettori canale): vedi prima ⁃ - canali voltaggio-dipendenti: attivati dal potenziale d'azione ⁃ I principali canali ionici trasportano Na, Ca, Cl all'interno della cellula, K all'esterno. Canali per il Na: presenti tipicamente in cellule neuronali e nei cardiomiociti. Alcuni farmaci anticonvulsionanti bloccano questi canali e di conseguenza le scariche epilettiche, gli anestetici locali bloccano questi canali a livello delle fibre sensitive determinando iperpolarizzazione che non permette la conduzione dello stimolo doloroso, infine gli anti-aritmici inibendo questi canali riducono velocità di conduzione dello stimolo (effetto dromotropo negativo) e frequenza contrazione (effetto cronotropo
negativo). Canali per il Ca: regolano la contrazione muscolare, rilascio neurotrasmettitori e secrezione ormonale, esistono 2 tipologie di canale: i canali T a basso voltaggio che subito si inattivano e i canali L ad alto voltaggio che si inattivano dopo. Canali per il K: l'apertura di questi canali determina l'efflusso di K all'esterno della cellula per gradiente di concentrazione e l'effetto sarà un iperpolarizzazione della membrana a seguito dell'uscita di cariche di segno positivo (si passa da -70 mV a -90mV) rendendo più difficile il raggiungimento del valore soglia e la conseguente nascita del potenziale d'azione stabilizzando la membrana. Canali per il Cl: l'apertura di questi canali determina un afflusso di Cl all'interno della membrana secondo gradiente di concentrazione determinando iperpolarizzazione della membrana. Pompe e scambiatori: la membrana plasmatica ha sia funzioni di isolare il citosol dall'ambiente extracellulare sia di permettere un continuo scambio di sostanze con lo stesso. Il trasporto può essere sia attivo che passivo. Nel primo caso le molecole vengono scambiate contro gradiente di concentrazione e necessitano di pompe (usano ATP) e di scambiatori (usano energia elettrochimica dei legami), può coinvolgere un composto (uniporto) o più composti (cotrasporto) che può suddividersi in trasporto nello stesso senso (simporto) e trasporto in senso opposto (antiporto), mentre nel secondo caso le molecole diffondono per gradiente di concentrazione o elettrochimico. Pompe: complessi enzimatici che idrolizzando l'ATP trasportano ioni contro gradiente. ⁃ Pompa Na/K ATPasica: trasporta 3 ioni Na fuori e 2 ioni K dentro la cellula, questa pompa consuma il 30% dell'ATP generato dalla cellula stessa. Una sua importante funzione è a livello cardiaco rappresentando il bersaglio della Digitale che blocca questa pompa determinando un aum Na intracellulare che inverte l'attività dello Scambiatore Na/Ca (che in condizioni normali porta 3 ioni Ca fuori e 1 ione Na dentro) che espelle ioni Na e fa affluire all'interno ioni Ca che a sua volta libera il Ca-free-Ca dai reticoli sarcoplasmatici determinando un significatico aum Ca intracellulare. ⁃ Pompa protonica: scambia 1 ione K all'interno e 1 ione H all'esterno del lume gastrico, è situata tipicamente sulla membrana cellulare parietale gastrica dove secerne protoni ed acidifica l'ambiente gastrico (pH 1). Le vie vagali prendono rapporto con i neuroni colinergici che innervano le cellule parietali, le cellule che producono Gastrina e quelle che producono Somatostatina. Nella cellula parietale gastrica, in condizioni di riposo la pompa H-K-ATPasi è conservata in strutture vescicolari che non hanno rapporto con il lume e non sono a contatto con il K. L'attività di integrazione delle vescicole alla membrana con relativa esposizione delle proteine è controllata da: ⁃ Ach nel fondo gastrico agisce attraverso recettori di tipo muscarinico (M3) anch’essi accoppiati ad una proteina Gq che attiva la fosfolipasi C con la formazione di IP3 ed aumento del calcio intracellulare che trasloca la Pompa protonica sulla membrana. ⁃ Gastrina viene prodotta da meccanismi di distensione e tramite il sangue raggiunge il fondo gastrico essa interagisce con recettori specifici accoppiati a proteine Gq che attivano la fosfolipasi con formazione di IP3 ed aumento del Ca intracellulare. ⁃ Istamina liberata dalle Cellule enterocromaffini light che interagisce con recettori H2 che causa aum di cAMP (meccanismo + importante di formazione Pompa). ⁃ Somatostatina viene liberata in caso il pH si abbassi troppo (acido) bloccando la produzione di Gastrina ed Istamina.
L'aumento di Ca e di cAMP determinano in entrambi i casi una fosforilazione delle proteine che mantengono ancorate le vescicole con dentro le pompe svincolandole e permettendone l'esposizione sulla membrana plasmatica. In tal modo la pompa che non aveva rapporti con il lume ora viene a contatto con gli ioni potassio che entrano nella cellula in cambio degli ioni idrogeno che fuoriescono giungendo nel lume contemporaneamente si attiva una corrente di ioni Cl in uscita; viene così attivata la secrezione dell'acido cloridrico (Hcl). ⁃ Questa pompa è il bersaglio di farmaci antiacidi che inibiscono l'attività ATPasica e l'influsso ioni K (Ranitidina). Le Cellule Epiteliali producono Bicarbonato e Muco (stimolate da Prostaglandine) (pH 6,5) Le Cellule Parietali inibiscono la Pompa (stimolate da Prostaglandine) ⁃ Pompa Ca ATPasi: enzima che regola la concentrazione citosolica di Ca espellendolo dalla cellula, ma la sua sola attività non basta infatti viene accoppiato con lo Scambiatore Na/Ca. Scambiatori: complessi che utilizzano l'energia elettrochimica proveniente dai legami. ⁃ Scambiatore Na/Ca: espresso in cellule nervose e muscolari, espelle 3 ioni Ca e introduce 1 ione Na e si attiva quando il Ca supera certi valori. A seguito di aum di Na intracellulare vi è un’inversione del trasporto ionico (vedi prima). ⁃ Sistema di recupero dei neurotrasmettitori: alcuni farmaci come gli anti depressivi agiscono ⁃ come inibitori della ricaptazione di noradrenalina e serotonina, inoltre alcuni composti psicostimolanti come la cocaina e l'ecstasy esercitano i loro effetti psicotropi agendo da inibitori rispettivamente del reuptake della Noradrenalina e della Dopamina. ⁃
SISTEMI DI TRASMISSIONE Neurone: Corpo cellulare: assicura sintesi neurotrasmettitore Assone: espansione citoplasmatica che permette di assicurare connessioni ed informazioni tra i diversi neuroni attraverso le secrezioni di mediatori ⁃ Trasporto assonico: di proteine e/o macromolecole del corpo cellulare alle terminazioni presinaptiche grazie alle tubuline (ortogrado è ATP-dipendente, retrogrado dalle terminazioni al corpo cellulare) ⁃ Reticolo endoplasmatico: si estende dal corpo cellulare all'assone.
⁃ ⁃
Neurone Pre-sinaptico: - sintesi di neurotrasmettitore - uptake (deposito in vescicola) - metabolismo (parziale) Spazio Intersinaptico: - liberazione - reuptake - metabolismo Neurone Post-sinaptico: - attivazione recettore specifico - metabolismo Sostanze liberate: - neurotrasmettitore - ormone - sostanze biologicamente attive
I neurotrasmettitori sono sintetizzati e liberati dal neurone, agiscono su specifici recettori, azioni rapide e fugaci, le sostanze biologicamente attive sono sintetizzate dai tessuti ed hanno effetti specifici su organi, gli ormoni sono rilasciati nel sangue, sintetizzati da ghiandole specifiche, trasportanti nel sangue dall'alfa globulina. Falso mediatore: - analogia strutturale mediatore (agonista debole) - depositato e rilasciato come mediatore - possono avere attività recettoriali (ma minori) - impediscono al vero neurotrasmettitore di legarsi al recettore Tra esse troviamo l'Alfa-Metilnoradrenalina, Tiramina. Con un farmaco possiamo intervenire nelle varie fasi del meccanismo d'azione di un neurotrasmettitore: ad esempio L'Ach: ⁃ Emicolineo: blocca la colina non facendola entrare nel neurone colinergico (Sintesi) ⁃ Vesamicolo: Ach rimane nel citoplasma e viene metabolizzato (Deposito) ⁃ Tossina botulinica: blocca esocitosi di Ach nello spazio sinaptico (Rilascio) ⁃ Inibitori colinesterasi: bloccano le colinesterasi che degradano l'Ach (Reuptake) Particolari cellule come le Cellule Gliali hanno funzioni di supporto, metabolizzano neurotrasmettitore e lo ricaptano. Cotrasmissione: - facilitazione risposta trasmissione - inibizione risposta neurotrasmissione - modulazione pre-sinaptica della liberazione o sintesi mediatore - su un altro recettore post-sinaptico di un neurone adiacente Trasmissione catecolaminergica: le catecolammine sono molecole che presentano un catecolo, un anello aromatico con 2 ossidrili in posizione 3 e 4 ed un'ammina. Tra esse troviamo la Dopamina, la Noradrenalina e l'Adrenalina aventi funzioni a livello del SNC (psichiche e motorie), periferiche (sistema cardiovascolare). Il SNA si divide in Simpatico e Parasimpatico. Il primo origina a livello delle corna antero-laterali della porzione T1 a L3 (toracico-lombare) della sostanza grigia midollare dove si trova il pirenoforo raggiungendo un ganglio (stazione grigia dove si incontrano 2 neuroni, il pre ed il post-sinaptico) che forma una catena paravertebrale nelle vicinanze e da qui si dirama il neurone post-sinaptico che raggiunge l'organo specifico. Il secondo origina a livello di gangli annessi ai nervi cranici e di gangli annessi alla zona sacrale raggiungendo un ganglio post-sinaptico a livello dell'organo innervato. Nella pre-sinapsi una depolarizzazione oltre il valore soglia apre i canali per il Ca che fa fondere le vescicole contenenti Ach per esocitosi con la membrana con il rilascio di mediatore nella fessura sinaptica, nella post-sinapsi il legame recettore-mediatore apre i canali per il Na che a sua volta apre i canali per il Ca. Il Simpatico a livello centrale rilasci Ach, mentre a livello periferico Noradrenalina, mentre il Parasimpatico rilascia sempre Ach sia a livello centrale che periferico. La stimolazione può essere diretta (Ach sul recettore), indiretta (inibizione reuptake) Tra le funzioni del sistema nervoso Simpatico abbiamo (attacca e fuggi): (DIFFUSO) ⁃ stimolazione sistema cardiovascolare, induce aum forza di contrazione cardiaca (effetto inotropo positivo), aum frequenza cardiaca (effetto cronotropo positivo), aum velocità d'impulso cardiaco (effetto dromotropo positivo) ed aum eccitabilità (effetto batmotropo
positivo). ⁃ aum flusso sanguigno cuore e muscoli ⁃ aum dilatazione bronchiale ⁃ dim produzione Hcl e motilità gastro-intestinale, aum contrazione sfinterica ⁃ dim secrezione pancreas ⁃ aum produzione renina ⁃ aum dilatazione vasi muscolari, dim dilatazione vasi periferici ⁃ aum glicogenolisi epatica Tra le funzioni del sistema nervoso Parasimpatico abbiamo (riposa e digerisci): (LOCALIZZATO) ⁃ dim volume sistolico, frequenza cardiaca e pressione ⁃ aum costrizione bronchiale ⁃ aum produzione Hcl e motilità gastri-intestinale, dim contrazione sfinterica ⁃ aum secrezione pancreas ⁃ aum secrezioni ⁃ dim renina ⁃ dim glicogenolisi epatica Il Simpatico a livello vasale regola sia la costrizione (recettori Alfa) che la dilatazione (recettori Beta), in particolare: ⁃ Adrenalina: affinità Alfa elevata (media per Beta) ⁃ Noradrenalina: affinità Alfa elevata (bassa per Beta) ⁃ Isoprenalina: affinità Beta elevata dose-dipendente (bassa per Alfa) ⁃ 1) Somministrando Adrenalina si ha subito un aum pressione seguito da un ritorno ai valori normali abbastanza rapido. 2) Somministrando prima degli Alfa-bloccanti e dopo A avrò un dim pressione (poichè i recettori Alfa sono bloccati, l'Adrenalina si riversa tutta sui Beta avendo una media affinità) 3) Somministrando Isoprenalina avrò dim pressione per l'elevata affinità Beta ma aum della frequenza cardiaca stimolando i Beta 1 4) Somministrando Noradrenalina avrò aum pressione per affinità Alfa. 5) Somministrando prima degli Alfa-bloccanti ...
Similar Free PDFs

2 Farmacologa cellulare e molecolare
- 21 Pages

biochimica e biologia molecolare
- 4 Pages

Pedagogia- Molecolare
- 20 Pages

Biologia Molecolare
- 79 Pages

Organizzazione Cellulare
- 31 Pages

11. continuo Docking Molecolare
- 29 Pages

LA Respirazione Cellulare
- 3 Pages

1 Lezione Trasporto Cellulare
- 8 Pages

Trascrizione biologia molecolare
- 27 Pages

La membrana cellulare
- 8 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu