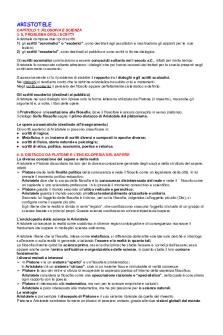Riassunto di Kelsen (\"Filosofia del diritto\" di P. Tincani) PDF

| Title | Riassunto di Kelsen (\"Filosofia del diritto\" di P. Tincani) |
|---|---|
| Course | Filosofia del diritto |
| Institution | Università degli Studi di Bergamo |
| Pages | 12 |
| File Size | 426.9 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 76 |
| Total Views | 134 |
Summary
Riassunto completo del capitolo su Hans Kelsen (dal libro "Filosofia del diritto" di Persio Tincani)....
Description
HANS KELSEN (1881 – 1973) La dottrina pura. La fama di Kelsen è dovuta principalmente alle sue ricerche sulla filosofia del diritto che tenta di rifondare su nuove basi. Nella sua opera “Lineamenti di dottrina pura del diritto”, Kelsen afferma che la scienza giuridica sia dominata da due grandi correnti di pensiero, l’idealismo e la giurisprudenza sociologica, che lui rifiuta in quanto le considera inadeguate a conoscere il diritto. Kelsen sostiene che questi approcci non siano adatti alla scienza giuridica in quanto il giurista deve studiare il diritto con metodo scientifico, per questo motivo è necessario rifondare il metodo che da sempre ha utilizzato la dottrina tradizionale → Tale metodo è definito dottrina pura e si ottiene togliendo dalle tecniche di studio della dottrina tradizionale tutti gli elementi che sono estranei al diritto, cioè gli elementi non giuridici. Questo nuovo metodo dichiara di essere una teoria puramente giuridica. Etica, morale, teologia, sociologia e le stesse ideologie della giustizia sono discipline utili per lo scienziato sociale: per esempio, quando si deve valutare come una certa norma viene recepita da un certo pubblico; oppure possono anche servire al legislatore nella sua attività di produzione di norme o per correggere quelle norme che non raggiungono lo scopo politico in vista del raggiungimento del quale sono state poste in vigore, ecc. →non è però il lavoro del giurista ma il lavoro dello studioso di politica (di scienze politica e di filosofia politica ).
Per Kelsen nessuna considerazione di valore ha effetto sul significato delle norme giuridiche, poiché il compito del giurista è puramente descrittivo (deve dire cosa dicono le norme, senza includere giudizi di valore). La filosofia del diritto, dunque, deve essere confinata a una spiegazione di ciò che il diritto è. Se il diritto in generale, o qualsiasi legge particolare, è buono o cattivo è una questione separata che dovrà essere risolta dai filosofi morali (ma non dal giurista!) Esempio del marziano e delle automobili: a seconda della conferenza di Proudhon o di Murray Rothbard, noi diamo una valutazione, rispettivamente, negativa o positiva della proprietà privata senza però spiegarla in termini giuridici, cioè stiamo dando una valutazione morale di quell’istituto giuridico ma non la sua descrizione.
La dottrina pura vuole conoscere esclusivamente e unicamente il suo oggetto (cioè il diritto), cercando di rispondere alle domande: che cosa è il diritto? Come è il diritto? e non come deve essere il diritto o come deve essere costituito; tuttavia, la scienza giuridica dei secoli precedenti si è rivelata a Kelsen ancora lontana dal raggiungimento di questo fine. Il bersaglio di Kelsen è chiaramente il giusnaturalismo, che tra tutte le dottrine idiosincratiche del Kelsen vs. diritto è quella che riassume in sé tutti i difetti della dottrina tradizionale perché confonde il piano giusnaturalismo della conoscenza empirica dei fatti con il piano della conoscenza dei significati dei fatti empirici. Afferma infatti che “se la scienza del diritto non deve risolversi nella scienza della natura, allora il diritto non ha niente a che fare con la natura”. Il significato di un fatto, anche se questo fatto un'azione umana, non può essere rilevato o sentito senz'altro nell'atto come un fatto esteriore. L’approvazione della legge la sentenza il contratto l'omicidio nessuna di queste cose esiste di per sé nelle azioni che le producono → Il diritto è un oggetto concettuale, oggetto che si può conoscere con il ragionamento e non con i sensi → il diritto è un oggetto di senso comune così basilare (tutti sanno o credono di sapere cos’è il diritto) che è facile dimenticarsi che non è un oggetto visibile o percepibile bensì il risultato di complesse scelte mentali e concettuali. Sorge dunque qualche confusione, che dipende dal fatto che l'oggetto (concettuale) giuridico si identifica nella nostra percezione immediata con l'oggetto (materiale) naturale che lo esprime, oppure con gli atti (materiali) che ricevono una determinata qualificazione giuridica (concettuale): tuttavia questi piani sono distinti. L'errore del giusnaturalismo sta proprio nella confusione di questi piani, chiamata fallacia naturalistica (da Hume). In generale, il giusnaturalismo si presenta come teoria scientifica del diritto ma è in realtà una delle tante teorie idealistiche, cioè che credono di individuare un ordine immutabile al quale gli ordinamenti giuridici vigenti si devono conformare, perché è la congruenza tra l'ordinamento reale e l'ordinamento ideale che gli ordinamenti vigenti vengono valutati sui termini della loro giustizia. Il giusnaturalismo è una teoria tanto idealistica quanto dualistica, in quanto coniuga il diritto positivo (reale, stabilito dagli uomini) con il diritto ideale (naturale e
immutabile, che si identifica con la giustizia) ne consegue che su queste basi nessuna conoscenza scientifica può essere fondata dunque non può essere fondata nessuna scienza giuridica. Altro bersaglio di Kelsen è l’idea di giustizia: vista come qualità che le istituzioni giuridiche devono possedere o intesa come lo scopo che l'ordinamento giuridico deve realizzare nella società (il diritto deve essere giusto). Tali concezioni non possono però essere accettate da una scienza del diritto. La giustizia è un ideale irrazionale, che esiste su un piano diverso da quello nel quale esiste il diritto, in quanto del diritto si può avere una conoscenza oggettiva (mentre della giustizia no). Dunque, valutare un sistema giuridico in termini di giustizia, non ha nulla a che vedere con uno studio giuridico scientifico. Questo confronto tra diritto e morale non descrive il diritto ma esprime un giudizio sul diritto (caso del marziano). La dottrina pura ha l’obiettivo di garantire oggettività ed esattezza al diritto, risultato raggiungibile solo qualora l’impresa scientifica riesca ad essere avalutativa La giustizia non può essere oggetto di studio della dottrina pura. Kelsen è relativista e non accetta l’idea dell’esistenza di una morale oggettiva→ il diritto è oggettivo perché oggettivamente conoscibile, la morale è soggettiva perché sono oggettivamente conoscibili i vari sistemi morali, ma non è oggettivamente conoscibile il sistema morale. Kelsen vuole tenere distinti i due concetti (diritto e morale): le attitudini morali e le credenze non sono altro che espressioni di interessi soggettivi (non può esistere una scienza della morale, perché le norme morali mancano di validità oggettiva). Kelsen non ritiene che i giudizi morali siano falsi, ma che i giudizi morali non siano giuridici (es. ordinamento giuridico nazista: la filosofia morale potrà dire che il regime nazista è profondamente ingiusto, la scienza giuridica può soltanto parlare di diritto e quindi studiare le sue norme e spiegarne il significato, cioè ha gli strumenti solo descrivere il suo oggetto e non per valutarlo). La separazione di teoria morale e giuridica è una condizione per la possibilità della scienza giuridica, perché i discorsi morali non posseggono la struttura per poter essere studiati giuridicamente. Tale separazione si scontra con la dottrina tradizionale → l’errore della dottrina tradizionale è considerare l’esistenza di una morale assoluta valida per tutti, vera, che si distingue dalle tante morali particolari false (dunque non valide): il diritto giusto sarebbe il diritto che incorpora i valori di quella morale (la sola valida) e che quando è possibile ne ribadisce le norme; tuttavia non vi è traccia di questa morale universale secondo l’idea di Kelsen, in realtà esistono tanti sistemi morali, ciascuno dei quali è considerato giusto dalle persone che lo adottano perché la morale è il prodotto degli interessi che ogni società sente come più rilevanti e che perciò intende proteggere. Ciò ha conseguenze importanti sul concetto di giustizia: giustizia esprime un valore assoluto e il suo contenuto non può essere determinato dalla dottrina pura del diritto, anzi e sono né in alcun modo determinabile dalla conoscenza razionale. Ogni valore morale non è assoluto, bensì relativo, cioè affermato da alcuni gruppi sociali (o da alcuni individui) e non necessariamente riconosciuto anche dagli altri affermare che il diritto (ho un particolare ordinamento giuridico) è giusto, significa affermare che idoneo a realizzare i fini morali che il legislatore aveva in mente quando lo ha posto in essere: si tratta di una valutazione che si concentra per intero nel giudicare il diritto come un mezzo per il raggiungimento di uno scopo, ma che non si spinge fino a valutare lo scopo. Norberto Bobbio: “il problema della giustizia è il problema della corrispondenza o meno della norma ai valori ultimi o finali che ispirano un determinato ordinamento giuridico. Ci basta constatare che ogni ordinamento giuridico persegue certi fini e convenire sul fatto che questi fini rappresentano i valori alla cui attuazione il legislatore, più o meno consapevolmente e adeguatamente, dirige la propria opera. nel caso che si ritenga vi siano valori supremi, oggettivamente evidenti, il domandarsi se una norma sia giusta o ingiusta significa domandare se essa sia atta o non ad attuare quei valori. Ma anche nel caso in cui non si crede in valori assoluti, il problema della giustizia o meno di una norma ha un senso: equivale a domandarsi se quella norma sia atta o meno a realizzare i valori storici, che ispirano quel concreto e determinato ordinamento giuridico”.
Adottare la tesi della separazione non significa che il concetto di giustizia non possa essere utilizzato nello studio giuridico, ma si rende necessaria una trasformazione da concetto morale a concetto giuridico, che va inteso come sinonimo di legale. Nella maggioranza dei casi il diritto vigente non soddisfa tutti, ma questo non significa che non sia possibile che un particolare ordinamento giuridico finisca per corrisponderà esattamente alle ideologie e morale di tutti i membri della società nella quale quell'ordinamento è in vigore: un tale ordinamento sarebbe perfettamente coincidente con l'idea di giustizia ideologica di quella società e, di conseguenza, realizzerebbe la felicità di tutti. È possibile che una situazione del genere possa realizzarsi anche se è molto improbabile. Di fatto tale situazione non indebolisce in nessun modo la separazione tra diritto e morale: i due ambiti restano ontologicamente distinti anche se le norme dell’uno possono coincidere con le norme dell’altro → il diritto percepisce le idee morali più diffuse in società, ma è anche uno strumento di mutamento delle convinzioni morali diffuse. Il dovere di obbedienza alle norme giuridiche non dipende dal loro contenuto specifico, ma dal fatto che sono giuridiche:
se
il contenuto di determinate norme coincide con quello di determinati precetti morali: allora determinate condotte saranno doverose tanto per il diritto quanto per la morale → in questo caso sorgono due obblighi (morale e giuridico), che possono materialmente coincidere (un solo comportamento adempie ad entrambi gli obblighi) ma restano concettualmente irrelati (non legati, non connessi).
se le norme e i precetti morali divergono o sono in contrasto: dal punto di vista giuridico, il contrasto di una norma con un precetto morale è irrilevante (la norma non viene considerata invalida se contrasta con la morale) poiché non esiste alcuna possibilità di antinomia tra diritto e morale. L’antinomia può infatti esistere solo tra norme che appartengono allo stesso ordinamento, mentre i doveri (uno giuridico e l'altro morale) che sono in preteso contrasto, discendono da due ordinamenti diversi, indifferenti l'uno rispetto all'altro. Si potrebbe obiettare che diritto e morale sono entrambi sistemi normativi che possono entrare in contrasto avendo ad oggetto le condotte umane: in caso di contrasto, quindi, sia un'antinomia e quindi la prevalenza di un sistema sull'altro (per il giurista: del sistema giuridico su quello morale; per il moralista: del sistema morale su quello giuridico) dipende dalle regole del sistema di riferimento, che prescrivono quale è la norma che deve prevalere in caso di conflitto. nel concludere per la validità dell'obbligo giuridico nei casi di conflitto con la morale, il giurista deve 1) rilevare l'esistenza di un conflitto; 2) rilevare l'esistenza della regola che stabilisce che la norma giuridico prevale sulla norma morale; 3) applicare quella regola, riconoscendo la norma morale come soccombent e.
In realtà l’obiezione è sbagliata poiché lo studio giuridico ha per oggetto solo e soltanto il diritto: nel momento in cui il giurista riconosce l'esistenza di un ordinamento morale ha cessato di comportarsi come scienziato del diritto → per la scienza giuridica esiste un solo ordinamento: l'ordinamento giuridico. Alla base di tale obiezione giace la confusione tra il piano della normatività e quello della fattualità (tra essere e dover essere), la cui separazione rappresenta uno degli assi portanti della teoria di Kelsen e in generale ed è il positivismo giuridico; oltre a ciò, la confusione può essere conseguenza dalla poca precisione del linguaggio naturale usato (“norma” – “dovere” possono indicare sia la norma (o il dovere) giuridico che la norma (o il dovere) morale o prudenziale.
Validità ed efficacia. Il tentativo di rifondare il diritto riguarda anche l’idea del rapporto tra validità ed efficacia delle norme e in particolare l’idea che le norme giuridiche debbano essere efficaci per essere considerate valide. In particolare si fa riferimento alla convinzione che le norme possano decadere per desuetudine: una norma che da tempo non viene applicata smette di essere considerata una norma applicabile, e perciò cessa di essere una norma valida → tale visione è propria della giurisprudenza sociologica, una scuola di pensiero che vede il diritto come il complesso risultato delle regole e della loro efficacia, cioè della loro effettiva presenza nella società come tecniche per orientare e valutare le azioni umane e che identifica la validità con l’efficacia.
Uno dei massimi esponenti di tale scuola è EUGEN EHRLICH, che nella sua opera “I fondamenti della sociologia del diritto” (1913) scrive che «la norma giuridica è solo una delle varie regole dell’agire e, in quanto tale, ha la medesima natura di tutte le regole sociali. La scienza giuridica non mette mai in rilievo questa affinità e tende invece ad accentuare le differenze tra il diritto e le altre norme, in particolare quelle della morale, per esercitare sul giudice una costante ed efficace pressione diretta a farlo decidere unicamente in base alle norme giuridiche, e mai scomodando altre norme» Per Ehrlich, la separazione tra diritto e morale non è una questione analitica (come sostiene Kelsen), ma solo pratica: serve a limitare il campo delle soluzione possibili dei casi concreti, perché impone di considerare esistente ai fini dell’applicazione del diritto, solo la norma di diritto positivo (tralasciando quindi tutti gli altri tipi di norme, es, norme sociali) → si tratta di un’affermazione normativa e non di una descrizione della realtà delle cose: «solo quelle regole giuridiche che sono effettivamente divenute regole dell’agire e che, quindi, sono riconosciute e osservate, almeno in generale, dagli uomini, costituiscono l’ordinamento del gruppo sociale». Il giudice non ignora gli altri sistemi normativi e quindi non ignora nemmeno il sistema morale, che fa sì che determinate norme (di diritto positivo) siano considerate vincolanti dalle persone: norme desuete non vengono applicate e nemmeno le norme inefficaci, perché nessuno (cittadini, giudici) le utilizza come ragioni per l’azione → per Ehrlich il diritto positivo non è di per sé diritto valido a meno che non consta di norme efficaci. Questa impostazione (diventerà punto essenziale nel realismo giuridico) lega la validità delle norme alla loro efficacia. Se il diritto è guida del comportamento (o tecnica di controllo sociale) non possiamo dire che sia diritto una norma di diritto positivo che non viene seguita da nessuno (perché non viene utilizzata o seguita mai come guida del comportamento). Validità ed efficacia, quindi, sono due elementi che insieme concorrono a definire la norma giuridica. Per analizzare il rapporto tra validità ed efficacia occorre definire cosa sia l’efficacia. Kelsen condivide l’idea che il diritto sia uno strumento di controllo sociale e che l’efficacia sia rilevabile dall’osservazione del comportamento delle persone di fronte alla norma giuridica: l’efficacia, quindi, è la situazione che viene a determinarsi quando la norma viene effettivamente osservata e applicata. L’efficacia è sempre relativa al comportamento umano e non alla norma giuridica (della quale si dice è efficace o non è efficace) e per questo la validità della norma non si può identificare con la sua efficacia (e quindi non può essere una qualità della norma) perché il livello giuridico non ha nulla a che vedere con il piano naturalistico dei fatti osservabili. Il fatto che una norma sia rispettata dai tribunali non dice nulla sul fatto che sia funzionale sullo scopo di controllo sociale in vista del cui raggiungimento è stata posta in vigore (es. norma che punisce con multa di 10 € chi ruba 100 capi di bestiame e 30 € per chi ruba 101 e + capi -> vista la sanzione molto bassa possiamo dire che la norma non è efficace perché non raggiunge lo scopo di dissuadere/diminuire i furti).
Per i pensatori della giurisprudenza sociologica, la validità è intesa come validità sociale, perché consiste nell’efficacia della norma nella società: una norma vale socialmente se viene osservata o se viene sanzionata la sua inosservanza. Nella terminologia di ROBERT ALEXY, il diritto funziona come strumento di controllo sociale e di guida del comportamento se è efficace nei termini della concezione giuridica della validità: se una norma, o un sistema di norme, non ha alcuna validità sociale e dunque non manifesta la minima efficacia sociale, tale norma, o sistema di norme, non può neanche valere sul piano giuridico. In ogni caso, per la dottrina pura (e dunque per Kelsen), l’efficacia riguarda il comportamento delle persone (oggetto fattuale → appartiene al piano dell’Essere, Sein) e non riguarda la norma (diritto è oggetto normativo → appartiene al piano del Dover Essere, Sollen). Per Kelsen, una norma valida è una norma vincolante, ma la condizione di validità della norma giuridica è la sua appartenenza all’ordinamento giuridico: una norma è vincolante quando prescrive un dover essere in modo vincolante (e non che quella norma vincoli effettivamente nel senso che viene davvero seguita e che produce effetti nella vita delle persone).
Essere e Dover Essere sono due realtà distinte che non possono in alcun modo confluire l’uno nell’altro (conferma della c.d. legge di Hume, fallacia naturalistica). Per Kelsen, neanche il fatto che una norma non sia mai stata applicata può essere una ragione per dubitare della sua validità e del fatto che essa possa o debba essere applicata: una norma giuridica entra in vigore già prima di essere efficace, cioè prima di essere osservata e applicata (un tribunale che applichi ad un caso concreto una legge appena emanata applica una norma giuridica valida, applicandola diverrà efficace). Dunque, non esiste un concetto di validità assoluto perché si parla di validità della norma solo in relazione all’ordinamento. Per contro, la giurisprudenza sociologica vede il diritto come fenomeno essenzialmente sociale e secondo questa concezione non ci sono barriere epistemologiche tra essere e dover essere (entrambi i termini interagiscono e la conoscenza del primo è una condizione primaria per la conoscenza dell’altro). Anche Kelsen riconosce che il diritto è un fenomeno sociale ma nell’ottica di attribuire un significato giuridico a determinati comportamenti. L’efficacia è una condizione della validità, ma non è la validità stessa. Dalla distinzione analitica compiuta dalla dottrina pura (Kelsen) dei concetti di validità, efficacia e giustizia, si possono formulare alcune proposizioni: 1. Una norma può essere giusta ma non valida: secondo una determinata ideologia se una norma è giusta, ma non viene posta in vigore dall’ordinamento giuridico vigente...
Similar Free PDFs

Appunti di Filosofia del diritto
- 83 Pages

Diritto DI FUGA - RIASSUNTO
- 2 Pages

Riassunto di Diritto Penale - Palazzo
- 129 Pages

Diritto di Famiglia riassunto breve
- 14 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu