Definizioni Manuale di narrativa PDF

| Title | Definizioni Manuale di narrativa |
|---|---|
| Author | dave 19 |
| Course | Semiotica |
| Institution | Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM |
| Pages | 17 |
| File Size | 219.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 58 |
| Total Views | 159 |
Summary
definizioni del libro di narrativa del corso di semiotica...
Description
Tre focalizzazioni (Genette): 1. Focalizzazione zero o racconto non focalizzato : narratore onniscente che consoce tutto della storia e sa più dei personaggi di cui parla. Si muove nel tempo e nello spazio, anche in luoghi lontani da cui si svolge azione principale. Narratore che palesa propria presenza nel testo (Alessandro Manzoni, Promessi Sposi). 2. Focalizzazione interna : punto di vista è quello di un personaggio, narratore dice solo ciò che sa questo personaggio. Mind Style → peculiarità lessicali e sintattiche assoziate a certi personaggi suggeriscono un particolare modo di pensare. Linguaggio che imita in modo implicito la mente di un personaggio. Tre sottocategorie di focalizzazione interna: 1) focalizzazione interna fissa → punto di vista di un solo personaggio per tutta narrazione. 2) focalizzazione interna variabile → narrazioni che impiegano più di un riflettore (Madame Bovary). Tipo di focalizzazione tipica del romanzo contemporaneo, consente di vedere di più. 3) focalizzazione interna multipla → stesso evento viene narrato più volte, ma attraverso riflettori diversi. 3. Focalizzazione esterna : punto di vista è quello di un narratore esterno nascosto che sa meno dei personaggi, che agiscono senza che noi siamo ammessi a conoscerne sentimenti e pensieri (Hemingway, Colline come elefanti bianchi). La narratologia è la branca della semiotica interessata a capire che cosa fa di un testo un testo narrativo. Termine introdotto da Tzvetan Todorov (1939-2017) alla fine degli anni Sessanta Narrative Turn: A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, in seguito alla cosiddetta “svolta narrativa”: apporti del cognitivismo, delle neuroscienze e degli studi sull’intelligenza artificiale. ü storytelling come processo cognitivo, uno strumento di pensiero, per cui l’interesse si è rivolto verso i procedimenti mentali del soggetto che produce o fruisce un testo narrativo. • Apporti scientifici come strumenti di descrizione e classificazione. LO STUDIO SULLE FIABE DI MAGIA DI V. PROPP • Propp analizza le strutture narrative di un insieme specifico e limitato di testi composti da un centinaio di fiabe appartenenti alla tipologia delle fiabe di magia. • Raccolta di fiabe russe realizzata da Aleksandr Afanas’ev (1826-18719, scrittore e linguista russo, famoso folclorista russo dell'Ottocento. • Da questo insieme ristretto di racconti riesce a estrapolare un modello generale che sembra guidare la struttura della narrazione in ognuna delle fiabe prese in considerazione. • Il modello identificato da proprio è costituito dalla sequenza di sole 31 funzioni narrative. • Ogni funzione narrativa è la forma astratta o la tipologia di alcune più specifiche azioni LO SCHEMA ATTANZIALE DI GREIMAS ¢:Partendo da una tipologia delle sfere d’azione dei personaggi della fiaba di magia simile a quella di Grotto, il semiotico francese A. J. Greimas, negli anni 70, elabora un modello applicabile a qualunque forma di narrazione, e non solo allo specifico insieme delle fiabe studiate da Propp. Greimas: tentativo di generalizzazione de modello proppiano: a. le funzioni vengono ridotte (funzioni contrattuali, funzioni di comunicazione...) b. la teoria delle sfere d’azione viene riformulata in una struttura di attanti, ovvero tipi di personaggi agenti. Greimas cerca di adattare l’idea di Propp a tutti i tipi di narrazione (e non solo alla fiaba di magia russa). Ne risulterà uno schema più semplice e più flessibile, composto da funzioni meno numerose e più generali: lo schema narrativo canonico. Manipolazione, qualcuno fa fare qualcosa a qualcun altroCompetenza, qualcuno acquista l’abilità di fare qualcosaPerformanza: qualcuno fa qualcosaSanzione, chi ha compiuto l’azione è premiato, non premiato o punito.
La narratività è un processo orientato di trasformazione. La narrazione è alimentata da valori: Valori di base (esistenziali, utopici): preoccupazioni, ambizioni, desideri fondamentali dell’esistenza (ad es., la ricchezza, l’amore, la fede). Possedere l’oggetto significa, soprattutto, realizzare se stessi rispetto a quel valore, riconoscere la propria identità. Valore d’uso (utilitari, pratici): un oggetto ha un valore d’uso essenzialmente quando serve a fare qualcosa, quando è utile a compiere determinate azioni che, più o meno direttamente, ci permettono di realizzare il nostro progetto (o programma narrativo) principale storia = contenuto o concatenarsi di eventi (azioni e avvenimenti) insieme a quelli che possono essere chiamati gli esistenti (personaggi, elementi dell’ambiente) ¢ discorso = i mezzi espressivi con cui è raccontata la storia [Chatman 2003] L’analisi del discorso narrativo secondo Gérard Genette: tempo, modo e voce ¢ la teoria del tempo riguarda le possibilità di manipolazione temporale (ordine, durata, frequenza) la teoria del modo analizza la regolamentazione delle informazioni narrative (a) i modi di presentare l’azione, il discorso e il pensiero (b) i modi di selezione e di restrizione delle informazioni comunicate da una narrazione (in particolare la focalizzazione) la teoria della voce si occupa del narratore, dei livelli narrativi e della scelta della persona grammaticale Voce: extradegietica (atto narrativo che istituisce) Intradiegetico (atto narrativo viene mostrato) Eterodiegetico (assente da storia che racconta) Omodiegetico presente come persoaggio secondario Autodiegetico, narratore De Saussure, padre dello strutturalsimo, struttura del linguaggio Modello di Jakobson:- I l mittente, chi invia un messaggio; - il destinatario (o interlocutore, o ricevente) del messaggio; - il contesto, cioè la situazione in cui il messaggio viene inviato; - il codice, ossia la forma del messaggio (parole/ linguaggio, gesti, immagini, suoni od altro) che deve essere comprensibile al mittente e al destinatario, altrimenti non si riesce a comunicare: se mi parlano in cinese, io probabilmente non capirò nulla, perché non conosco il codice di questa lingua; - il canale che consente di stabilire la comunicazione e di mantenerla (il linguaggio orale o scritto, la vista… ma anche il telefono, la connessione ad internet, la pellicola di un film, un canale televisivo…); il messaggio, che è il contenuto della comunicazione, quello che viene espresso e recepito Messaggi televisivi di carattere casuale e internzionale Funzioni linguaggio verbale
La funzione referenziale , definita anche denotativa o cognitiva, è orientata verso il r e f e r e n t e (o contesto), ossia verso la realtà extralinguistica; i messaggi prodotti in conformità a questa funzione tendono a trasmetterci una informazione, una asserzione su un contenuto dell'esperienza, sia concreta (ad es. "oggi piove") sia mentale (come quando si dice "la felicità non esiste") sia persino immaginaria ("i marziani sono verdi"). La funzione emotiva (o espressiva) è invece indirizzata verso l'e m i t t e n t e , del quale proietta in primo piano una determinata emozione ovvero l'atteggiamento rispetto a ciò di cui si parla ("Sono stanco. Non ce la faccio più!"; "Come sei elegante!"; "Che angoscia!"). Dal punto vista delle strutture formali, gli enunciati in cui prevale la funzione emotiva si caratterizzano per la frequenza di frasi esclamative, interiezioni ecc. La funzione conativa (o persuasiva) è orientata verso il d e s t i n a t a r i o . Sono messaggi essenzialmente conativi quelli che trovano espressione grammaticale in frasi imperative ("Fai presto!"; "Alzati!"), esortative ("Su, usciamo!") o nel vocativo ("Ma ti prego, cara, accetta questo regalo!"). La persona verbale tipica di tale funzione è la seconda; ma possono aversi anche tecniche comunicative indirette che comportano altre strategie ("non sarebbe male se chiudessimo il finestrino"). La funzione fatica o di contatto, si esplica in messaggi, privi di autentica carica informativa e referenziale, che servono essenzialmente per stabilire, prolungare e mantenere o anche riattivare la comunicazione. Sono da considerare essenzialmente fàtici i convenevoli e gli enunciati di cortesia che si producono nelle comuni interazioni verbali (ad es. "ciao, come va?"; ted. "Schöner Tag heute", "So, auch schon auf" ecc.), gli attacchi di conversazione, in particolare quelli con cui si dà inizio ad una telefonata (it. "Pronto!"; ted. "Hallo, hören Sie mich?", o semplicemente "Hallo"), le formule rituali e vuote di significato come ho capito, da intendere alla stregua di un segnale che significa "ti sento, continua pure". La funzione metalinguistica si ha ogni qual volta il discorso è focalizzato sul c o d i c e ; il messaggio convoglia informazioni sulle strutture linguistiche, fa del codice stesso l'oggetto della comunicazione, esempio vocabolari La funzione poetica (o estetica) si individua in quelle produzioni verbali nelle quali l'accento sia posto sul m e s s a g g i o per se stesso. E' da far rilevare, in linea con le concezioni di Jakobson, che la funzione poetica si ritrova non solo in poesia, dove certo tale funzione predomina, ma anche all'infuori della poesia, ogni qual volta cioè si desideri produrre un enunciato stilisticamente ricercato ed esteticamente efficace. Rientrano dunque a pieno titolo in tale funzione i moderni spot pubblicitari e in generale promozionali, le poesia Formalismo 1900, russi studiano narratologia, “esercizi di stile”. Vladimir propp studia fiabe Modello Greimas 1. soggetto (colui che compie l’azione 2. oggetto (che è la meta dell’azione) 3. aiutante (che aiuta il soggetto) 4. opponente (che ostacola il soggetto) 5. destinante (che è il mandante del soggetto all’inizio della narrazione) 6. destinatario (a cui viene affidato alla fine l'oggetto o attante finale della comunicazione) storia= concatenarsi eventi
discorso= mezzi espressivi per raccontare 1)Ordine Anacronia: Tradizione letteraria occidentale è caratterizzata da anacronie (es. inizio in medias res dell'Iliade, che costringe Omero a tornare indietro nel tempo). L'anacronia può avere funzione completiva (segmento testuale finalizzato a colmare lacuna anteriore o posteriore del racconto) o funzione ripetitiva (racconto torna sui propri passi entrando in ridondanza con se stesso, per modificare fatto già avvenuto, rendendo significante quanto in precedenza non lo era. In base al rapporto tra il loro contenuto narrativo e quello della storia principale, anacronie possono manifestarsi nella forma di anacronia omodiegetica (fondata sulla medesima linea d'azione del racconto principale) o anacronia eterodiegetica (contenuto narrativo diverso da quello del racconto primo Sillessi : raggruppamento di situazioni ed eventi governato non da principio cronologico ma da parentela tematica, spaziale o d'altro genere. 2)Durata: indica quanto tempo e frasi e pagine l'autore impiega per raccontare un fatto. Variazioni di essa possono essere usate per mostrare quali eventi narrativi siano più importanti rispetto ad altri. Scena narrata brevemente è minore rispetto alla scena narrata diffusamente. Il tempo della storia può essere specificato, mentre quello del discorso è più difficile da misurare. Isocronia: uguaglianza della durata della storia e del discorso. Impossibile. Anisocronia: variazione della velocità narrativa, ovvero accellerazione o rallentamento sull'asse del tempo secondo cinque principali modalità: • Ellissi → destinatario del messaggio costretto a tentare di ricostruire significato di un enunciato o attendere che esso sia chiarito dopo (ambiguità). Ellissi temporale → tecnica narrativa che consiste nel tacere fatti avvenuti in un determinato arco cronologico, perciò tempo del racconto è inferiore rispetto a tempo della storia, mentre ritmo narrativo subisce accellerazione. 1) ellissi esplicita: indicazione del lasso di tempo eliso. 2) ellissi implicita: presenza non è dichiarata ed è inferibile solo dal lettore. • Sommario → quando un testo narrativo breve corrisponde a un tempo narrato relativamente lungo. Nel cinema si chiama montage sequence, serie di rapide inquadrature che mostrano aspetti selezonati di un evento. • Scena → quando vi è una qualche equivalenza tra un segmento del racconto e il narrato che esso rappresenta. Il romanzo modernista è in questo caso più filmico, anche se è sbagliato dire che sia cambiato per influsso del cinema. • Estensione → tempo del racconto è più lungo del tempo della storia. Tipico delle narrazioni novecentesche, soprattutto film. Resa attraverso slow motion nel cinema. Nel romanzo → parole possono essere ripetute o parafrasate. • Pausa → una parte del tempi narrativo corrisponde a un arresto del tempo della storia, racconto si ferma. Quasi impossibile nelle narrazioni filmiche → in questo caso viene usato il quadro fisso. 3)Frequenza narrativa riguarda le relazioni di ripetizione tra numero di volte in cui si presume che eventi siano accaduti e numero di volte in cui essi sono narrati. Si può distinguere tra:
• Racconto singolativo : raccontare una volta sola quanto è avvenuto una sola volta. • Racconto singolativo multiplo : raccontare N volte quanto è accaduto N volte. • Racconto ripetitivo : raccontare N volte quanto è avvenuto una volta sola. • Racconto iterativo : raccontare una volta sola quanto è avvenuto N volte. Flaubert in Madame Bovary usa iterazione per sottolineare monotonia della vita di Emma. Effetto Kulesov, montaggio film influenza percezione Floch divide valori di base (preoccupazioni, desideri) e d’uso (funzione di un determinato oggetto) STORYTELLING:h capacità di elaborare narrazioni Capitolo 1 Le narrazioni iniziano ad essere indagate tra gli anni 60 e 70 grazie alla Scuola di Parigi. Intenti → identificare le unità minimali delle narrazioni e creare una grammatica universale del racconto. Risultato: ogni storia finiva per assomigliare alle altre, non si percepiscono elementi differenziali. Negli anni 90 lo studio delle narrazioni imbocca una nuova strada → cognitivismo + neuroscienze + studi sulle intelligenze artificiali danno vita a una collaborazione pluridisciplinare. Gli studiosi di letteratura assumono un ruolo minore rispetto al passato. Cognitivisti si rendono conto che la nostra mente si fonda su connessione crono causale di episodi, cioè narrazioni in cui impariamo a: • Correlare eventi secondo rapporti di causa effetto • Interpretare un fatto esterno come motore di un cambiamento interiore • Rapportare la nostra evoluzione interiore al contesto in cui agiamo Neuroscienziati osservano che quando osserviamo qualcosa, lo classifichiamo sulla base di un confronto con un modello stereotipico, derivato da esperienze registrate nella memoria → ogni nuova esperienza viene valutata sulla base della sua conformità o difformità rispetto a uno schema pregresso. Bruner divide: Pensiero paradigmatico: tipico dell’ambito scientifico, imperniato sulla definizione di concetti astratti Pensiero narrativo:è di tipo sequenziale, connessioni temporali che consentono di fotografare realtà Schema, frame: etichette che diamo a porzioni dinamiche di esistenza Script : microsceneggiatura, processi dinamici, come si verificano sequenze e eventi. situazionali, personali, strumentali Componenti essenziali narrazione: setting, intenzione,risposta interna , fattore causale, obiettivo, azione, reazione Controfattualità : immaginare le cose che non ci sono (Mind reading), teoria della mente: capacità di leggere intenzioni di un individuo. (emozionale: stati emotivi. Cognitivo; intenzioni), Narrazioni mainstream si fondano su storia, d’autore sul discorso.
Pecma: percezioni delle emozioni, cognizioni, propensioni ad agire a motor action. Bloccato dal melodramma Life narrative: memoria autobiografica (2-3anni), teoria della mente (3-4),grammatica della storia (5-6), copione culturale (10-14), ragionamento autobiografico e abilità di narrazione (12-25) Età: 2-3 attore, presente,capacità di autocontrollo,vincoli comportamentali. 7-9 agente, futuro, autostima, vincoli motivazionali. 15 in poi autore,passato, auto continuità, vincoli narrativi. Capitolo 2 La voce è l'insieme di attributi che caratterizza l'istanza narrativa → relazione tra narratore e storia da lui narrata. Deve essere distinta dalla focalizzazione, dalla prospettiva e dal punto di vista (che offrono informazioni su chi vede). Si va dal polo negativo della pura mimesi (storia non narrata o narrata in modo minimale secondo molteplici forme) al polo positivo della pura diegesi (narratore parla con la propria voce, dà interpretazioni e valutazioni palesandosi in quanto tale). Diegetico: livello storia, narratore primo grado, Extradiegetico, livelo discorso. Secondo grado, esterno al racconto, simile all’autore reale Autenticazione diadica, graduata, uso improprio Personaggio, tre paradigmi: modello semantico (funzionale, nello story world, proprietà umane), cognitivo (flat character, round character), comunicativo (LA FONTE INFORMATIVa è l’affermazione che si attribuisce all’individuo. Lettore, narratario, lettore implicito Cinque codici del movimento del lettore: preferenziale, proairetico, semico, simbolico, ermeneutico, + meta codice Narratario: destinatario storia Orizzonte d’attesa, aspettative dei lettori in base a cui giudicano testi Evento, cambiamento di stato nel discorso narrativo PARATESTO: epitesto (elementi esterni come interviste)+ paratesto (elementi interni come titolo, note), elementi che contornano e prolungano testo Exergo, motto o citazione a inizio testo Incipit: zona d’apertura del testo vere e proprio. È diverso dall’apertura .narrativi, descrittivi, commentativi Explicit: segmento conclusivo di un plot o di un’azione Chiusura= soddisfazione di domande aperte durante la narrazione Incastonatura o embending: combinazione di sequenze narrative una posta dentro l’altra
Metalessi= narrare cambiando livello, discendente e ascendente Capitolo 3 Architesto. Architestualità= relazione del testo col suo architesto Forme semplici di Jolles: • Leggenda → nasce nel 13° secolo per narrare la vita di un santo per indicare che ogni esistenza individuale vale solo nella misura in cui può fungere da modello esemplare di cristianità e di capacità di dare luogo a eventi straordinari. (Età moderna → record, da recordari → impresa straordinaria, degna di essere ricordata). • Saga (o Leggenda Profana) → si riferisce a eventi significativi in termini di clan, famiglie, stirpi, è sempre connessa a movimenti intra o internazionali di gruppi etnici o culturali → in tempo di crisi funge da coagulante sociale attraverso l'attivarsi di meccanismi quali il vincolo di parentela, vendetta del sangue, faida ecc. • 1800 vasto numero di romanzi genealogico familiari per conservare la memoria di una coesione comunitaria che avrebbe rischiato di andare perduta. Età moderna → Soap Operas . • Mito → non prescinde mai dall'intervento di un oracolo dotato di forza predittiva, sua funzione è dare risposta a domande che uomini si pongono riguardo realtà terrena. • Memorabile → resoconto di un fatto saliente attraverso il ricorso a dettagli concreti che garantiscono autenticità di ciò che è stato narrato. • Fiaba → dà al lettore un senso di sognante soddisfazione per il fatto che tutto procede come dovrebbe se la realtà fosse perfetta. narrazione breve in prosa, origine popolare o letteraria, no intenzioni etico didascaliche della favola, personaggi e azioni non verosimili. Però possono esserci fiabe lunghe (rielaborazioni) e in versi. Difficile ricostruire origini del genere fiabesco: molteplici teorie. Fiaba si sviluppa in Francia a fine 600 e in Germania tra il 700 e l'800. In Germania la fiaba si sovrappone alla novella, così Wieland traccia linea di demarcazione tra le due: • Novella → mondo concreto e reale che ci circonda, tendenza umana verso la verità. • Fiaba → tendenza dell'uomo verso verità ma anche verso prodigio. In Italia il genere della fiaba ci mette di più ad arrivare. Tra 800 e 900 → la fiaba acquista importanza, anche se l'attenzione viene posta sul personaggio più che sull'azione → ricombinazioni nuove. Fiaba → entra anche nel mondo dei fumetti, film, videogiochi ecc. • Scherzo → forma di storytelling che sovverte le restrizioni del linguaggio, della logica e dell'etica per liberare da ogni inibizione. Età moderna → Parodia. Punto di vista, inteso come luogo fisico, ideologia e psicologia attraverso cui vengono presentati personaggi. Nel cinema c’è oggettiva, soggettiva e semi soggettiva Sguardo, atto del vedere fonadato sulla cos...
Similar Free PDFs

Definizioni Manuale di narrativa
- 17 Pages

Relazione di narrativa
- 9 Pages

Manuale di Didattica Generale
- 37 Pages

Breve manuale di retorica
- 33 Pages

Manuale di Diritto Commerciale
- 103 Pages

Manuale Di Restauro
- 29 Pages

Manuale di economia pubblica
- 2 Pages

Manuale Prontuario di punteggiatura
- 109 Pages

Manuale DI Disegno Infantile
- 24 Pages

MANUALE-DI-GLOTTODIDATTICA
- 1 Pages

Manuale di rilievo (2)
- 21 Pages

Manuale di linguistica italiana
- 33 Pages

Riassunto manuale di biblioteconomia
- 22 Pages
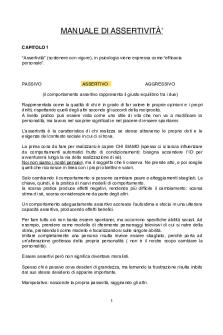
Manuale di assertività
- 21 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

