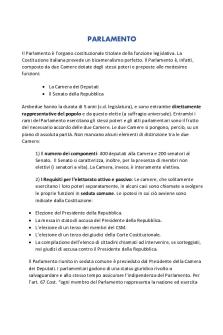Diritto - Ottimo riassunto per passare esame brillantemente con la faleri. PDF

| Title | Diritto - Ottimo riassunto per passare esame brillantemente con la faleri. |
|---|---|
| Course | Diritto del lavoro privato |
| Institution | Università degli Studi di Siena |
| Pages | 82 |
| File Size | 1.4 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 301 |
| Total Views | 638 |
Summary
LEZIONE 1 – INTRODUZIONESi parla di UTILIZZAZIONE INDIRETTA DEL LAVORO quando il datore di lavoro utilizza una prestazione di lavoro senza assumere quel lavoratore. Si fa riferimento agli strumenti della somministrazione, del distacco, dell’appalto e del sub-appalto.Si parla di ACQUISIZIONE INDIRETT...
Description
LEZIONE 1 – INTRODUZIONE Si parla di UTILIZZAZIONE INDIRETTA DEL LAVORO quando il datore di lavoro utilizza una prestazione di lavoro senza assumere quel lavoratore. Si fa riferimento agli strumenti della somministrazione, del distacco, dell’appalto e del sub-appalto. Si parla di ACQUISIZIONE INDIRETTA DEL LAVORO quando si fa riferimento al datore di lavoro che acquisisce un ramo d’azienda ceduto e quindi indirettamente acquisisce anche il personale destinato al ramo stesso. Qui si parla di acquisizione poiché i lavoratori diventano dipendenti dell’azienda che ha acquisito il ramo d’azienda ed è indiretta perché non è stato stipulato un contratto di lavoro individuale ma prosegue il vecchio contratto di lavoro. Vi è soltanto un cambio del datore di lavoro, il quale subentra nella titolarità del rapporto di lavoro. CONTESTO DI RIFERIMENTO Con decentramento produttivo si intende un fenomeno aziendale che caratterizza il mondo delle aziende private cioè, mentre prima l’azienda svolgeva al suo interno l’intero ciclo produttivo (Modello Fordista) quindi aveva mansioni deputate a tutte le funzioni interne dell’azienda, ora le aziende tendono ad esternalizzare. A seguito della maggiore competitività del mercato globale le aziende per essere più competitive hanno avvertito la necessità di concentrarsi e specializzarsi su quello che è il segmento del ciclo produttivo in cui è più forte. Tale segmento può essere sia il Core business sia un altro segmento del ciclo produttivo. Specializzarsi significa che si va ad esternalizzare, quindi a cedere quelle parti dell’azienda che non sono necessarie per lo svolgimento dell’attività principale alla quale l’azienda decide di dedicarsi. Questo significa che porrà in essere dei contratti di cessione di parti dell’azienda e contestualmente verranno ceduti i lavoratori che operano nei reparti interessati dalla cessione contrattuale, quindi saranno interessati da quello che si chiama Trasferimento d’azienda o di Ramo d’azienda. Come scelta strategica Il decentramento può avvenire Per motivi economici Il fenomeno del decentramento produttivo può essere legato a ragioni organizzative reali, quindi può essere un fenomeno fisiologico, cioè l’azienda per mantenersi competitiva sul mercato avverte la necessità di concentrarsi su un segmento del processo produttivo. Il decentramento può essere legato anche a ragioni economiche, cioè di riduzione dei costi, in particolare dei costi del personale, sia nel caso in cui l’impresa versi in stato di crisi e sia nel caso in cui voglia semplicemente ridurre i costi. Il decentramento può presentarsi anche come un fenomeno patologico, cioè l’azienda decide di esternalizzare una parte del ciclo produttivo che comporta la cessione dei lavoratori, ma avendo ancora bisogno di quelle mansioni l’azienda è portata ad interiorizzare gli stessi lavoratori non come lavoratori dipendenti ma attraverso gli strumenti di utilizzazione indiretta del lavoro. Gli strumenti sono:
1
•
Trasferimento d’azienda
•
Contratto di somministrazione
•
Contratto di appalto interno
•
Distacco
Acquisizione indiretta Utilizzazione indiretta
IL RAPPORTO DI LAVORO Dietro le fattispecie di acquisizione e utilizzazione si parla di rapporti di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e un lavoratore. Quando si parla di acquisizione indiretta, come nel caso di trasferimento di ramo d’azienda, il rapporto di lavoro si mantiene come rapporto giuridico e si ha solo un subentro del nuovo titolare dell’azienda nella titolarità del rapporto. Nel caso di utilizzazione indiretta ci son più casi: ✓ Nel contratto di somministrazione il rapporto di lavoro è tra l’agenzia di somministrazione (che assume la veste di datore di lavoro) e il lavoratore, il quale verrà mandato a svolgere la propria prestazione presso l’impresa che lo ha richiesto. ✓ Nel distacco, il lavoratore distaccato è dipendente dell’impresa distaccante quindi non ha nessun rapporto con l’impresa distaccataria cioè quella che utilizza la prestazione. ✓ Nell’appalto, il lavoratore è dipendente dell’impresa appaltatrice la quale invia (anche fisicamente) il lavoratore a svolgere la propria attività nell’impresa che lo utilizza. Il rapporto di lavoro tradizionale è bilaterale (datore di lavoro – lavoratore). Il datore di lavoro assume il lavoratore e ne utilizza la prestazione lavorativa. Nell’utilizzazione indiretta del lavoro si parla, invece, di rapporto di lavoro trilaterale in cui è presente: 1. Il lavoratore che svolge la prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro (agenzia di somministrazione, impresa distaccante o appaltatrice) ma a favore di un terzo soggetto rispetto al rapporto duale di lavoro; 2. L’utilizzatore, che è colui che beneficia della prestazione di lavoro senza assumere la veste di datore di lavoro. Viene stipulato un contratto di fornitura tra l’utilizzatore e l’impresa fornitrice di manodope 3. Il fornitore di manodopera. Detto anche datore di lavoro o somministratore, è il soggetto che si interpone tra il lavoratore e l’utilizzatore. Nello specifico, il somministratore assume il lavoratore per poi inviarlo a svolgere la sua prestazione lavorativa presso l’utilizzatore.
LEZIONE 2 – LA SOMMINISTRAZIONE IL FENOMENO DELL’INTERPOSIZIONE Il fenomeno dell’interposizione (somministrazione, distacco e appalto) che vede coinvolto un soggetto terzo, non ha sempre avuto un approccio uniforme da parte del legislatore, così come in generale il fenomeno del decentramento.
2
Questo inizialmente è stato visto in modo negativo dal legislatore nel senso che l’approccio verso questi strumenti era considerato come un fenomeno patologico dei rapporti di lavoro. Patologico nel senso che il legislatore presumeva che l’impresa che ricorreva a tali strumenti negoziali lo faceva con finalità elusiva, cioè per eludere le norme protettive del diritto del lavoro (norme che trovano applicazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato e che determinano a capo del datore di lavoro una serie di costi economici e normativi), o meglio per eludere il costo del lavoro. Costo economico = costo retributivo, contributivo e assicurativo Costo normativo = consiste nel dover applicare la disciplina limitativa del diritto del lavoro (disciplina limitativa del potere di licenziamento). Costo del lavoro = costo economico + costo normativo Questo approccio da parte del legislatore è cambiato a partire dagli anni 2000. Questi fenomeni di interposizione vengono visti come un qualcosa di fisiologico cioè che caratterizza sempre di più il mercato del lavoro. Avendo però ancora bisogno di quelle fasi l’impresa si avvale di manodopera esterna per lo svolgimento di quelle attività che sono comunque necessarie ma sulle quali non intende investire in prima persona. Vengono quindi riconosciuti e regolamentati, cioè si riconosce l’esigenza dell’azienda di poter utilizzare manodopera esterna per soddisfare esigenze di efficienza organizzativa e di adeguamento, ma vengono legittimate a certe condizioni. DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE L’approccio dell’interposizione parte da un divieto sancito dalla legge n.1369 del 60 che stabiliva un divieto assoluto di interposizione e di intermediazione di manodopera, intendendo per interposizione i fenomeni in cui un soggetto terzo si interpone tra lavoratore e datore di lavoro e per intermediazione di manodopera i casi in cui un soggetto terzo si interpone tra domanda e offerta di lavoro. Sulla base del divieto di intermediazione nel nostro ordinamento fino alla fine degli anni 90 è rimasto in vigore il sistema del monopolio pubblico del collocamento, nel senso che solo ad un soggetto pubblico veniva riconosciuta la legittimità a svolgere l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Questa legge sancisce il divieto in modo assoluto, poiché si voleva contrastare un fenomeno ancora diffuso, ossia il caporalato, caratterizzato dal fatto che un soggetto terzo svolgeva attività di intermediazione assumendo anche direttamente il lavoratore per mandarlo poi a lavorare presso altre aziende. Ciò che si voleva impedire era di consentire a dei soggetti terzi di lucrare sull’attività di interposizione e di intermediazione. L’art 4 della Cost. sancisce il diritto al lavoro quindi è compito dello Stato favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed è per questo che per decenni è stata contrastata l’attività di intermediazione privata e di interposizione. Precisazione: questo divieto è stato possibile perché nel contesto giuridico ancora non si era formata la normativa protettiva del lavoro (sviluppatasi intorno agli anni 60 -70). Nel 1970 con l’adozione della legge 300 dello statuto dei lavoratori si è assistito ad una costruzione sempre più rigida dell’apparato di tutela del lavoratore. Quando negli anni 80 e 90 la crisi economica ha
3
iniziato a tradursi in crisi occupazionale il legislatore ha iniziato a vedere in modo diverso i fenomeni interpositori. Per favorire maggiori opportunità occupazionali alla fine degli anni 90 è stata emanata la legge 196 del 97 chiamato pacchetto TREU che riguarda l’intero mercato del lavoro. Viene introdotta per la prima volta una deroga in materia di interposizione. Deroga significa che si mantiene in vigore la legge 1369 del 60 e quindi il divieto di interposizione di manodopera, però si viene a prevedere in via eccezionale il lavoro temporaneo o lavoro interinale, chiamato così perché caratterizzato da una temporaneità della prestazione lavorativa. La ratio di questa deroga consiste nel fatto di voler favorire un maggior numero di opportunità occupazionali a tempo temporaneo. Il legislatore autorizza questa forma di interposizione di manodopera stabilendo dei requisiti riguardo al soggetto interpositore (fornitore di manodopera). Tali requisiti sono: •
il soggetto interpositore non può essere una persona fisica ma deve essere una persona giuridica (società di capitali o una cooperativa);
•
deve avere un certo capitale versato, in grado di garantire una copertura economica per il lavoratore;
•
requisiti di onorabilità degli amministratori;
•
rispetto della normativa sulla privacy;
•
la società deve avere la sede legale in Italia o nel territorio di un paese dell’UE.
La legge 196 richiede anche altri 2 principi: 1. IL PRINCIPIO DELLA GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE. Cioè che il soggetto che svolge attività di intermediazione non chieda niente al lavoratore. La sua fonte di guadagno deve derivare dal rapporto di lavoro che ha con l’utilizzatore. 2. IL PRINCIPIO DELL’OGGETTO SOCIALE. Cioè le società che svolgono attività di fornitura di manodopera devono avere come oggetto sociale esclusivamente questa attività di fornitura di manodopera, non possono fare altro. Soltanto laddove siano verificati tutti i requisiti l’agenzia di fornitura potrà ricevere l’autorizzazione amministrativa e solo in quanto autorizzato dal ministero il soggetto potrà svolgere l’attività di intermediazione. In particolare, l’agenzia richiede l’autorizzazione che viene concessa inizialmente in modo temporaneo per 2 anni, dopo questo periodo viene effettuato un controllo da parte del ministero per verificare se l’attività è stata svolta nel rispetto delle norme di legge. Se l’esito è positivo l’autorizzazione diventa definitiva salvo cause di revoca. Nel dicembre del 1997 vengono emanati una serie di decreti che legittimano l’intermediazione privata. Interposizione ed intermediazione rimangono però fortemente separate, cioè i soggetti possono dedicarsi esclusivamente ad una delle due procedure. Il passaggio successivo riguarda il dlgs 276 del 2003 (Legge Biagi) con il quale si inizia a parlare di somministrazione di manodopera. Questa è una legge di riforma del mercato del lavoro ed è caratterizzata da un approccio diverso nel senso che la legge 196 del 97 veniva ad ammettere il lavoro interinale per finalità occupazionali, ma comunque considerava in modo negativo il fenomeno dell’interposizione. Ecco che con il decreto del 2003 cambia proprio questo aspetto
4
cioè i fenomeni di interposizione non vengono più visti in modo negativo. Viene, infatti, formalmente abrogata la legge 1369 del 60 e i fenomeni di interposizione e di intermediazione vengono legittimati regolamentandoli, cioè ponendo dei limiti a tutela del lavoratore senza che questi siano al tempo stesso ostativi all’attività dell’azienda di utilizzare questi strumenti contrattuali. Con il decreto 276 viene meno il criterio dell’esclusività dell’oggetto sociale perché dopo la legge del 97 questo requisito aveva di fatto impedito la diffusione delle agenzie di lavoro interinale. Il venir meno di questo requisito significa che oggi il soggetto che svolge attività di interposizione di manodopera è legittimato a svolgere anche attività di intermediazione, attività di ricerca del personale e di formazione, in pratica gli vengono riconosciute tutte quelle attività che sono tra loro strettamente collegate. Il requisito della gratuita permane per l’attività di interposizione ma non opera per altre attività come ad esempio l’attività di formazione in quanto la formazione dei lavoratori in base alle esigenze del mercato non è gratuita quindi si viene indirettamente a legittimare una forma di guadagno dell’azienda somministratrice nei confronti dei lavoratori stessi. La fattispecie della somministrazione è stata poi oggetto di ulteriori riforme. Gli ultimi interventi legislativi ossia il Decreto 81 del 2015 (pacchetto Jobs Act) e il Decreto 8 del 2016 sono intervenuti riguardo alla legittimazione dei requisiti di legittimità dell’attività di interposizione dal profilo sanzionatorio. Ciò significa che quando non vengono rispettati i requisiti di interposizione si parla di interposizione illecita e questo configura sia un illecito civile che penale. Dal punto di vista civile succede che se il soggetto che svolge attività di somministrazione, la svolge violando le norme di legge, ciò comporta che l’attività svolta si considera illegittima e quindi si considerano nulli i contratti di lavoro da lui stipulati perché non poteva svolgere l’attività di interposizione. L’effetto civile consiste nel fatto che il contratto di lavoro viene imputato direttamente in capo all’utilizzatore, questo viene quindi giuridicamente riconosciuto come datore di lavoro, come se il rapporto fosse nato direttamente tra colui che svolge l’attività lavorativa e colui che ne beneficia. Qui trova applicazione una deroga a una regola generale poiché solitamente nei rapporti di lavoro non viene riconosciuta nessuna validità ad atti di gestione del rapporto di lavoro posti in essere da soggetti terzi. È come se l’interposizione non ci fosse mai stata e il rapporto fosse nato direttamente tra lavoratore ed utilizzatore. Dal punto di vista penale la legge 1369 del 60 prevedeva delle sanzioni penali nei confronti sia dell’impresa somministratrice quando svolgeva l’attività di interposizione senza avere i requisiti di legge, oppure per chi svolgeva tale attività prima del 97 (poiché fino a quel momento era vietata), sia nei confronti dell’impresa utilizzatrice nell’ipotesi di somministrazione fraudolenta cioè laddove si fosse riscontrata in capo all’utilizzatore una volontà specifica di rivolgersi ad un soggetto non legittimato all’attività di interposizione per volontà di eludere norme di legge. L’interposizione illecita come reato penale è venuto meno con il decreto 81 del 2015 il quale ha completamente abrogato l’art 28 della legge 276 del 2003 che rinnovava la configurazione dell’interposizione illecita come illecito penale e successivamente il decreto 8 del 2016 che ha totalmente depenalizzato la materia delle esternalizzazioni. Oggi la sanzione penale è stata
5
sostituita con una sanzione amministrativa (cioè dal pagamento di una multa). La configurazione dell’illecito penale è rimasto solo nel caso in cui il fenomeno interpositorio coinvolge dei minori. Oggi quindi, in caso di interposizione illecita abbiamo una coesistenza della sanzione civile e della sanzione amministrativa. Questa coesistenza si ammette perché perseguono finalità diverse: ✓ la sanzione civile viene a tutelare il lavoratore al quale viene garantito il suo rapporto di lavoro imputandolo direttamente a colui che utilizza la prestazione; ✓ la sanzione amministrativa persegue un interesse pubblico, cioè quello di garantire che l’attività di interposizione ma anche di intermediazione avvenga nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge.
LEZIONE 3 SOMMINISTRAZIONE COME DEROGA AL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE. La somministrazione è una fattispecie interpositoria riconosciuta come una deroga legittima al divieto di interposizione stabilito dalla legge 1969 del 60. È la prima forma di interposizione legittima, pur mantenendo il divieto di interposizione. Quest’ultimo si deve considerare come una regola generale del rapporto di lavoro che si sostanzia in una regola di trasparenza, dal momento che il fine ultimo è contrastare il fenomeno di caporalato. In quanto principio generale continua ad affermarsi nonostante l’abrogazione della legge. Inizialmente il legislatore parlava di fornitura di manodopera in riferimento alla somministrazione ed è la prima volta che si parla di deroga al divieto di interposizione. La prima deroga è stata introdotta con la legge 196 del ‘97 (pacchetto Treu). Tale legge non interviene in modo specifico sul tema della somministrazione ma è una legge di riforma del mercato del lavoro. È la prima legge generale in tema di riforma del mercato del lavoro, fino a quel momento c’erano stati solo interventi mirati per i diversi istituti giuridici. Tale pacchetto contiene diverse norme che disciplinano diversi istituti al fine di regolamentare il mercato del lavoro. Siamo alla fine degli anni ‘90 quando si avvertiva una forte esigenza di creare strumenti che favorissero una maggiore occupazione (anche temporanea). Il contratto a termine del ‘62 era una disciplina rigida e il datore di lavoro poteva stipulare contratti solo se venivano soddisfatti una serie di requisiti indicati dal legislatore stesso, quindi non aveva flessibilità nella gestione del proprio organico. Si avvertiva pertanto la necessità di aggiungere ulteriori strumenti giuridici al contratto a termine, la cui disciplina viene tra l’altro attenuata. Con la 196 del ‘97 si parla di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale). SOMMINISTRAZIONE COME FATTISPECIE DISCIPLINATA. Quando parliamo di somministrazione parliamo di una fattispecie interpositoria nella quale vi è l’agenzia di somministrazione di manodopera che si interpone tra chi offre manodopera (lavoratore) e chi chiede manodopera (l’impresa utilizzatrice). Questa fattispecie interpositoria si fonda dal punto di vista giuridico su due contratti, uno è quello che si istaura tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore, rapporto di lavoro subordinato, l’altro è quello tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione e si fonda su un contratto di natura commerciale trattandosi di un contratto di fornitura. Il lavoro interinale è stato disciplinato per la prima volta nel 97, detto lavoro
6
temporaneo perché l’agenzia di somministrazione poteva fornire il lavoratore all’impresa utilizzatrice solo temporaneamente, ovvero il contratto di fornitura poteva essere esclusivamente temporaneo/a termine. Questa fattispecie è stata legittimata per creare da un lato strumenti occupazionali e maggiori opportunità di lavoro a fronte di mancate assunzioni, e dall’altro poiché l’Italia era l’unico paese in Europa che non aveva questi strumenti.
PRIMO RAPPORTO. Riguarda il rapporto tra agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice, in cui la prima si assume un obbligo di fornire manodopera (non è un contratto di lavoro ma di fornitura/somministrazione). L’impresa chiede manodopera avente una serie di caratteristiche, l’agenzia la fornisce soddisfacendo tali richieste. Qualora la manodopera non sia in grado di svolgere l’attività lavorativa secondo le esigenze dell’impresa, questa può chiedere la so...
Similar Free PDFs

Schemi Diritto Tributario PER Esame
- 101 Pages

Risposte Esame Diritto Privato
- 8 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu