Il latino, periodi e stili, fonti del latino volgare PDF

| Title | Il latino, periodi e stili, fonti del latino volgare |
|---|---|
| Course | FILOLOGIA ROMANZA |
| Institution | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| Pages | 5 |
| File Size | 139.9 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 69 |
| Total Views | 145 |
Summary
Materiale di supporto allo studio del testo...
Description
IL LATINO PRIMA DEL LATINO La linguistica storico-comparativa raggruppa le lingue tramite leggi fonetiche in modo ricostruttivo cioè stabilendo per via ipotetica lo stato precedente a quello delle lingue osservate, dal punto di vista fonetico, morfologico, sintattico e semantico. Si punta a ricostruire il protoindoeuropeo. La romanistica congiunge e usa leggi fonetiche per congiungere diacronicamente le lingue romane con il latino. L'' indoeuropeo viene dall'India (e altri paesi dell'Asia) e dall'Europa. Sottofamiglie dell'indoeuropeo sono: germanico, slavo, baltico (oggi lituano e lettone), celtico (gallico continentale, impero romano, estinto, britannico insulare in galles, gaelico in Irlanda e in Scozia), ellenico (oggi greco moderno o neogreco), albanese (antico tracico, illirico), armeno, iranico (tra cui persiano), indiano (vedico e sanscrito antichi, oggi zingaro e altre), italico (diversi rami tutti estinti: umbro, sannitico, osco, ecc.; il latino è proseguito nelle lingue romanze). Le famiglie dell'indoeuropeo antiche ed estinte sono: ittita (Asia minore), tocario (Turkestan cinese), paleoveneto o venetico (da non confondere col dialetto veneto odierno che è una continuazione del latino) che è una lingua preromana. Lingue pre-romane: venetico, le lingue italiche diverse dal latino, greco (Italia meridionale e Sicilia), traco-dacico (Dacia romanizzata). Lingue pre-indoeuropee: iberica, aquitanica (oggi basco), ligure, si pensa a un paleo-sardo per la Sardegna. Quando in una lingua è presente un lessico che non è di origine latina e non è stato preso a prestito, si ipotizza che provenga da uno strato anteriore al latino. G. I. Ascoli attribuì al sostrato il ruolo di , ad esempio influenza la fonetica della lingua imposta con la propria, introducendo nella lingua dominante la propria pronuncia per reazione (es. il fonema /y/ del celtico nell'attuale francese e nei dialetti dell'Italia-settentrionale). Ma c'è bisogno di un lunga ricerca empirica. La gorgia toscana è stata giustificata come un'eredità dell'etrusco, ma è attestata solo agli inizi del Cinquecento. PERIODI E STILI DEL LATINO Le lingue romanze vengono dal latino VOLGARE, concetto che viene ripreso dagli umanisti e dal metodo storico-comparativo. Studio diacronico: dal latino arcaico a quello cristiano passano 8 secoli. In mezzo abbiamo la norma classica, che blocca o maschera lo sviluppo in atto, ma effettivamente l'evoluzione avviene. Studio sincronico: registri o stili. Cicerone fa un'opposizione di registro: plaebeius sermo, sermo familiaris (leggermente differente) e sermo vulgaris “lingua popolare”. Il latino volgare è il registro più basso della lingua usato dai ceti più bassi e da tutti gli altri per la comunicazione quotidiana: quindi era la lingua spontanea di tutti. FONTI DEL LATINO VOLGARE Le forme scorrette vengono chiamate volgarismi o romanismi. Tra le fonti di questi abbiamo: -Opere di grammatici latini, che illustrano le forme scorrette, ci danno informazioni a livello fonologico. Appendix Probi: dal punto di vista lessicale e fonetico è una raccomandazione a non usare certe forme, come ad es. la caduta della vocale post-tonica in calida, che diventa
calda. -Iscrizioni: le scritture occasionali rivelano la difficoltà di chi non conosce le forme ufficiali, come nei graffiti a Pompei e Ercolano, che riportano messaggi d'amore o ingiurie al nemico (cose quotidiane). Defixionum tabellae: iscrizioni contenenti formule magiche scritte su lamine di piombo che servivano a lanciare il malocchio a nemici e rivali. -Lettere: di privati, riportano faccende personali, rivelano un uso vivo e a volte scorretto della lingua. -Letteratura tecnica: artes, cioè discipline scientifiche e tecniche, ritenute inferiori a retorica, grammatica, matematica, geometria -Opere letterarie: commedie teatrali di Plauto e Terenzio lingua retoricamente meno elaborata e più vicina al parlato. Le epistole di Cicerone mostrano un latino familiare, diffuse tra il pubblico per il valore letterario. Satyricon Petronio: durante la cena di Trimalcione si parla il latino dei liberti arricchiti, è interessante per il lessico. Fra i testi cristiani: Vetus Latina: la più antica versione in latino della Bibbia, tradotta dal greco, umile e popolare. Vulgata di Girolamo, tradotta dal greco, latino popolare. Anche Agostino era recettivo nei confronti del latino popolare. Itinerarium Egeriae: pellegrinaggio di una monaca, Egeria, nei luoghi della Bibbia: ille e ipse qui e corrispondono a articolo romanzo. DAL LATINO TARDO AL LATINO MEDIEVALE Durante l'Altomedioevo il livello del latino scritto era molto basso. Nel IX secolo abbiamo dei miglioramenti grazie alla politica di Carlo Magno. Nel XIV secolo il latino conosce ripresa fortissima grazie agli umanisti. Ma ora cominciano a diffondersi i volgari. Dopo la fine dell'impero romano avviene la trasformazione dal latino al romanzo, approssimativamente nel V secolo. Il romanzo è già nato, ma verrà scritto secoli dopo. -Testi documentari, scritti in latino merovingio, leonese, longobardo presentano forme scorrette, termini lessicali locali, di carattere giuridico e pratico. -Opere storiografiche: da VI secolo in poi, abbiamo l'Historia Francorum di Gregorio di Tours e altre, caratterizzate da latino linguisticamente modesto ma letterariamente vigoroso. -Regole monastiche: di san Benedetto, 530 -Glosse: testimoniano già il primo romanzo, sono spiegazioni o traduzioni di parole o gruppi di parole → di Reichenau: su parole Bibbia (pulchra → bella), nord Franca VIII-IX; di Kassel, IX secolo: manualetto romanzo tedesco ad uso dei bavaresi diretti in Francia “tagliami i capelli”; X-XI emilianensi e silensi (santo Domingo de Silos): traduzioni a margini di parole latine che dovevano sembrare difficili (repente > lueco =sp. luego subito). INTERPRETAZIONE DELLE FONTI. ERRORI E IPERCORRETISMI Sui muri di Pompei (I sec. d. C.) troviamo errori di metrica e constatiamo che l'opposizione tra vocali lunghe e brevi non esiste più. Anche: ae e ĕ sono passati a /ε/. Ipercorrettismo: errore che porta a correggere forme che in realtà sono giuste. Ad esempio, quando un dialettofono veneto, che tende a scempiare le consonanti, per paura di sbagliare scrive motto per moto (per indicare movimento). Ostis per Hostis testimonia che h non si pronunciava più; ma troviamo Hoctober per October, che è un ipercorrettismo. FENOMENI EVOLUTIVI CONDIZIONATI TIPOLOGICAMENTE Latino e lingue romanze oggi ci sembrano tipi linguistici diversi, quasi opposti. La fonologia delle seconde è diversificata da quella del latino, così come la morfologia e la
sintassi. Il latino classico era caratterizzato dalla libertà nell'ordine delle parole, grazie all'esistenza dei casi, soprattutto nella poesia. La posizione del verbo era alla fine, seguivano soggetto e complemento oggetto (ordine OV). Nelle lingue romanze abbiamo libertà nelle opere letterarie di ispirazione classica, come in Vincenzo Monti: iperbati, anticipazioni. Il verbo segue il soggetto ma precede l'oggetto (ordine VO). In latino: l'aggettivo precede nome; l'avverbio precede il verbo; il verbo ausiliare segue il verbo principale (profectus est = è partito); il genitivo precede il nome. Nelle lingue romanze l'ordine è speculare. Ordine Modificatore-Modificato (in latino, es. aggettivo-nome); Modificato-Modificatore (nelle l. romanze, es. nome-genitivo). Può aver avuto un'influenza sulla caduta dei casi. Nelle lingue romanze il ruolo di Modificatore è svolto dalla preposizione: can-IS > DI cane. ALTRI FENOMENI SINTATTICI E MORFOLOGICI (che non possono essere spiegati in un prospettiva tipologica) -Condizionale e futuro. Il condizionale è un nuovo modo verbale, che si sviluppa da altre forme perifrastiche ottenute dall'ausiliare HABERE. Nel caso del futuro non si crea una categoria nuova, ma abbiamo un nuovo modo di formazione: infinito + HABERE. -Pronomi clitici. In latino abbiamo solo una serie di pronomi personali. Nelle l. romanze ne abbiamo una libera e una clitica, vedi me, guardami. In italiano abbiamo l'accusativo me (più mi) come in latino, mentre per il dativo abbiamo a me, mi-mihi. Ma alla terza persona singolare gli < ILLI, lo < ILLUM. I clitici sono già presenti nei primi documenti del volgare romanzo. Nelle lingue romanze medievali. Il pronome clitico presenta atonicità e posizione fissa nel contesto linguistico (Spero di trovarlo presto, *Spero di trovare prestolo) → adiacenza al verbo, di due tipi: proclisi (prima del verbo), enclisi (dopo) → se il verbo è all'infinito: clisi (trovarlo); se il verbo è di forma finita: lo trovo. Nello spagnolo: non trovarlo! No lo encuentres! I testi antichi romanzi mostrano un maggior sviluppo dell'enclisi. Legge Tobler-Mussafia: regolarità nell'alternare forme come cercasi o si cerca. Dal Novellino: Verbo in posizione iniziale → enclisi: Mandolli, Dicoti, Lodolle Verbo in posizione non iniziale → proclisi: e tu mi dona (per e tu donami), non ho di che ti sovenire (non ho di che aiutarti); anche nella negazione: non mi rispondere -Declinazioni nominali: in latino 5. Quelle che contengono meno parole scompaiono (quarta e quinta, assorbite da prima e seconda) → genitivo di fructus: fructi e non più fructus). Semplificazione in tutte le lingue romanze -Coniugazioni verbali: meglio conservate delle declinazioni; tuttavia abbiamo metaplasmi: passaggi frequenti da una declinazione all'altra, es. capire < CAPERE -Formazione del passivo. In latino troviamo forme semplici o sintetiche (amor, sono amato) e analitiche (amatus sum, sono stato amato). Le forme semplici scompaiono e quelle analitiche acquisiscono nuovo significato (amatus sum: sono stato amato → sono amato). Scompaiono anche verbi deponenti (sequor > *sequo > seguo) TRE FENOMENI INTERESSANTI
-Sistema casuale e sua evoluzione. I casi latini sono un'eredità indoeuropea ed esprimono numero e genere. Nelle lingue romanze viene persa la funzione casuale ma sono conservati genere e numero. Tuttavia, nella fase più avanzata del francese, queste informazioni sono relegate all'articolo o a un altro determinante. In latino, nelle espressioni come cum sodalibus (con gli amici), il morfema diventa ridondante, anche se non è questo motivo a provocare la scomparsa automatica dei casi, comunque ha avviato il processo. La proposizione rende prevedibile il caso (cum → ablativo; ad → accusativo). Nei graffiti di Pompei troviamo: in + ablativo anziché in +accusativo per il moto a luogo: sono conseguenze anche dell'ipercorrettismo (siamo in una fase intermedia, prima della caduta totale dei casi). Il francese antico, ampiamente attestato, aveva un sistema bicasuale: nominativo o Caso del Soggetto e Caso Obliquo (che indica: caso dell'accusativo, caso richiesto da tutte le preposizioni, certi usi del genitivo e dativo). Il francese attuale ha eliminato questa opposizione mantenendo solo la forma originariamente obliqua. Il romeno continua nominativo-accusativo e genitivo-dativo. Tutte le altre lingue romanze sono prive di caso. Quelle che utilizziamo oggi vengono principalmente dall'accusativo, vedi cenere < cinerem (accusativo) e non da cinis (nominativo); a volte vengono da entrambi, come serpeserpente, rispettivamente da serpens (nominativo), serpentem (genitivo), più rare. -Articolo romanzo. É sia definito che indefinito (anche il greco li ha). Russo e polacco non ce l'hanno, ma macedone e bulgaro l'hanno formato; le lingue germaniche l'hanno sviluppato nell'Alto Medioevo. Quello definito indica la classe, la specie, ma anche un soggetto noto agli interlocutori (nessuna traccia di questo enl latino tardo), viene usato nell'Itinerarium Egeriae, in cui abbiamo un uso anaforico: indica un elemento già nominato (es. Illi sancti: quei santi). Sardo e catalano hanno continuato non ille ma ipse, che aveva preso il posto di idem (uso anaforico). Nel periodo dell'Itinerarium, quando l'articolo comincia a fare la sua comparsa in latino, ha un uso testuale: è usato solamente per indicare un oggetto di cui si è già parlato in precedenza. Unus prende il posto di quidam che indicava indefinitezza specifica (Homo quidam: un uomo specifico anche se non identificato). Articolo indefinito nelle opere di Gregorio di Tours (una nocte) e in non habeo de parentis, de viene usato come articolo partitivo (uso tipicamente gallo-romanzo e toscano). EVOLUZIONE FONOLOGICA Lunghezza sillabica: le vocali nella grafia latina non sono distinte, lo sono solo le consonanti. In italiano è distintiva solo la lunghezza consonantica, nelle altre lingue le vocali non hanno nessuna delle due opposizioni. Nelle iscrizioni pompeiane: le vocali lunghe e brevi non sono più distintive. L'accentazione latina si basava sulla legge della penultima: si accentava la penultima sillaba se questa era lunga, la terzultima se la penultima era breve. Parossitone sono le parole piane, proparossitone le sdrucciole. La perdita della distinzione vocale lunga-breve ha fatto crollare il fondamento legge penultima, quindi l'accento, nelle lingue romanze, si è fissato sulla sillaba che occupava prima che venisse meno la distinzione, divenendo distintivo: fonologizzazione dell'accento. Vocalismo tonico. Per il complesso delle lingue romanze, abbiamo: Ī > i; Ĭ, Ē > e; Ĕ > ε; Ă, Ā > a; Ŏ > o aperta; Ō, Ŭ > o; Ū > u; nel caso del sardo e della zona Lausberg (confine tra Calabria e Lucania) da tutte le varianti (breve e lunga) abbiamo la
rispettiva vocale, es. Ī, Ĭ > i (tutto questo vale per la posizione tonica). In posizione atona si neutralizzano in un fonema unico: arcifonema. In italiano: le aperte dittongano solo in sillaba aperta BŎNUM > buono, ma DĔNTEM > dente perchè la sillaba “den” è chiusa. In spagnolo: abbiamo il dittongo anche in sillaba chiusa (bueno, diente). In romeno: è un sistema a metà tra il sardo e quello maggioritario: ŭ > u e non o (FŬRCAM > furca e non forca) (invece ē, ĭ > e) Siciliano e calabrese: il loro sistema ha come base il sistema maggioritario, ma si è evoluto ulteriormente: i, e > i; ε > ε; a > a; o aperta > o aperta; o, u > u. Era il sistema in uso nella Scuola poetica siciliana di Federico II (tiniri, vuci, viniri). I poeti toscani poi riportarono tenere, venire, voce, facendo rimare o con u e i con e (prima la rima era perfetta). Si ritrovano esempi in Dante, ma già con Petrarca l'usanza è caduta. -Dittonghi. ae > e molto precoce. Ipercorrettismi nei graffiti pompeiani → aegisse per egisse. Questo sviluppo è venuto a coincidere con quello di ĕ. Au è rimasto tale in alcuni termini, ma talvolta si è monottongato in o: AURUM > it. sp. oro -Vocalismo atono: solidus > soldus; a Pompei frigidam > fridam; presenti nelle espressioni scorrette dell'Appendix Probi (“oculus non oclus”) -Vocali in iato: tertĭum (ter-tĭ-um) > tert-jum; sviluppo di jod nel latino volgare -Consonantismo. Semivocali j e w. Perdono il tratto vocalico e passano alla serie delle consonanti. Nella grafia antica il suono [v] non esisteva: il segno V e segno u indicavano la semivocale /w/ e la vocale /u/ (pronunciate [w] e [u]). I graffiti pompeiani mostrano come sia evoluta nella fricativa bilabiale sonora [β]. Questo suono è passato a [v] in gran parte delle lingue romanze (in spagnolo si conserva in contesto intervocalico → lavar [laβar]). -Nessi di consonanti + jod. In un primo tempo consonante prima di j si è allungata HODĬE > *od-je > *od-dje. In seguito, per assimilazione, j si è fusa con con consonante precedente dando luogo a fonema palatale *od-dje > *od-dᶾe. Questo ha portato, es., a PLATĔA > it. piazza fr. place sp. plaza. t+j > ts.; k+j > t∫. l, n + j > λ (a specchio) nj poi gn (di gnomo) -Spirantizzazione di -b-. è passata a [β] e poi [v]: HABERE > lat volg. [aβere] > it. avere -Caduta di h- iniziale. In latino era aspirata e viene eliminata già in età repubblicana; tutte le lingue romanze l'hanno perduta -Caduta di -m finale, articolata debolmente già nel latino classico, la sua caduta è documentata a Pompei; diversamente da -s, -m è stata eliminata in tutto il dominio romanzo (ne resta traccia in con < CUM)...
Similar Free PDFs

Dal latino al volgare
- 4 Pages

Latino - Plinio il Vecchio
- 1 Pages

Latino - Ripasso Latino
- 10 Pages

Capitolo 2 - Il teatro latino
- 1 Pages

Analisi del periodo latino ;)
- 16 Pages

Teatro latino
- 1 Pages

Latino - L\'elegia
- 2 Pages

Latino grammatica
- 35 Pages

Fedro, Ovidio e Livio- Latino
- 4 Pages

Latino 1
- 3 Pages

Storia del teatro greco e latino pdf
- 28 Pages
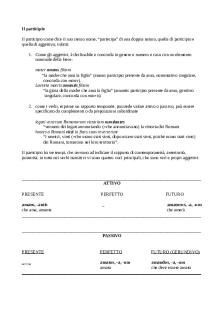
Latino participio
- 14 Pages

2. Le origini del latino
- 6 Pages

Exercício de Quadrado Latino
- 1 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

