La rinuncia al mandato PDF

| Title | La rinuncia al mandato |
|---|---|
| Course | Storia diritto e deontologia |
| Institution | Università degli Studi di Torino |
| Pages | 4 |
| File Size | 82.2 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 72 |
| Total Views | 135 |
Summary
Download La rinuncia al mandato PDF
Description
La rinuncia al mandato Art. 32 del Codice deontologico forense
Il nuovo Codice Deontologico Forense disciplina all’art. 32 la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato e le modalità con le quali la stessa deve essere effettuata per evitare che ne derivi un pregiudizio per l’assistito. A livello di contenuto, la norma riprende sostanzialmente quanto già sancito dal precedente art. 47, sebbene attraverso una diversa formulazione ed articolazione delle previsioni nell’ambito dei cinque commi che precedono il comma di chiusura, dove viene individuata la sanzione disciplinare che dovrà essere applica in ipotesi di violazione dei doveri previsti dall’art. 32, vale a dire la censura. Specificamente, nella sua nuova formulazione, l’art. 32 del Codice Deontologico stabilisce che l’avvocato abbia facoltà (e non più “diritto”) di rinunciare al mandato, vale a dire di rinunciare ad assistere il proprio cliente. Nell’esercizio di tale facoltà l’avvocato deve rispettare alcuni obblighi deontologici. In particolare l’avvocato, che assista una parte in giudizio ma abbia intenzione di dismettere il mandato, oltre che comunicarlo tempestivamente all’Autorità procedente (in modo da non determinare un ritardo nella definizione del processo e di consentire al cliente la sostituzione del difensore), deve, soprattutto, darne previa comunicazione all’assistito, in ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà (CNF 03/09/2913, n. 151), tenuto altresì conto che la dichiarazione di rinuncia al mandato diviene effettiva soltanto nel momento in cui la stessa viene a conoscenza del cliente (Cassazione, n. 2735/1973). Secondo il disposto dell’art. 32, infatti, l’esercizio della facoltà di rinuncia deve avvenire con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita (vale a dire, ad esempio, compiendo precedentemente alla dismissione gli atti processuali in scadenza, come potrebbe essere la nomina di un consulente di parte), nonché dando un congruo preavviso alla stessa, la quale dovrà anche essere informata di quanto è necessario fare per non compromettere la propria difesa (come, ad esempio, eventuali atti da compiere per evitare decadenze). Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarato che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rinunci al mandato il giorno stesso dell’udienza lasciando il proprio assistito senza difesa e non
preoccupandosi di provvedere, almeno per quella udienza, alla propria sostituzione” (CNF 10/12/2007, n. 196). Non risulta necessaria, in ogni caso, la sussistenza di una giusta causa, né l’avvocato ha l’obbligo di indicare il motivo della rinuncia (Cassazione, n. 2735/1973) trovando tale facoltà il proprio fondamento giuridico nel rapporto fiduciario che si instaura tra l’avvocato ed il proprio cliente. L’esigenza di rispettare particolari precauzioni al fine di garantire massima tutela al proprio assistito, prevista dalla norma, viene ribadita anche dalla giurisprudenza deontologica, secondo cui “il rapporto cliente – avvocato si caratterizza per una serie di motivazioni informate al rispetto e alla fiducia. Pertanto, l’avvocato che intenda rinunciare al mandato ha l’obbligo di dare al cliente precisa notizia delle sue intenzioni” (CNF 04/03/1995, n. 21). Più specificamente, la rinuncia al mandato, rappresentando un momento qualificante e decisivo del rapporto professionale, deve essere manifestata in modo chiaro e perfettamente comprensibile dall’assistito che la riceve, ovvero essa “deve formare oggetto di una precisa, ampia e puntuale comunicazione ad hoc, che ponga il destinatario in grado di intenderne completamente il significato e le derivanti conseguenze” (CNF 30/11/1993, n. 158). Inoltre, in caso di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve farsi carico di comunicare la propria rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla stessa presso l'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto, oppure (novità introdotta nel nuovo Codice Deontologico Forense), a mezzo p.e.c. Ed invero è soltanto dopo avere adempiuto a tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, che l'avvocato risulta esonerato da qualsiasi altra attività, a prescindere dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. Più precisamente, nel rispetto degli obblighi di legge e pur essendo comunque tenuto ad informare la parte assistita delle comunicazioni e/o notificazioni che dovessero pervenirgli, l’avvocato non risulta responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non venga nominato, in tempi ragionevoli, un altro difensore, poiché con la cessazione dell’incarico professionale viene meno ogni suo potere di gestione della causa e del fascicolo processuale. A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto disposto dal correlato art. 45 del nuovo Codice Deontologico Forense, in ipotesi di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o per rinuncia al mandato, il nuovo difensore deve rendere nota la propria
nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) nonché adoperarsi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, affinché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte, vale a dire siano pagate le competenze del collega sostituito, pena l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento (sul punto, anche CNF 11/03/2015) Ciò non significa, in ogni caso, che il nuovo difensore sia responsabile e/o obbligato al pagamento del compenso al collega sostituito. Concludendo, è opportuno rilevare che la possibilità per l’avvocato di rinunciare al mandato risulta disciplinata anche da ulteriori norme. In particolare, per quanto riguarda il processo civile, il riferimento è all’art. 85 c.p.c., rubricato “Revoca e rinuncia alla procura” secondo cui il difensore può sempre rinunciare alla procura, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti della controparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. La rinuncia da parte dell’avvocato difensore, secondo tale norma, può essere esercitata ad nutum, ossia in ogni stato e grado del processo civile, nonché essere espressa o anche risultare da fatti concludenti, non richiedendo infatti la legge, alcuna formalità specifica, ritenendo sufficiente un comportamento dal quale possa desumersi la volontà di abbandonare l’incarico. Ciò nondimeno, deve ritenersi che sino al momento di nomina e costituzione del sostituto, il precedente difensore sia tenuto a rappresentare il proprio assistito e sia deontologicamente obbligato a rispettare i principi di lealtà e correttezza che si pongono alla base del rapporto professionale. In ordine al processo penale, invece, l’art. 107 c.p.c., rubricato “Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore”, stabilisce, al comma 1, che il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne deve dare subito comunicazione all’autorità procedente ed a chi lo ha nominato, nonché, al comma 3, che la rinuncia del difensore non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o d’ufficio, e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108 c.p.p. (vale a dire quel termine non inferiore a sette giorni che può essere richiesto dal nuovo difensore dell’imputato per prendere cognizione del processo e visionarne gli atti)....
Similar Free PDFs

La rinuncia al mandato
- 4 Pages

Unidad 30 - Mandato
- 6 Pages

Contrato DE Mandato
- 10 Pages

IL contratto di mandato
- 6 Pages

Settimana Veg 2020 pdf mandato
- 49 Pages

Modelo de contrato de mandato
- 5 Pages
![Tema 9 EL Mandato[ 11131 ]](https://pdfedu.com/img/crop/172x258/k925mk49ev3m.jpg)
Tema 9 EL Mandato[ 11131 ]
- 6 Pages

La educación Médica en AL
- 32 Pages
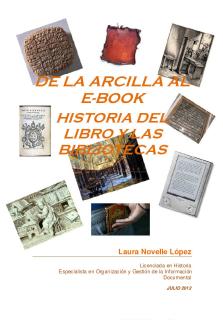
De la arcilla al ebook
- 79 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






