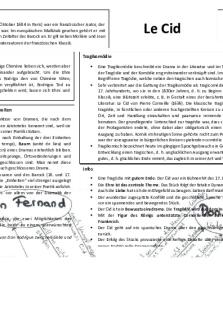Le Cid - Corneille PDF

| Title | Le Cid - Corneille |
|---|---|
| Course | Letteratura francese i |
| Institution | Università degli Studi di Palermo |
| Pages | 15 |
| File Size | 228.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 67 |
| Total Views | 140 |
Summary
Riassunti completi di appunti sulla tragicommedia Le Cid di Pierre Corneille...
Description
Le Cid - Corneille Teatro classico francese. Condizioni di tipo storico: Le cid viene messa in scena per la prima volta nel 1636 e pubblicata nel 1637. Si tratta di un periodo storico in cui siamo nel vivo del regno di Luigi XIII, il quale sta riuscendo ad instaurare in Francia quello che poi la storia ha chiamato assolutismo (anche se il vero assolutismo monarchico sarà quello di Luigi XIV, ma durante il suo regno ne abbiamo le premesse); non è però il sovrano ad essersi inventato l’assolutismo. Colui che lo ha inventato è il primo consigliere del re, il cardinale Richelieu: nasce da una famiglia della piccola nobiltà – il cognome di origine è Du Plessis. Conosce una rapida ascesa diventando il cappellano della regina madre Maria de Medici, che aveva sposato Enrico IV e, alla sua morte (assassinato da Ravaillac nel 1610, dopo la pubblicazione dell’editto di Nantes nel 1598) lei assume la reggenza è un periodo caratterizzato da una certa instabilità di governo, perché lei governa insieme alla sorella di latte (?) Leonore Galigai e insieme al marito (della Galigai), un certo Concini dettagli importanti perché testimoniano quanto ancora la corte, che era stata italiana nel rinascimento (‘500), continui fino agli anni 10 del ‘600 circa, ad essere italiana. si avverte ancora una certa influenza italiana – essa non era gradito ai francesi; la pace portata da Enrico IV era ancora un po’ frutto di un compromesso/accordo politico, perché sposa ancora una Medici – Caterina de Medici aveva gettato nel sangue la Francia, ed Enrico IV, che riporta la pace, sposa ancora una componente della stirpe dei Medici – ciò non è casuale ma è frutto di un accordo politico. Enrico muore prematuramente, assassinato da Ravaillac e la Francia si ritrova ancora una volta in mano degli italiani situazione molto mal vista dal popolo. Luigi XIII era ancora troppo giovane per governare, e occorrerà aspettare circa 7 anni, perché nel 1617, Luigi XIII decida di prendere in mano la situazione, chiedendo alle sue guardie di far assassinare Concini, che effettivamente viene assassinato, Leonore si allontata, e, nel momento in cui la regina madre si trova in una posizione politica minoritaria ingaggia Richelieu come suo cappellano privato; la regina capisce quindi il suo valore politico e lo invia al consiglio del re, dove si fa immediatamente notare per la bravura e le capacità politiche. Richelieu era un uomo particolarmente ambizioso, e capisce che non è rimanendo legato alla regina madre che farà una brillante carriera. Punta quindi al sovrano, riuscendo nell’intento di teorizzare e incoraggiare l’assolutismo monarchico. Luigi XIII si lascerà affascinare dal suo progetto politico. Quando, nel 1630, Richelieu decide di dichiarare guerra alla spagna, la regina madre si oppone categoricamente – essendo legata all’Italia e al papato; è furibonda nei suoi confronti , ne chiede, fondamentalmente la testa. Richelieu si appresta a fuggire, ma viene convocato dal re, che lo salva. Maria allora si esilia volontariamente in Belgio. In 12 anni Richelieu inventa lo stato francese moderno asservendo la nobilità la condizione di vita della nobiltà cambia, dal 1630 al 1642, in 12 anni R. riesce a piegare, con la forza, la nobiltà.
ad esempio: fa emanare un decreto reale che vietava i duelli per strada, condannando alla pena di morte chi vi si opponeva. Un nobile, per una bravata, proprio pochi giorni dopo l’emanazione del decreto, lo infrange. R. lo farà decapitare. I nobili, a quel punto capiscono che l’assoggettamento al potere reale non era qualcosa che poteva essere ancora beffato. Tutte le città che godevano, ad esempio, di roccaforti private, vennero disarmate. Azione che Richelieu condurrà sul territorio francese costituisce una delle più grandi intuizioni politiche dei vari capi di stato francesi: il segreto della tenuta della nazione era l’azione capillare sul territorio. Le Cid si colloca esattamente in questi 12 anni di potere di Richelieu, all’indomani della creazione dell’Académie Française, e infatti sarà la prima opera che la neonata Académie sarà chiamata a dibattere. Le cid: non è una storia originale, ma è originale l’uso che ne fa Corneille. Siamo nell’undicesimo secolo, in particolare nel 1043, e vicino Burgos, nella vecchia Castiglia, un soldato, un certo Rodrigo Diaz, si illustra nella lotta contro i mori. Il sovrano, Alfonso VI, gli concede in sposa una dama di sangue reale, e il privilegio di regnare su Valencia, che aveva ripreso ai mori, dove regnerà quasi come un effettivo sovrano dal 1095 al 1099, anno della sua morte. La storia che ci consegna la leggenda medievale è quella di un guerriero, il Campeador (il battagliero), il quale riesce, grazie al suo valore militare, ad ottenere il riconoscimento del sovrano, a tal punto che questi gli concede una principessa di sangue reale e lo pone a capo di una città. Il nucleo originale/principale della vicenda si svolge durante il Medioevo, con l’aggiunta di alcuni dettagli elementi che si aggiungono alla leggenda: nasce l’idea che la principessa di sangue reale che lui ha sposato, l’avesse fatto in un matrimonio riparatore perché Rodrigo, il Cid, ha ucciso in duello il padre della ragazza. Occorre aspettare il 1618 affinché nella pi+èce di Guillen de Castro – Las mocedades del Cid (l’infanzia del Cid), venga fuori l’idea che Cimena (Chimene) fosse già stata innamorata di Rodrigo prima ancora che questi uccidesse il padre costruzione della leggenda ha diversi gradi di preparazione. Corneille scopre probabilmente Las Mocedades intorno al 1635, una pièce spagnola che aveva un certo successo, ma che risente ancora molto della temperie barocca nella quale è stata scritta. Parentesi: le pièce seicentesche spesso soffrono di una sorta di intasamento narrativo: i drammaturghi cercano di mettere talmente tante informazioni che l’azione stessa risulta quasi legnosa. La pièce non è fatta per essere troppo ricca di informazioni; essa deve avere una struttura essenziale, lineare, deve poter essere facilmente seguibile dallo spettatore. (Si rischia, se no di scrivere pièces che nell’800 verranno appositamente create per essere lette, “le théâtre dans un fauteuil”, quello che realizzerà uno dei più grandi scrittori dell’ottocento francese, Musset. Nel ‘700 però non c’era questa intenzione; tuttavia, spesso gli autori non avevano il
genio letterario che poteva permettere loro di valutare esattamente, e tendono a riempirle di una serie di dettagli che portano il lettore a perdere il senso della narrazione.) La pièce di Guillen è intasata dal punto di vista narrativo. La storia è la stessa del Cid di Corneille, solo che è piena da una serie di dettagli, scene, che non rendono questa piéce tanto godibile quanto lo è invece il Cid. Il lavoro che fa Corneille sulla pièce è un alleggerimento. I contemporanei lo accusarono di aver fatto una traduzione, un plagio. Venne presa da alcuni detrattori come un plagio. La trama è in ogni caso esattamente la stessa. Egli sfronda la pièce di tutti gli elementi secondari, organizza la trama in maniera molto più fluida, ed è animato da una tensione verso uno spirito classico della pièce – le pièce classiche sono le più efficaci. Nell’estetica del teatro barocco lo spettatore deve essere stupito da ciò che vede in scena. Teatro in cui viene messo in scena il Cid per la prima volta è quello dell’hotel du Marais – si trattava di una sala per il gioco della palla a corda adeguata a teatro. Il parterre, antistante al palcoscenico, permetteva l’acquisto dei biglietti a minor prezzo – il pubblico era in piedi e si pagava molto poco. Poi vi erano le logge, poche logge, con un prezzo maggiore, destinate alle donne e a degli spettatori più abbienti che ne potevano pagare il prezzo. Ma i posti principali erano quelli situati sul palcoscenico, per spettatori nobili, ricchi, che entrano a far parte della coreografia. Era parte dell’uso dell’epoca. Ma, in una pièce come il Cid la presenza di questi nobili ben vestiti contribuissero a fare perfettamente la coreografia delle stanze reali. Il vero spettacolo si poteva godere dalla loggia, nella nostra sensibilità. In queste condizioni di rappresentazione vi era anche un’azione disturbante di un pubblico chiassoso, rissoso che fischiava agli attori se la rappresentazione non era gradita. Non è affatto il pubblico disciplinato che siamo diventati noi nel corso dei secoli. Una delle testimonianze relative alle rappresentazioni del Cid dice che la quantità di gente al teatro du Marais era tale che si pagava come posto sul palcoscenico una delle nicchie che veniva generalmente usata per riporre il materiale di scena – e si diffuse un proverbio (perso nel corso nel tempo): il est beau comme le Cid, per indicare il successo di qualcosa. Il Cid è interessante anche per la distanza che comincia a crearsi tra ciò che il pubblico apprezza e ciò che non apprezza per niente; può essere considerato uno dei primi fenomeni di pop culture – perché la critica dell’epoca, di fronte a questa cid mania, reagì in maniera talvolta sprezzante, dando luogo alla querelle du cid. furono composti 36 libelli contro il cid, unitamente ad un altro documento che chiude la querelle, i sentimenti dell’accademia francese sul cid (Des sentiments de l'Académie française sur la tragi-comédie du Cid). E’ il primo atto, di una forza sconvolgente, su un’azione di natura non politica o militare, che non riguarda le sorti della nazione, ma è la prima ferma e decisissima azione di politica culturale. Oggi nessuno può mettere un punto finale sulla discussione di un’opera, perché, per come diceva U.Eco “non esistono opere chiuse”; all’epoca però non era così: infatti, ci si ferma una volta che l’académie si pronuncia perché essa era sostanzialmente la voce del cardinale Richelieu. Oggi “non esistono opere chiuse” – invece, l’academie da un giudizio assoluto che non potrà più essere messo in discussione, e che chiude la capacità polisemica del testo.
Testimonianze dell’epoca: nel 1637 avviene la prima rappresentazione: ruolo ufficiale viene affidato a Mondory, un grande attore dell’epoca, che scrive a Guez de Balzac, suo amico, dicendogli “desidererei che foste qui per gustare il piacere delle commedie che rappresentiamo e in particolare il Cid che ha incantato tutta Parigi; è così bello che ha suscitato l’amore anche delle dame più continenti; la folla era grande e la sala talmente piccola, che tutti gli angoli del teatro sono stati venduti come posti di favore” --> dice quanto grande fosse all’epoca il favore del pubblico un’altra testimonianza, più tardiva, è quella di un grande intellettuale dell’epoca che era stato eletto all’académie, di cui non è rimasta a noi traccia alcuna, per quanto riguarda le opere: Pellisson, che nel 1653, nella sua storia dell’académie, racconta che è “difficile immaginare con quanta approvazione questa piéce fu accolta dalla corte e dal pubblico; non ci si poteva stancare di vederla; non si sentiva parlar d’altro nelle compagnie e ognuno conosceva qualche parte a memoria. La si faceva imparare a i bambini (è una delle costanti del sistema educativo francese); in parecchi posti di Francia diventa proverbiale la frase “cela est beau comme le Cid”. testimoniano il successo della pièce all’epoca. Tra i detrattori possiamo invece citare un certo Mairet con un libretto che dice già tutto a partire del titolo: L’auteur du vrai cid español à son traducteur français. è una falsa lettera in cui Mairet, un drammaturgo, probabilmente invidioso del successo di Corneille, scrive fingendo di essere Guilleme de Castro “riconoscerai che mi devi la tua celebrità”; una delle grandi accuse a lui mosse era quella di plagio, una anche delle più superficiale. Colui che fece un’analisi molto approfondita dell’opera fu Georges de Scudéry, fratello di Mlle de Scudéry. Egli si accorge di tutti i difetti della pièce rispetto all’applicazione delle regole classiche, in particolare riprende l’accusa di plagio già espressa da Mairet, ma, essendo un lettore molto più fine, si accorge che all’interno della trama, ciò che più stupisce è il fatto che una ragazza, cui il suo ragazzo abbia ucciso il padre, decida alla fine di acconsentire di sposarlo, e ancor prima che il sovrano lo imponesse, di far entrare Rodrigue nella stessa casa in cui si trovava ancora la salma del padre. In questa storia, di profondamente scandaloso per il 600, di inverosimile: oggi potremmo ritenere valida per i codici cavallereschi dell’epoca, il motivo che egli aveva avuto per uccidere il padre di Chiméne, perché lui aveva sbeffeggiato in maniera pesante suo padre, e si trattava di difendere l’onore della sua famiglia di fronte al fatto che avevano buttato nel fango il suo nome; ma, nel 600, appare profondamente inverosimile il fatto che una donna di buona famiglia cedesse così facilmente alle sue passioni – sistema del dominio delle passioni: vena di stoicismo che accompagna tutto l’equilibrio dell’essere umano del 600, la stessa vena che abbiamo conosciuto con Montaigne, Malherbe, e che continua nel pensiero che una persona che si lasci guidare dalla passioni non viene ritenuta morale. Ciò che viene quindi enfatizzato nella critica di G. de Scudery è il fatto che Chiméne abbia ceduto alle proprie passioni. Questa morale di tipo stoico, nonostante accompagnasse la rappresentazione ideale della classe aristocratica, non era certamente il modo di fare del popolo, e soprattutto, per come scrive
Mondory, persino le dame più composte si lasciavano prendere dal sentimento d’amore vedendo le Cid. Le Cid e Chimene, all’epoca dei fatti raccontati, sono ragazzini. Sono presi dal loro amore; inoltre, il rapporto genitori figli del ‘600 lungi dall’essere quello dei nostri giorni. Vi è una grande distanza, erano rapporti codificati, più che essere rapporti di affetto sincero. tuttavia, egli non si accorge del valore della pièce. Non una testimonianza ma un giudizio critico che può dare una risposta più raffinata alla questione è quello di Charles Péguy, un grande poeta del novecento che muore durante la prima guerra mondiale, che scrive una nota sul Cid in cui dice poche parole, ma appropriate: “ci si farà difficilmente credere che l’amore di R. e di C. sia una debolezza, e ci si farà ancora più difficilmente credere che sia una bassezza; in realtà il conflitto in Corneille non è un’opposizione tra un dovere, un’altezza, e una passione, una bassezza opposizione tra onore/amore non è, per Péguy, una opposizione nel senso che l’onore è qualcosa di altro e l’amore basso – è un dibattito tragico tra una grandezza e un’altra grandezza, tra la nobilità e la nobiltà, tra l’onore e l’amore. Il Cid fu tradotto in italiano già a partire dagli anni 50 del ‘600: una delle prime traduzioni italiane era chiamata “onore contra amore” – si capisce il nucleo tematico principale. (Il Cid sarebbe stato incomprensibile in italiano). Péguy coglie molto bene nel segno rispetto al modo in cui la piéce fu recepita nel ‘600: ciò di cui il pubblico si accorse immediatamente, a differenza dei critici che erano troppo presi a sottolineare che si trattava di un plagio, a dire che Chimene non avrebbe dovuto comportarsi in questo modo, e a sottolineare il fatto che non vengono rispettate le unità di tempo e d’azione previste dalla poetica di Aristotele. Ma i critici non si accorgono della cosa più importante, ovvero del fatto che Corneille non intende far prevalere l’onore sull’amore o l’amore sull’onore, ma si trattava di due forze ugualmente grandi. Nella binaria opposizione onore/amore che deve trovare modo di conciliarsi, viene salvato l’onore di Rodrigue e l’amore di Chimène. Dal lato maschile viene salvato l’onore e da quello femminile l’amore: ciò risponde ad una logica di gender molto classica tipica del teatro del 600 il vero sacrificio viene fatto dalla donna. legame di Corneille con la società del tempo: l’académie solleverà Corneille dall’accusa di plagio. Dirà che egli ne ha semplicemente tirato fuori la trama; l’académie continuerà però a condannare la scelta di Chimene, ma sorvolerà con acume. Chi redige i pensieri dell’académie è Chapelain, il primo segretario permanente dell’académie francais, uomo di grande intelligenza politica che capisce che l’académie non poteva urtare in maniera troppo forte il senso comune. Il sovrano, Don Fernardo, è Luigi XIII – riesce a presentare ciò che egli si avvia ad essere a partire dal 1630 e nel 1637 siamo all’apogeo del dodicennio in cui l’assolutismo monarchico viene posto; la scena di Corneille fa vedere un sovrano che decide tutto è una delle
rappresentazioni del potere reale che piacciono molto al sovrano l’académie doveva garantire una idea di cultura legata agli interessi del sovrano. L’académie, di fatto, nasce proprio per questo: per veicolare una certa idea della nobiltà e soprattutto della sovranità. Lui ha la fortuna o l’intuizione di creare una pièce in cui il sovrano potrebbe benissimo essere Luigi XIII e per questo l’académie decide di schierarsi a suo favore. Questi uomini agiscono per ragioni letterarie piegate interessi contingenti rispetto alla creazione dell’académie française. è un atto politico di grandissima intelligenza, ovviamente storta nel modo in cui la vediamo noi perché non potremmo che trovare inaccettabile un organismo che legiferi su ciò che andava bene e ciò che non andava bene (la vedremmo come una privazione di libertà d’espressione), o almeno, anche da noi esiste con le case editrici etc, ma non ce ne fanno accorgere più di tanto, mentre all’epoca veniva fatto in modo plateale. Trama in brevissimo: L’intreccio si sviluppa attorno all’amore reciproco di Rodrigo per Jimena, figli nobili della corte di Fernando di Castiglia, alla vigilia di un felice matrimonio sul loro amore si abbatte un evento sciagurato: il re concede a Don Diego, padre di Rodrigo, il ruolo di precettore che Don Diego, padre di Jimena, rivendica per sé. Il conflitto tra i due ha un esito drammatico: Don Gomes schiaffeggia Don Diego e chiede al figlio la vendetta. Rodrigo lacerato tra il dovere di vendicare il padre e l’amore per Jimena, scegliere di salvare l’onore della propria famiglia, sfida Don Gomes e lo uccide in duello. La stessa lacerazione tra dovere e amore colpisce Jimena che si sente costretta a vendicare la morte del padre, nonostante l’amore che prova per Rodrigo. Un’impresa eroica di Rodrigo gli permette di vincere sui Mori, che lo riconoscono loro Cid – signore – ciò gli procura un riconoscimento del re. Il conflitto tra amore e dovere che lo oppone a Jimena non è ancora risolto, questa chiede aiuto a Don Sancho, suo innamorato senza speranza, che sfida in duello Rodrigo. Don Sancho verrà sconfitto ma lasciato in vita, e sarà il re Fernando a risolvere il conflitto, cancellando le conseguenze del conflitto tra Don Diego e Don Gomez e permettendo a Rodrigo e Jimena di realizzare il loro amore.
ATTO I, scena I: Chiméne e Elvire (governante di Chiméne) parlano dell’amore di Chiméne per Rodrigue e del fatto che il padre (le Compte, don Gomès) deve scegliere un pretendente per la figlia: la scelta del padre sembra tendere a Don Rodrigue “Il estime Rodrigue autant que vous l’aimez.” Un’espressione diventata proverbiale è « je me promets du fils ce que j’ai vu du père » utilizzata per rivolgersi ad un ragazzo di buone aspettative con un padre distintosi per valore, per stima. Implicitamente si vedono diversi elementi: il primo è il fatto che Rodrigue, implicitamente – anche se sembra non contare nulla, ha un rivale. In secondo luogo, viene detto chiaramente che il padre di Rodrigue, un grande e valoroso guerriero, è molto avanti negli anni e non ha più una grande forza. Infine, viene detto che Chimène, nonostante il padre si sia pronunciato soprattutto a favore di Rodrigue, sente un presagio oscuro. Elvire, alla fine della scena, tenta di consolarla “vous verrez cette crainte heureusement deçue” questo timore svanirà presto. Nel teatro classico, tutto il primo atto (tutte le scene che lo compongono) servono a spiegare in maniera molto precisa la situazione drammatica, e l’atto primo viene chiamato “atto d’esposizione”, che serve ad illustrare la situazione drammatica. La scena prima, in particolare, punta i primi 3-4 elementi segnati: il fatto che Chiméne abbia 2 pretendenti (l’altro è don
Sanche), la sua preferenza per Rodrigue,...
Similar Free PDFs

Le Cid - Corneille
- 15 Pages

Le Cid - Résumé
- 5 Pages

Corrigé-bac-corneille
- 1 Pages

Fiche Suréna Corneille
- 2 Pages

El CID Campeador del mio CID
- 94 Pages

Resumen Cid
- 3 Pages

Práctica 1. EL CID
- 5 Pages

El Cid Richard Fletcher
- 6 Pages

Cantare Del Cid
- 3 Pages

Varela CID - resumen
- 48 Pages

Análisis del Cid Campeador
- 10 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu