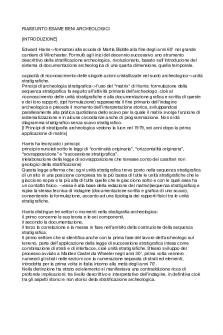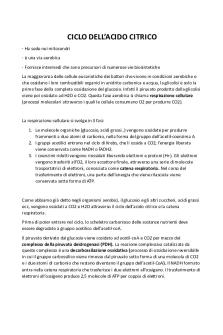Principi DI Stratigrafia Archeologica PDF

| Title | Principi DI Stratigrafia Archeologica |
|---|---|
| Author | Luana Albanese |
| Course | Metodologia della ricerca archeologica |
| Institution | Università degli Studi Roma Tre |
| Pages | 15 |
| File Size | 201.9 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 54 |
| Total Views | 142 |
Summary
Riassunto libro principi di stratigrafia archeologica...
Description
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA ARCHEOLOGICA – HARRIS I principi della stratigrafia archeologica devono considerare gli aspetti non storici della stratificazione, poiché sono questi ad essere di applicazione universale; molte singole unità stratificazione non hanno alcuna importanza generale come elementi storici, dal momento che è principalmente attraverso il confronto delle sequenze culturali e dei manufatti dei vari siti, non della loro stratificazione, che l’archeologo studia lo sviluppo delle società passate. Tutte le forme di stratificazione sono il risultato di simili cicli di erosione e di deposito, e quindi un ciclo di erosione e accumulo, né può esistere l’una senza l’altro. Oltre alle forze naturali che sono dietro a questo processo, come il clima o la flora e la fauna, non possono essere ignorate le attività umane. Da quando l’umanità ha imparato a scavare, essa è divenuta la forza principale del processo di stratificazione archeologica. Quale che sia lo scopo, dallo scavo del terreno risulterà sempre alla fine la formazione di nuovi strati. La duplice attività naturale di erosione e accumulo è integrata dall’attività di scavo intenzionale e dalla scelta di luoghi definiti di deposito. Anche in altro senso il processo di stratificazione archeologica è duplice: la creazione di uno strato equivale alla creazione di una nuova interfaccia e, in molti casi, di più di una. Altri strati, formati da materiale di scavo, presentano superfici nuove, ma la loro formazione è conseguente alla creazione, in altro luogo, di una fossa, che è essa stessa un’interfaccia. La stratificazione archeologica è composta di depositi e di interfacce, solitamente in equale proporzione, ma spesso le seconde sono più numerose dei primi. Questi depositi e interfacce archeologiche, una volta creati, possono essere alterati o distrutti nella prosecuzione del processo di stratificazione. La stratificazione è irreversibile. Una volta che l’unità stratigrafica si è formata, è soggetta, da allora in poi, solo ad alterazione e deperimento: non può essere ricostruita. Il geologo CHARLES LYELL definì uno ‘’STRATO’’ come: ‘’Il termine strato significa semplicemente una base o qualsiasi altra cosa che si stesa o sparsa sopra una determinata superfice.’’ Questa definizione indica altri due aspetti del processo di stratificazione, e cioè: -
I mezzi attraverso cui il materiale viene trasformato e
-
Le sue condizioni al momento della deposizione;
La definizione di Lyell non è del tutto appropriata per le situazioni archeologiche, poiché in molti casi le unità stratigrafiche archeologiche non sono distese su una superficie, ma vengono collocate deliberatamente secondo esigenze specifiche. HIRST, ha individuato tre classi di unità stratigrafiche archeologiche: 1. Strati di materiali depositati, o in corso di deposito, gli uni sopra gli altri orizzontali (coincide con la definizione di strato di Lyell): sulla base dei mezzi di trasporto e delle condizioni di deposito, questa classe deve essere suddivisa in strati naturali e strati artificiali.
i materiali per la costruzione degli STRATI NATURALI in una situazione archeologica posso essere trasportati dall’uomo o dalla natura; Come STRATO ARTIFICIALE, tende ad accumularsi secondo un normale modello di sovrapposizione, uno strato sopra l’altro. 2. elementi che tagliano gli strati (elementi negativi), ad esempio fosse; 3. elementi costituiti da costruzioni intorno alle quali si siano di seguito formati gli strati (elementi positivi), per esempio muri ecc… [Esaminata come strato verticale].
La deposizione di questi strati provocherà alterazioni nella conformazione topografica di un sito, ma essi stessi raramente creeranno nuovi bacini di deposito, come fanno alcuni strati verticali. Gli strati verticali, come i muri costituiscono una stratificazione artificiale e sono direttamente confrontabili con alcuno strato geologico; dal momento che si mantengono consolidati per un certo periodo, formano su un sito nuovi bacini di deposito. Gli strati naturali, gli strati artificiali e gli strati verticali hanno in comune i seguenti elementi stratigrafici
1. ‘’FACCIA’’ o superficie originaria: questo termine è stato usato per distinguere la superficie superiore originaria di uno strato dalla sua superficie inferiore. E’ stato sviluppato in geologia come un modo per determinare l’ordine originario di sovrapposizione. Gli strati verticali, possiedono diverse facce originarie o superfici superiori, cioè esterne o esposte all’atmosfera dopo la loro deposizione. 2. Contorni della superficie di strato: queste linee o contorni definiscono l’estensione nello spazio di ciascuna unità stratigrafica in entrambe le dimensioni, orizzontale e verticale. Non vengono spesso indicati sulle piante archeologiche, ma appaiono di frequente nelle sezioni. 3. Rilievi di superficie di strato: queste linee indicano il rilievo topografico della superficie di uno strato, o di un gruppo di unità stratigrafiche; questi rilievi sono ottenuti dalla documentazione in pianta di una serie di punti quotati. Essi non costituiscono una documentazione primaria come i contorni della superficie di strato, che possono anche comparire sia nelle piante che nelle sezioni, mentre i rilievi di superficie di strato vengono indicati in genere solo sulle piante. 4. Volume e massa: il volume e massa di un’unità stratigrafica archeologica possono essere determinati, se necessario, combinando le dimensioni dei contorni con quelle dei rilievi della sua superficie. 5. Posizione stratigrafica:
Tutte le unità stratigrafiche avranno una posizione nella sequenza stratigrafica di un sito. La posizione, che rappresenta la datazione relativa di una determinata unità in rapporto con le altre, si determina mediante l’interpretazione dei soli resti stratigrafici secondo le leggi e i principi della stratigrafia archeologica. 6. Cronologia: Tutte le unità stratigrafiche sono state create in una determinata epoca. Questa viene misurata in anni, ma in molti casi non può essere stabilita dal momento che essa dipende dalla qualità di materiali databili rinvenuta nei depositi di un sito. L’ accertamento della cronologia di un’unità stratigrafica è comunque un compito secondario nello studio della stratificazione archeologica. Sullo scavo l’interpretazione e la documentazione della stratificazione possono procedere senza rivolgere un’attenzione immediata alla cronologia assoluta; in molte circostanze, la consapevolezza della datazione di un deposito è estremamente utile dal momento che può suggerire comportamenti altrimenti trascurati, come ad esempio la raccolta di campioni di suolo in quantità maggiore rispetto alla routine abituale. La cronologia di un’unità stratigrafica non può mai cambiare la sua posizione nella sequenza stratigrafica di un sito, ma può apparire in contrasto con la datazione del resto della sequenza. La stratificazione archeologica può essere documenta solo al suo stato attuale. Sebbene siano stati deposti nel corso dei secoli, gli strati di un sito sono soggetti ad un cambiamento continuo. Dal momento che la stratificazione di un sito non è un fenomeno statico, ma cambia nel corso del tempo per una quantità di fenomeni diversi, anche il grado di sopravvivenza degli elementi di ciascun periodo è del tutto involontario. Lo strato naturale, artificiale e verticale sono unità stratigrafiche archeologiche nonstoriche.
LA SUPERFICIE DI STRATO Esistono due tipi di superficie di strato quella Orizzontale e quella Verticale. Presentano le stesse relazioni stratigrafiche dei depositi. Le forme orizzontali verranno documentate su piante che dovrebbero indicare i contorni delle superfici degli strati e perciò i limiti delle interfacce. Il rilievo o topografia della superficie di strato orizzontale è documentato mediante una serie di quote, che possono in seguito essere riportate su una pianta con curve di livello. La superficie di strato verticale viene documentata mediante un disegno o prospetto. Dal momento che si tratta di superfici verticali, esse non hanno rilievi di superficie. Entrambi i tipi di superficie di strato indicano semplicemente il tempo intercorso tra la costituzione di un particolare strato e la sua successiva obliterazione. Molte di queste superfici vengono alterate nel corso del tempo anche se spesso è impossibile riconoscere queste alterazioni, in particolare se i depositi erano composti di materiali non consolidati. Per questa ragione il deposito e la sua interfaccia, o superficie, possono essere considerati come una sola unità stratigrafica.
LA SUPERFICIE IN SÉ Ci sono due tipi di superficie in sé, quella Verticale e quella Orizzontale. Queste interfacce sono formate dalla distruzione della stratificazione preesistente. Le superfici in sé sono unità stratigrafiche valide per sé: dovrebbero ricevere un numero di strato ed avere il proprio insieme di rapporti stratigrafici con altre unità della stratificazione, e i propri contorni e rilievi di superficie. Le superfici in sé orizzontali sono associate con strati verticali e segnano livelli ai quali alcune parti di tali depositi sono state distrutte: possono presentarsi quando un muro va in rovina e crolla per cause naturali, o risultate dalla demolizione parziale di un edificio. Queste interfacce vengono spesso documentate come se fossero ‘’piante’’ del muro originario, ed ogni pietra vi è disegnata in dettaglio; esse costituiscono la testimonianza, di un periodo spesso molto più tardo di quello della costruzione di un muro e posso rappresentare un uso degradato. Queste interfacce, quindi, dovrebbero essere documentate mediante rilievi dettagliati del livello del suolo, attraverso i quali dovrebbero rivelarsi le tracce di questo uso posteriore. Queste si presentano solamente su siti con edifici in muratura o dove sopravvivano costruzioni di legno. Le superfici in sé verticali risultano dallo scavo di fosse e si rinvengono su molti siti. Queste cavità possono aver avuto diverse funzioni, come i fossati, le fosse, le tombe, le buche ecc. Tali interfacce possono essere documentate come una parte dei depositi che le riempiono e non come unità stratigrafiche individuali. Questo tipo di analisi complica la documentazione stratigrafica, dal momento che vengono spesso istituiti rapporti tra strati all’interno di una fossa e quelli che la circondano, senza il dovuto riguardo per l’interfaccia originaria che forma le pareti della fossa stessa. Tra le unità stratigrafiche possono esistere diversi tipi di rapporti, basati sul contatto fisico tra le unità stratigrafiche e sul concetto di tempo relativo.
A Possono non avere alcuna relazione stratigrafica diretta; B Possono trovarsi sovrapposti; C Possono essere messe in relazione come parti di uno stesso deposito originario. Dal momento che le superfici in sé verticali non sono superfici di strato, ma superfici valide per sé stesse, esse non possono venire documentate in pianta; questa può essere documentata in pianta solo mediante il rilievo quotato dei livelli del suolo , poiché questi non sono altro che superfici.
L’INTERFACCIA DI PERIODO Quando un certo numero di strati e di interfacce si accumula formano una massa, viene a costituirsi un corpo di stratificazione che, può essere diviso in formazioni. In archeologia le formazioni possono essere individuate secondo criteri culturali, cronologici o funzionali (es. possiamo fare riferimento a formazioni romane o medievali, preistoriche o storiche, a episodi di costruzione o distruzione). Un certo numero di formazioni potrebbe costituire la stratificazione di una particolare epoca, cioè di un periodo, su un sito; ogni periodo avrà un’interfaccia che è una superficie composta di un certo numero di superfici di strato o superfici in sé. Queste interfacce di periodo vengono documentate nelle piante archeologiche abituali. L’interfaccia di periodo equivale a: ‘’la somma totale delle superfici che sono state livelli di terreno in uso in uno stesso ed unico momento’’ (Woolley). Se un sito è relativamente semplice, un’interfaccia di periodo può essere individuata nel corso stesso dello scavo. Su siti complessi, può essere impossibile definire queste interfacce composite fino a che non siano stati analizzati i ritrovamenti. La stratificazione è tuttavia una testimonianza che presenta elementi sia positivi – deposizione – che negativi – erosione o distruzione.
LA SEZIONE ARCHEOLOGICA Una sezione archeologica è un disegno di un profilo verticale di terreno, come ci appare effettuando un taglio attraverso una massa di stratificazione. Due cose ci appaiono in sezione: - un’immagine degli strati sul piano verticale e - le diverse interfacce tra i volumi degli strati; Le sezioni offrono pertanto un esempio del tipo di sovrapposizione esistente in un sito.
TIPI DI SEZIONE ARCHEOLOGICA Esistono tre tipi principali di profili archeologici: -
la sezione in parete la sezione occasionale la sezione cumulativa
La sezione in parete viene creata nel corso dello scavo mediante la rimozione della stratificazione adiacente. Queste sezioni possono presentarsi lungo i bordi principali dello scavo, sulle pareti dei testimoni oppure come profili prodotti da uno scavo verticale eseguito per risolvere un problema stratigrafico o per sezionare un elemento. La sezione occasionale, non sono profili prodotti dallo scavo archeologico, ma sezioni messe in luce durante lavori di costruzione. La sezione cumulativa, venne proposta da Philip Baker come alternativa al mantenimento dei testimoni con le loro sezioni in parete. Il suo metodo presuppone lo scavo completo dei depositi presenti in sezione.
‘’Secondo questo metodo lo scavo viene condotto fino ad una linea prestabilita dopo che si disegna la sezione. Lo scavo poi procede oltre questa linea. Ogni volta che lo scavo raggiungerà la linea, la sezione verrà disegnata‘’ (Baker). La sequenza della stratificazione documentata in una delle sezioni cumulative di Baker corrisponde esattamente a quella che è stata scavata. Lo scavo stratigrafico è un processo di rimozione degli strati di un sito nell’ordine inverso a quello in cui si sono depositati e questo tipo di scavo segue i limiti e la forma naturale degli strati. Come gli strati vengono rimossi ad uno ad uno, così con la sezione cumulativa essi vengono anche documentati ad uno ad uno. La sezione cumulativa risponde ai requisiti di una moderna teoria della stratigrafia archeologica.
IL DISEGNA DELLE SEZIONE ARCHEOLOGICHE Webster ha distinto tre procedimenti per il disegno delle sezioni archelogiche: -
realistico schematizzato di compromesso;
Nel metodo realistico: ‘’le differenze tra i depositi sono indicate da cambiamenti dell’ombreggiatura … Non vi appaiono linee marcate se non per i muri di pietra e per il suolo vergine.’’ (Webster). Da qui nasce una controversia, che si incentra sull’identificazione delle interfacce nella stratigrafia archeologica. Le interfacce non sono oggetti materiali, come gli strati, non sono visibili, ma devono essere definite con l’esame e la demarcazione dei differenti strati. I limiti degli strati, i contorni della loro superficie in profondità, lunghezza e larghezza, costituiscono le linee di interfaccia. Nella sezione schematizzata vengono numerati invece sia le linee di interfaccia che gli strati. La sezione di compromesso ha un po’ di tutto; i suoi aspetti migliori sono considerati come parte della sezione schematizzata. Si dice che il metodo schematizzato, a causa delle linee di interfaccia, contenga il rischio della soggettività. Nell’analisi della stratificazione nelle sezioni può essere irrilevante che lo scavatore usi il tipo occasionale, in parete o cumulativo, poiché tutti questi possono essere documentati secondo il metodo schematizzato.
LA PIANTA ARCHEOLOGICA Le piante sono documentazioni di superfici , non di vedute di un piano. Le sezioni contengono solamente i contorni delle superfici delle unità stratigrafiche, mentre le piante possono indicare sia questi che i rilievi delle superfici di strato. Lungo la linea di una sezione viene indicato il contorno integrale della superficie di ogni attività stratigrafica: i rapporti stratigrafici tra le singole unità possono essere accertati
dallo studio di quelle interfacce. In una pianta solo i depositi più recenti presenteranno integralmente i contorni delle loro superfici. In altri termini, le piante sono una documentazione della lunghezza e della larghezza dei resti archeologici; le sezioni documentano il loro spessore. Una superficie non ha spessore; perciò, le piante sono, in senso stretto, documentazioni di un’interfaccia. Ogni pianta si riferisce solo ad una data; quella della più tarda unità stratigrafica che forma una parte della sua superficie. Le piante non indicano una sequenza, dal momento che ogni pianta costituisce solo la documentazione di una singola interfaccia più o meno orizzontale. Le sezioni, rappresentano in un sito la dimensione del tempo. Esse indicano la sequenza della deposizione attraverso una serie di strati e di interfacce l’una di seguito all’altro e ogni successiva interfaccia rappresenta un livello potenziale per una pianta. Le sezioni e le piante sono quindi complementari: una pianta indica le dimensioni topografiche di un sito in un determinato periodo; una sezione indica le dimensioni verticali del sito attraverso il tempo. Esistono diversi tipi di piante archeologiche: - quella complessiva degli elementi particolari - quella composita - quella di strato.
LA PIANTA COMPLESSIVA DEGLI ELEMENTI PARTICOLARI Questo tipo di pianta archeologica è un indice di tutti gli elementi di un certo tipo che appaiono su un determinato sito. Queste piante non sono stratigrafiche, poiché possono essere fatte solo ignorando la stratificazione (cioè gli strati) che esisteva prima e dopo la formazione di quegli elementi particolari. L’immagine della sovrapposizione che viene offerta in questo tipo di piante è ingannevole, dal momento che il grado di sovrapposizione è andato perduto. Se un elemento o un muro è più tardo di un altro, e quindi gli è ‘’sovrapposto’’, è impossibile dire, sulla base di queste piante, se uno ha distrutto l’altro o se gli giace semplicemente sopra senza alcuna diretta connessione stratigrafica. La pianta complessiva degli elementi particolari non è mai una documentazione primaria. Per tutte le piante archeologiche, si dovrebbero dare indicazioni fondamentali circa il tipo di testimonianza che devono venire illustrate su questi disegni.
LA PIANTA COMPOSITA Questo tipo di pianta è stata chiamata in tal modo perché documenta una superficie che è composta di più di un’unità stratigrafica. La pianta composita è stata usata per molti decenni ed è la forma abituale con la quale vengono pubblicate la maggior parte delle piante archeologiche. Una pianta composita è stata descritta: ‘’in pratica le piante dovrebbero mostrare un’immagine dell’intera superficie scavata, di cui nessuna parte dovrebbe essere esclusa dalla rappresentazione attraverso l’uso di segni convenzionali’’ (Biddle e Kjølbye-Biddle). La pianta composita viene eseguita quando su uno scavo sia stata rinvenuta una superficie di particolare importanza. Molte piante composite comunque contengono un certo numero di unità stratigrafiche, la maggior delle quali si sono formate molto prima del periodo rappresentato in pianta. Se queste piante sono ‘’ un’immagine
dell’intera superficie scavata’’, allora verranno documentate solo quelle parti delle unità stratigrafiche che appaiono alla superficie. Le piante composite sono pertanto un tipo di documentazione molto selettiva delle superfici delle unità stratigrafiche. Poiché richiedono molto tempo possono essere eseguite solo a determinati intervalli. La pianta composita attuale si basa su alcuni presupposti: 1- che sia possibile riconoscere intere superfici fondamentali nel corso dello scavo e prima dell’analisi dei reperti; 2- che l’identificazione di una superficie fondamentale comporti il ritrovamento di testimonianze evidenti, come muri, pavimenti, strade o ampi depositi di carattere particolare; 3- che solo quelle parti delle unità stratigrafiche che costituiscono una por...
Similar Free PDFs

Principi di Glottodidattica
- 238 Pages

Principi Di Politica- Constant
- 14 Pages

Riassunto Principi di marketing
- 84 Pages

Capitolo-04 - Principi di Marketing
- 36 Pages

I principi di biochimica di lehninger
- 114 Pages

Biochimica e principi di biochimica
- 17 Pages

riassunto libro principi di economia
- 43 Pages
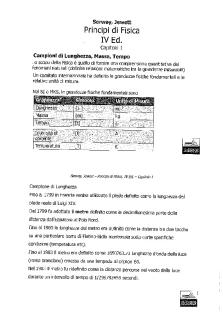
Principi di Fisica - Serway (cap.1)
- 13 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu