Profiler - Riassunto libro completo PDF

| Title | Profiler - Riassunto libro completo |
|---|---|
| Author | Eli Mar |
| Course | Marketing, consumi e comunicazione |
| Institution | Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM |
| Pages | 54 |
| File Size | 480.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 37 |
| Total Views | 155 |
Summary
Riassunto libro completo...
Description
Introduzione Il profiler è un professionista speciale e quando entra in gioco significa che c’è un caso dove non si capisce cosa sia successo e quale sia il movente. Quello che farà sarà prendere ogni elemento e incastrarli uno accanto all’altro come le tessere di un mosaico. Una volta risolto il problema quello che dovrà fare sarà verificare la correttezza delle proprie ipotesi (seguendo i processi o cercando un contatto diretto con il predatore). Al giorni d’oggi viviamo un momento di profondo smarrimento in cui siamo convinti che la situazione di criminalità stia aumentando. In realtà i dati non sono così drammatici il fatto è che la televisione, qualsiasi programma riserva una parte dal “fato criminale” d quindi tuto contribuisce a creare una diffusa percezione di paura. Quello che vogliamo fare è vivere sicuri. Ma cosa significa il termine “sicuro”? deriva dal latino sine cura. Ovvero senza preoccupazioni.
Parte prima Disinnesca la paura, riconosci il pericolo 1. La paura Tutto è cominciato con uno sbaglio Il caso di Albert B. è un caso molto famoso datato 1920, sulla quale hanno lavorato in coppia Watson e Rayner. Watson aveva studiato psicologia e min un’epoca dominata dlal0jnconscio e l’introspezione, si era messo a esplorare una strada diversa: per lui la psicoanalisi non aveva alcun significato. Per lui la ricerca doveva concertarsi sull’osservazione del comportamento e su come animali e uomini fossero capaci di imparare adattandosi all’ambiente circostante.
Il piccolo Albert Si tratta di un esperimento di cui ne è testimonianza anche un video in cui sulla destra vi è una giovane dona ovvero Rayner, a sinistra il professor Watson e in mezzo a loro un bimbo di neanche un anno seduto su un materassino. I due ricercatori offrivano al piccolo delle costruzioni e successivamente gli avvicinavano alcuni piccoli animali come un topolino bianco un coniglio e un can. Nessuna reazione di spavento nonostante lo annusassero ecc… A un certo punto però compariva l’assistente che colpì una sbarra di ferro con un martello provocando un rumore assordante. Sul volto del bambino l’iniziale sorpresa lasciò post lla paura. Ma questo succedeva no appena il topolino o gli altri animali toccavano il bimbo. Cosa voleva dimostrare l’esperimento? Si voleva dimostrare che dopo un po’ anche senza il rumore, bastava che i due ricercatori avvicinassero l’animale per far cambiare espressione adf Alber e cercare la fuga.
Il cervello emotivo La paura è un’emozione ed è fatta in tante parti: la risposta fisiologica con l’accelerazione o rallentamento del battito cardiaco, pallore o rossore ecc… La funzione delle emozioni è valutare ogni istante quello che
accade intorno a noi per permetterci di reagire. Il sistema emotivo ricalibra costantemente il nostro atteggiamento in rapporto al flusso di dati in arrivo e insieme regola il corpo preparandoci all’azione. Fino al 1884, anno in cui James pubblicò l’articolo “What is an Emotion?” , cadere preda della collera o del terrore significava solo cedere a una debolezza. Lui sosteneva che noi proviamo emozioni in risposta ai cambiamenti fisiologici del nostro corpo. Quindi il pianto non è la dimostrazione della nostra tristezza ma ci sentiamo tristi perché piangiamo. A contrastare le sue tesi ci fu il fisiologo Cannon che nel 1927 affermò che le nostre esperienze emotive possono verificarsi indipendentemente dall’espressione di un’emozione. Per sostenere la sua teoria sezionò il midollo spinale di alcune cavie impedendo così al cervello di ricevere informazioni sensoriali, per scoprire che, nonostante questo gli animali continua no a esprimere emozioni. Ma com’era possibile che la paura fosse la conseguenza di alcune alterazioni fisiologiche (es. aumento del battito cardiaco, sudorazione e bocco della digestione) se gli stessi cambiamenti venivano prodotti anche da un’altra emozione ossia rabbia o da una influenza? La spiegazione andava ricercata nel talamo (struttura specializzata situata al centro del nostro cervello). Le neuroscienze hanno poi fatto il loro ingresso nello studio delle emozioni grazie a una vecchia storia: il caso di Phineas Gage. È il 1848 quando capita l’incidente, e Phineas lavorava nell’impresa che si occupava di posare i binari di una ferrovia. Il suo compito era quello di togliere di mezzo le grosse rocce praticando un foro nella pietra e poi versando della polvere da sparo dentro, coprila con della sabbia e infine pressando tutto con una spranga di ferro. Soltanto che Gage quel giorno dimentica la sabbia e nel contatto con la roccia l’asta i metallo provoca una scintilla che innesca lo scoppio. La spranga penetra proprio sotto l’occhio sinistro di Phineas, ne attraversa la testa per uscire dalla parte superiore e finisce a qualche metro di distanza. Lui in tutto questo non perde conoscenza e anzi sopravvive anche per molti anni. Gage non riportò alterazioni nel linguaggio, paralisi o altri danni ma in molti che gli stavano attorno testimoniarono che in lui era successo qualcosa di strano: prima dell’incidente era considerato molto efficiente. Era un uomo intelligente e lavoratore, mentre a seguito dell’incidente diventò irriverente, capriccioso. Questo perché l’interruzione dei collegamenti tra la corteccia cerebrale prefrontale e le strutture profonde e più antiche, ha portato a “liberare” il cervello emozionale dalle regole e dalla disciplina del cervello razionale. Vediamo ora una classificazione delle emozioni primarie. Per Plutchik queste sono divisibili in 4 coppie: 1) 2) 3) 4)
Disgusto e accettazione Tristezza e gioia Sorpresa e attesa Paura e rabbia
E da queste combinazioni deriverebbero tutte le altre come la gelosia, la rassegnazione, il rimorso e la vendetta. Per Ekman invece le emozioni fondamentali sarebbero solo 6: 1) 2) 3) 4)
Disgusto Sorpresa Gioia Dolore
5) Rabbia 6) Paura
Perché abbiamo paura La paura è la reazione emotiva che proviamo di fronte a un pericolo esterno una minaccia alla nostra integrità e si manifesta con uno stato di allerta e insieme di disagio e inquietudine. A differenza dell’ansia è un fenomeno normale che spinge all’evitamento o alla fuga e il cui scopo è la sopravvivenza. Lo psicologo Izard ha proposto tre categorie per distinguere le cause della paura: 1) Persone o situazioni del mondo esterno 2) Pulsioni o altre emozioni che arrivano dalla nostra mente come la paura di parlare di fronte a un pubblico 3) Processi cognitivi dell’immaginare e del prevedere Inoltre possono essere riconoscibili e innate, o svilupparsi con l’esperienza e l’apprendimento, tanto consapevole quanto condizionato. Le paure innate per Gray, sono sempre legate ad almeno una di queste cause scatenanti: manifestazione di stimoli fisici intensi (dolore o rumore forte), esposizione a situazioni che possono essere persone totalmente sconosciuti che non sappiamo come affrontare, le situazioni di pericolo che mettono a rischio la sopravvivenza della specie come il buio, l’altezza e infine la presenza di animali che mostrino atteggiamenti aggressivi. La paura scatta automaticamente, senza il bisogno di un’analisi approfondita delle informazioni. Il condizionamento però (caso di Albert) può però trasformare qualunque stimolo neutro, come un topolino, in qualcosa di scioccante; basta associarlo a uno stimolo capace di provocare paura come l’improvviso rumore di un martello contro una sbarra di ferro. Inoltre si può anche provare paura non solo per l’esperienza diretta di una minaccia ma anche guardando delle immagini (per esempio un film).
I gradi della paura Esistono dei gradi della paura: 1) Al primo livello c’è il timorequando affrontiamo una situazione ambigua che promette di regalarci una sensazione piacevole ma che potrebbe anche celare un rischio 2) Ansia è generata da una situazione di incertezza in cui la promessa del piacere e la minaccia del dolore sembrano equivalere 3) Paura condiziona il bisogno di allontanarsi da un pericolo 4) Panicoil bisogno di fuggire è così forte da sottrare ogni scelta al confronto con la ragione 5) Terrore porta al ritiro, alla chiusura in se stessi e alla fuga all’interno del proprio corpo 6) Orrore la situazione appare minacciata e si arricchisce di note di ribrezzo e crudeltà inaccettabili RICORDA: può capitare però che il panico non porti alla fuga ma all’immobilità e alla paralisi.
La casa e il linguaggio della paura
Il sistema limbico è la struttura del cervello che governa la percezione e l’espressione delle emozioni. Nel sistema limbico troviamo anche l’amigdala, una piccola parte del cervello a forma di mandorla situata sotto la corteccia del lobo temporale. È importante sia nella gestione della rabbia e il suo funzionamento è essenziale anche nel riconoscimento dei pericoli. A tal proposito è bene citare il caso di una donna affetta da una patologia genetica rara di nome Mary. Questa paziente si è ammalata e alcune parti del suo corpo, compresa l’amigdala si erano calcificate prima di distruggersi. il suo comportamento era cambiato drasticamente: non aveva più timore di niente.
La paura innata L’essere umano è in grado di provare paura sin dai primi istanti di vita e questo accade perché già da bambini veniamo esposti a stimoli del tutto nuovi e inaspettati come volti nuovi ecc… Le paure dei bambini poi compaiono e si dissolvono nel orso della crescita lasciando spazio a nuovi timori. Ma le paure che invece accomunano bambini e adulti sono la paura dell’altezza e quella dello sguardo.
La paura liquida Molte volte capita che si provi paura di determinati eventi e situazioni, nonostante la consapevolezza che non vi sia alcun pericolo reale, e questo si pone in contrasto con comportamenti rischiosi come fumare o mangiare cibi troppo grassi. Simili comportamenti infatti causano più vittime degli squali e di altri animali che sembrano terrorizzarci maggiormente. Ai timori diffusi nel lontano passato si sono sovrapposte nuove paure: incerte, sfumate e liquidamente pervasive. È stato il sociologo Bauman a definire la società in cui viviamo “liquida” descrivendone le caratteristiche a partire dalla crisi degli Stati Nazionali (strutture capaci di garantire a ciascuno di noi la possibilità di affrontare i problemi in modo organico), o ancora al disfacimento delle ideologie. E in un mondo liquido anche la paura si è fatta liquida. Siamo vittime si un diffuso senso di impotenza, dell’impressione di non poter controllare più nulla. Questa impotenza porta alla nascita dell’insicurezza del presente e dell’incertezza del futuro che alimentano le 3 principali minacce alla nostra vita: 1) Il timore che venga meno la stabilità e l’affidabilità dell’ordine sociale da cui dipende la sicurezza di avere un lavoro 2) Paura di perdere il nostro posto nelle gerarchie del mondo (classe sociale) 3) Viviamo nell’angoscia che qualcuno ci aggredisca (rapinatori, terroristi) Tutte queste paure si fondono insieme lasciandoci addosso un senso di insicurezza. Per esempio le voci sulla crisi economica si gonfiano con l’annuncio di un attentato terroristico. Questi eventi del tutto slegati tra loro finiscono per produrre un effetto massa producendo un’unica grande paura liquida. Tutti gli italiani d’oggi credono che l’Italia non ha mai avuto così tanti omicidi, rapine come oggi per poi stupirsi nello scoprire che il numero di delitti non è mais tato così basso dal 1861. I giornali e televisione hanno svolto e lo fanno tutt’ora, un ruolo decisivo nell’alimentare la liquidità delle nostre paure. Bisogna però sapere che la conoscenza può trasformare l’angoscia in curiosità che è il primo passo per disfarsene.
2. Una decisione può salvarti la vita
Scegliere con giudizio Ne abbiamo parlato per quanto riguarda le emozioni ma anche di fronte a un a scelta importante, per secoli la logica, la ragione hanno rappresentato lo strumento ideale cui affidarsi, la guida su cui contare dav anti a un problema da risolvere. Per esempio Benjamin Franklin nell’800 circa suggerì di affrontare ogni questione delicata prendendo un foglio. Dividendolo a metà e rispostando da un lato i pro e dall’altro i contro per ogni soluzione ipotizzata (modello chiamato “algebra morale”). Ma questo modello come tanti altri modelli razionali, descrivono solo in modo efficace quale dovesse essere il comportamento ideale, ma fallivano nel prevedere le condotte future. Infatti nel 1957 Simon rivoluzionò la storia dei processi decisionali infatti secondo lui la razionalità nelle decisioni non poteva che esser eliminata. L’uomo bombardato da centinaia di informazioni caotiche e frammentarie. Non poteva che affidarsi a processi cognitivi per i quali inventò anche un neologismo, satisficing (satisfy+suffice) oppure utilizzare euristiche di ragionamento, scorciatoie che combinavano il bisogno di accuratezza con la necessitò di contenere lo sforzo mentale.
Trappole e scorciatoie Nel 1979 Kahneman e Tversky presentarono la teoria del prospetto: il loro lavoro era centrato sulle scelte in condizioni di rischio, e descriveva il comportamento di un individuo in situazioni reali. Arrivano a dire che vi sono due tipi di processi di pensiero: pensiero lento e pensiero veloce. Alla base di questi due pensieri ci sarebbero due sistemi cognitivi, due strade quindi per valutare le informazioni e prendere decisioni. Il pensiero lento prende il nome di sistema 1 ed è la parte più primitiva mentre il pensiero veloce e prende il nome di sistema 2 ed è quella più moderna del nostro cervello. Essi sono comunicanti tra loro, ma mentre il primo è caratterizzato da una modalità intuitiva, veloce, emozionale e automatica di prendere decisioni; il secondo è controllato, razionale, lento e pigro. Tutti noi pensiamo di operare in modalità 2 ma in realtà è il sistema 1 a governare la maggior parte delle nostre scelte. In questo caso le euristiche possono essere viste come scorciatoie mentali: di fronte alla complessità del mondo che ci circonda, il nostro cervello si affida a strategie di pensiero rapide ed efficaci, intuitive e automatiche. Esse facilitano la nostra vita e sono spesso determinanti per la nostra sopravvivenza, ma semplificando la realtà ci espongono a errori sistematici, a trappole cognitive chiamate bias (pregiudizi). Tra le euristiche più note troviamo: -
-
Euristica della rappresentatività utilizza stereotipi e somiglianze per classificare oggetti, situazioni e individui. Es. nei casi di cronaca tendiamo sempre a pensare che il responsabile della morte di una donna sia il marito Euristica della disponibilità gli eventi che ricordiamo, ma soprattutto quelli che spiccano per semplicità , chiarezza sono determinanti nella previsione di un evento futuro. Euristica dell’ancoraggio ogni volta che giudichiamo un fatto specifico lo facciamo in rapporto a un valor e di riferimento, un’ancora.
I bias (pregiudizi) invece sono tantissimi: -
Bias di conferma ovvero l’insieme dei processi che rendono più credibili le informazioni che confermano le nostre convinzioni e che quindi ci fanno sminuire quelle che contraddicono
-
Hindsight bias (ragionare con il senno di poi) anche questo è uno degli errori in cui cadiamo più spesso. Ci autoconvinciamo di aver previsto un avvenimento solo dopo che è accaduto Overconfidence eccessiva fiducia nelle nostre capacità di giudizio Illusione del controllo sovrastimiamo la possibilità di influenzare gli eventi esterni
Davanti al pericolo Klein è uno psicologo americano cje erano convinto che in condizioni d’emergenza i pompieri non valutano ogni scelta possibile ma stimano almeno due opzioni, confrontandole per poi scegliere la migliore. Ma dopo molti colloqui scoprì invece che i vigili del fuoco non prendono in considerazione nulla e si limitano ad agire. Quello che scoprì fu che quindi la gente usa l’intuizione per prendere decisioni: noi tutti siamo dei decision markers intuitivi tutti noi ci affidiamo all’intuizione. Al contrario alcuni sostengono il primato dell’analisi razionale in qualunque contesto decisionale. Ma come funziona il processo di didecision making intuitivo/RPD (Recognition-Primed Decision)? Quando nella testa scatta un campanello d’allarme, le esperienze vissute vengono inconsciamente legate insieme per formare uno schema. Quindi nel momento in cui viviamo una nuova situazione, questa genera agganci che portano al riconoscimento di schemi già collaudati: riconosciuto il pattern (schema), appare chiaro il senso della situazione. Gli schemi prevedono inoltre alcune routine di risposta: gli action scripsts usati per fa accadere delle cose e capaci di modificare la situazione di partenza. Però vi sono due problemi: 1) Riguarda la fiducia sulla propria impressione iniziale: infatti maggiore è il vissuto, maggiore sarà il numero di schemi interiorizzati che rendono un problema familiare. Quando una situazione viene riconosciuta è probabile che la prima soluzione sia quella giusta 2) Come si fa a valutare il potenziale svolgimento di un’azione (action script) se non lo confrontiamo almeno con una seconda opzione? La chiave questa volta è la capacità di operare una “simulazione mentale”: per esempio il vigile del fuoco valuta la situazione immaginando uno scenario, simulando nella propria mente le conseguenze positive e negative. Se la simulazione è convincete allora questa viene tradotta in azine, altrimenti si cambia l’actions cript e si passa all’opzione successiva. Riassumendo, l’RPD funziona attraverso 4 passaggi: 1) 2) 3) 4)
Le informazioni che arrivano dall’ambiente permettono di riconoscere degli schemi Gli schemi attivano gli action scripts Gli action scripts sono valutati attraverso le simulazioni mentali Le simulazioni sono guidate dai modelli mentali
Fettine di esperienza, veloci e frugali
Thin slicing tagliare in fette sottili. Vuol dire osservare la realtà, estrarne piccoli campioni e da questi ricavare informazioni utili per decidere. Il termine risale al 1922 ma colui che ha reso famoso questo concetto fu il giornalista scientifico Gladwell. Per lui il thin slicing è una qualità essenziale dell’essere umano. Vi rincorriamo quando facciamo una nuova conoscenza, dobbiamo capire qualcosa in fretta o affrontiamo una situazione inedita. In linea con quanto sostenuto da Kelin e divulgato da Gladwell vi è Gigerenze che è convinto che la nostra società faccia troppo affidamento sul pensiero razionale e che le buone scelte non devono sempre basarsi su una ponderazione attenta dei pro e dei contro. Per lui conta infatti più l’intuizione, che lui chiama anche “sensazione viscerale” e che ha 3 caratteristiche: 1) Affiora rapidamente 2) Lo fa senza la nostra consapevolezza dei suoi fondamenti e delle sue ragioni 3) Possiede una forza sufficiente per indurci ad agire Per lui “di più non è sempre meglio”, ma questo concetto è difficile da accettare visto che per noi è sempre meglio essere più informati e avere più scelte. Però ci sono situazioni in cui meno è decisamente l’opzione migliore. Concludendo, secondo Gigerenzer, quando pensiamo a cose difficile da prevedere e abbiamo poche informazioni, dobbiamo fidarci del nostro intuito.
Allarme giallo La consapevolezza situazionale (SA) si è imposta a partire dagli anni ’90. Sia la SA che l’RPD di Klein hanno trovato vasta applicazione in campo militare e tra le forze dell’ordine. La SA è un’abilità utile a tutti, soprattutto di fronte a una situazione di pericolo. Perché essere consapevoli di una minaccia prima che si realizzi può fare la differenza. Avere consapevolezza situazionale vuol dire cogliere ogni informazione e dettaglio dell’ambiente in cui viviamo e ci muoviamo. Ma la SA include anche la capacitò di sapere dove guardare e di riconoscere i comportamenti o i segnali d’allarme cui fare attenzione. Un modello ampliato di SA è stato sviluppato negli anni 80 da Boyn un colonnello dell’aviazione statunitense e l’ha chiamato con l’acronimo OODA (Observe, Orient, Decide and Act). Dai primi due elementi dipende la decisione come poi tradurla in azione. -
-
Osservare questo elemento consiste in un’attenta osservazione. Osservare però non significa solo guardare, ma utilizzare tutti i se...
Similar Free PDFs

Profiler - Riassunto libro completo
- 54 Pages

Riassunto libro
- 55 Pages

Aura resumen completo libro
- 3 Pages
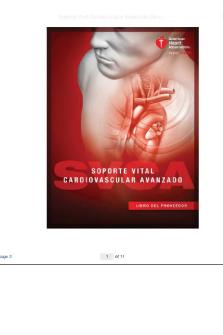
ACLS 2015 Libro Completo
- 213 Pages

Flatlandia Abbott - Libro completo
- 62 Pages

El Principito Libro Completo
- 111 Pages

Coraline libro completo
- 98 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu








