FINE PENA Teoria generale del dritto PDF

| Title | FINE PENA Teoria generale del dritto |
|---|---|
| Author | Angela Chiantia |
| Course | TEORIA GENERALE DEL DIRITTO |
| Institution | Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro |
| Pages | 4 |
| File Size | 75 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 18 |
| Total Views | 134 |
Summary
Download FINE PENA Teoria generale del dritto PDF
Description
ELVIO FASSONE FINE PENA: ORA Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Nemmeno tra due amanti, ammette l’autore, è pensabile uno scambio di lettere così lungo. Questo non è un romanzo di invenzione, ma una storia vera. Nel 1985 a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati all’ergastolo Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della Corte d’Assise ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto e quasi – la parola non sembri inappropriata – di fiducia. Il giorno dopo la sentenza il giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro. Ripensa a quei due anni, risente la voce di Salvatore che gli ricorda: «se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia». Non è pentimento per la condanna inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena. E non astrattamente, ma nel colloquio continuo con un condannato. Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove norme rendono il carcere durissimo con il regime del 41 bis. La corrispondenza continua, con cadenza regolare – caro presidente, caro Salvatore. Il giudice nel frattempo è stato eletto al CSM, è diventato senatore, è andato in pensione, ma non ha mai cessato di interrogarsi sul problema del carcere e della pena. Anche Salvatore è diventato un’altra persona, da una casa circondariale all’altra lo sconforto si fa disperazione fino a un tentativo di suicidio. Questo libro non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, è un’opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato. C’è un dialogo in questo libro di Elvio Fassone, Fine pena: ora, pubblicato da Sellerio, che fa sobbalzare. Fassone è un magistrato illustre, ha fatto parte del Csm, è stato per due legislature senatore della Repubblica. Il suo interlocutore, Salvatore, è un mafioso catanese imputato in Corte d’Assise, pluriomicida, futuro ergastolano... «“Presidente, lei ce l’ha un figlio?” Ne ho tre, e il maggiore ha solo qualche anno in meno di Salvatore. (...) “Glielo chiedo perché le volevo dire che se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo”». È un libro dolorante e bellissimo, una storia minuziosamente vera, scritta con umanità profonda, senza falsa pietà, senza linguaggi melensi. Il giudice e l’ergastolano sono soltanto uomini, alla pari, anzi qualche volta Fassone fa persino venire il dubbio in chi legge che si senta lui il colpevole, nel nome di una società che non fa ciò che deve: «La detenzione, ove non mitigata da un trattamento educativo reale, è una morte parziale, l’asportazione di una porzione di vita», scrive in una pagina del libro. E 1
ancora: «La comunità offesa dal delitto si fa risarcire con fette di vita prelevate chirurgicamente da quel bisturi inappuntabile che è il processo». Com’è nato questo libro che ha echi dostoevskijani e rammenta anche certi squarci di Dürrenmatt, ma è privo di ogni tentazione letteraria? Elvio Fassone, nel 1985 presiede a Torino, in Corte d’Assise, un maxiprocesso, 242 imputati della mafia catanese, 300 mila fogli di istruttoria. Salvatore ha 27 anni, è sotto giudizio per un’infinità di delitti efferati. Già dalla prima udienza vuol mostrare di essere un capo, non risponde agli appelli, si arrampica come una scimmia sulle sbarre della gabbia. Fassone non alza la voce, rifiuta le provocazioni. Salvatore, intelligente, scaltro, non insiste. Una serie di fatti fa sì che il mafioso guardi con occhi attenti il giudice. Non è un mostro: autorizza il viaggio in Sicilia di Salvatore — la madre sta morendo — fa sì che ad accompagnarlo siano agenti in borghese. I vicini di casa non lo vedranno con le manette ai polsi. Fassone decide poi di dedicare una parte del pomeriggio ai bisogni innumerevoli dei detenuti, il ricevimento di un’umanità varia e questo gli crea consenso. Il processo dura più di un anno, la camera di consiglio, nella foresteria del carcere, dura un mese. Per leggere la sentenza occorrono tre ore. «Assassini» urlano imputati e famigliari. Commenta il giudice: «In fondo la donna che ha gridato ha qualche viscerale ragione: anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge».L’udienza è tolta, ma non per Elvio Fassone. Salvatore gli è rimasto nella mente. Decide di scrivergli — «con che spirito leggerà queste parole, se non come l’ipocrita tentativo del carnefice di sgravarsi la coscienza accarezzando la sua vittima?» — gli manda anche un libro, Siddharta, di Hermann Hesse, leggenda sui sentimenti fraterni, più taoista che indiana. Come reagirà? Manderà al diavolo quello strano giudice che gli scrive: «Potrà perdere la libertà per un tempo anche lungo, ma non deve perdere la dignità e la speranza»?Salvatore invece risponde: «Presidente, io lo so che lei mi ha dato l’ergastolo perché così dice la legge, ma lei nel suo cuore non me lo voleva dare. E io la ringrazio del libro e le assicuro che farò come lei dice». Si scriveranno per 26 anni. Fine pena: ora è uno specchio del mondo, un altro mondo, malvagio. Le lettere sono genuine, nessuno dei due ha da chiedere qualcosa all’altro. Fassone, si capisce, non trova mai una risposta all’interrogativo del giudice onesto: «Perché si punisce?». E soprattutto: «Chi sono io per punire?». Salvatore non perde la speranza. Prende un diploma di giardinaggio, vuol fare un corso di ebanista, poi un altro corso di grafica, lavora in cucina, diventa un attore non disprezzabile in una compagnia del carcere, ha l’ambizione di arrivare al diploma di terza media e per studiare rinuncia anche all’ora d’aria. Commenta Fassone: «Il confronto è inevitabile con certe levigate adolescenze, punteggiate di magliette e scarpe griffate». Ma l’inferno è certo. «Che vuole che ci aspetti, a chi nasce nel Bronx di Catania?» «Dice proprio così», scrive il giudice, «deve averlo sentito alla televisione, e lo ripete con eleganza guappa e disperata». La libertà è come un miraggio, l’acqua nel deserto. Il libro insegna che cosa è la prigione più di tanti trattati di criminologia. Il 41bis è una tragedia, le carceri di massima sicurezza cancellano ogni forma di vita. Le lettere di Salvatore si fanno sempre più cupe. Salvatore sente il suo destino come una cappa maledetta. «Ce lo detto presidente, che dove cammino io non può crescere l’erba... che se io tocco l’oro diventa ferro». Ma all’ergastolano che non vuole perdere la speranza le lettere del giudice sono davvero utili. «Le condanne non insegnano nulla, anzi incattiviscono, ma lei le sue lettere insegnano tanto, sono come un libro che insegna la vita». I permessi, le licenze, la 2
semilibertà sono i sogni, le ragioni di vita, come l’art.21 dell’Ordinamento penitenziario, il lavoro all’esterno. Ma il primo permesso è un trauma: «Presidente, non sapevo nemmeno camminare. Fuori anche l’aria che si respira è diversa da dentro. È tutto nuovo per me, le macchine, la roba che c’è nei negozi, la gente come è vestita, anche il fatto di pagare con l’euro». Rosi, la ragazza che per anni è andata a trovarlo di penitenziario in penitenziario, lo lascia. Un dolore immenso. Lavora in un vivaio, media nel conflitto tra gruppi di carcerati, potrebbe essere elogiato, viene invece ritenuto un capo, perde ogni beneficio. La burocrazia è ottocentesca, non gli viene dato l’articolo 21 perché un detenuto che l’ha avuto ha violentato una ragazza. Si sente un perseguitato — «non c’è amarezza o sofferenza che non ho conosciuto» — Il giudice cerca di incoraggiarlo, non è facile. Poi un nuovo trauma. Nella sua cella le guardie trovano un telefonino. Salvatore non c’entra. Sarebbe stato facile controllare i numeri. Non viene fatto: tutti al 41bis, cancellata ogni misura alternativa. L’ergastolano scrive a Fassone: «L’altra settimana ne ho combinato una delle mie: mi sono impiccato, mi scusi». Un agente di custodia lo salva. È passato più di un quarto di secolo. Elvio Fassone osserva una fotografia di Salvatore. Quando l’ha conosciuto era «un fascio di muscoli e di nervi, pronto a scattare come una molla compressa». Adesso sembra L’urlo di Munch. La sensazione immediata è quella di trovarsi di fronte a un libro importante e necessario, in primo luogo per gli stimoli che infonde a chi ogni giorno, anche con ruoli diversi, si affaccia sul mondo della penalità e tenta di conciliare il carcere con la giurisdizione, le norme con le persone, le formule e i riti con la carne e la vita vere.
Un libro così, capace di commuovere e coinvolgere senza ricorrere a un filo di retorica o di bigotto paternalismo, lo puoi commentare solo con il ricorso a qualche citazione, che almeno ti aiuta a far arrivare a piccole e attraenti dosi la voce dello scrittore. La storia prende le mosse dalla scelta di un giudice, l’autore stesso, che, il giorno dopo aver irrogato la pena dell’ergastolo, scrive d’impulso una lettera al suo ergastolano, al giovane boss catanese che già durante il processo aveva imparato a conoscere come uomo, oltre che come imputato. Come questa conoscenza sia stata possibile già durante il procedimento bisogna scoprirlo leggendo; è una scoperta appassionante, buona per scrollarsi di dosso le tristi sensazioni di una routine giudiziaria quotidiana dove troppo spesso l’imputato è “presente al giudice quale semplice entità metafisica, una sorta di contrappunto concettuale e anonimo alla nozione della contumacia”. Da quella scelta, da quella lettera accompagnata anche dal regalo di un libro significativo, nasce una corrispondenza tra il giudice e Salvatore lunga ventisei anni. Lo scambio epistolare con il suo giudice ritma la vita di Salvatore, tra timide esaltazioni per i traguardi raggiunti e nere frustrazioni per una meta, quella del ritorno in società, che si sposta sempre in avanti senza arrivare mai. Per ventisei anni. Un tempo lungo, lo stesso necessario per arrivare, se si è ergastolani e si è stati bravi, alla liberazione condizionale. Tuttavia per Salvatore quella libertà non può arrivare. Nel frattempo, infatti, lo Stato ha dovuto prendere le misure alla criminalità organizzata e in piena emergenza mafiosa è scattato il “giro di vite” dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. In altre parole, se sei dentro per mafia e per una serie di altri (molti, troppi) delitti equiparati, non c’è 3
rieducazione che tenga. L’unico modo per mettere il naso fuori dalla pena perpetua è collaborare con la giustizia, mettere in mostra una “disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri individui)” che con il reinserimento sociale “ha poco a che spartire” e che spesso neppure è umanamente esigibile. Non ci si può fermare soltanto a evidenziare la profondità e l’autenticità delle riflessioni sul carcere, in cui ci imbattiamo scorrendo le immagini di una vita in galera. Occorre, piuttosto, provare a riflettere sulle sensazioni che si sedimentano dopo la lettura e, soprattutto, accettare la sfida politica che l’autore lancia attraverso una postilla dedicata alle possibili modalità di superamento dell’ergastolo, pena diseguale per eccellenza. Due riflessioni, prima di ogni altra. Chiuso il libro, ci si confronta subito con il pensiero forte che il fare giustizia non possa e non debba finire con la sentenza di condanna. Troppo spesso, al contrario, ci si accontenta di quel punto di arrivo. Per il dopo si accetta o si pretende che il muro della galera soddisfi i sentimenti della vittima, degradi sufficientemente il colpevole, tranquillizzi il buon senso. Una coazione a ripetere che, sinora, non ha portato più sicurezza, non ha ristorato le vittime, ma spesso, in compenso, ha fatto fuori le vite dei colpevoli. Un mutamento di paradigma si impone, anche a partire da una considerazione ancora non unanime: dopo la sentenza c’è ancora bisogno di giustizia, di giudici, di giurisdizione. C’è bisogno, poi, di conoscenza ravvicinata delle persone. E qui viene in mente il secondo importante lascito della lettura, che conduce a una considerazione da ribadire con forza: la conoscenza reale degli uomini che il giudice si trova davanti, in carcere come in tribunale, non fa male alla giurisdizione, non inquina il formalismo, non sporca la tabula rasa. Semmai, rende più efficace la giustizia penale, la fa assomigliare meno al dito puntato contro il capro espiatorio di turno e la traghetta in un campo dove, accanto alle responsabilità personali, vengono in rilievo anche quelle collettive e sociali. L’unica giustizia costituzionale è quella che si toglie la benda. Rimane il tema della battaglia politica contro l’ergastolo, se non altro nella sua variante assoluta e ostativa. È una sfida culturale che merita risposte all’altezza, almeno in termini di impegno. Questa Rivista la accetta e intende portarla avanti con la riflessione culturale, l’analisi e la critica della giurisprudenza, la proposta normativa. Salvatore direbbe: lasci stare, ce lo detto che sono maledetto. E invece no.
4...
Similar Free PDFs

teoria generale del diritto
- 35 Pages

Teoria del gran hombre
- 3 Pages
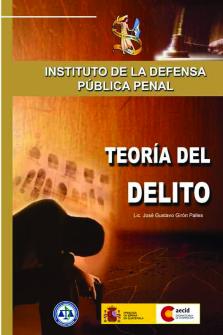
TEORIA DEL DELITO LIBRO
- 158 Pages

Teoria del comportamiento , PDF
- 6 Pages

Teoria DEL Derecho. Preguntas
- 21 Pages

Teoria del productor
- 5 Pages

Teoria DEL Aprendizaje Significativo
- 37 Pages

Teoria DEL Color Newton
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu







