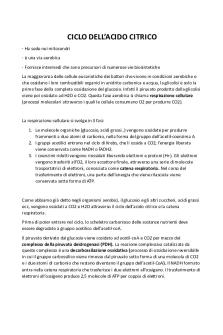Riassunto biochimica di lehninger PDF

| Title | Riassunto biochimica di lehninger |
|---|---|
| Author | Rodolfo Colciago |
| Course | Biochimica |
| Institution | Università telematica San Raffaele Roma |
| Pages | 54 |
| File Size | 3.5 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 3 |
| Total Views | 697 |
Summary
Warning: TT: undefined function: 32GLI AMMINOACIDILe proteine mediano tutti i processi che hanno luogo nelle cellule e svolgono un numero enorme di funzioni. Sono le macromolecole biologiche più abbondanti e sono presenti in tutti i tipi di cellula. Sono il prodotto finale dell’ informazione genica ...
Description
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
GLI AMMINOACIDI Le proteine mediano tutti i processi che hanno luogo nelle cellule e svolgono un numero enorme di funzioni. Sono le macromolecole biologiche più abbondanti e sono presenti in tutti i tipi di cellula. Sono il prodotto finale dell’ informazione genica e assolvono a numeroso funzioni specifiche. Le proteine sono polimeri degli amminoacidi, in cui ogni residuo amminoacidico (amminoacido che ha perso una molecola d’acqua quando si unisce ad un altro) è unito a quello vicino attraverso uno specifico legame covalente. Esistono 20 amminoacidi differenti presenti nelle proteine i quali sono sempre alfa-amminoacidi. Sono formati da un atomo di carbonio centrale (carbonio-alfa) a cui è legato un gruppo carbossilico, un gruppo amminico, un idrogeno e una catena laterale (catena R) il quale è diverso per ogni amminoacido e si differenzia per struttura, dimensione e carica e quindi influenza anche la solubilità dell’amminoacido in acqua. Ad ogni amminoacido è assegnata una abbreviazione a tre lettere e un simbolo a una lettera. Il carbonio-alfa degli amminoacidi lega 4 gruppi atomici differenti è dunque un centro chirale fatta eccezione per la glicina. (che ha due idrogeni) A causa della disposizione tetraedrica degli orbitali di legame, i quattro gruppi funzionali possono disporsi in due modi differenti nello spazio, quindi per ogni amminoacido sono possibili due stereoisomeri, in particolare due enantiomeri essendo l’immagine speculare l’una dell’altra non sovrapponibile. Per questo sono anche otticamente attive ovvero fanno ruotare il piano della luce polarizzata in maniera perfettamente opposta. Questi due entantiomeri vengono descritti con i sistemi D e L: si assegna la configurazione D all’ amminoacido che presenta il gruppo a priorità maggiore (NH2) a destra. Nelle proteine troviamo solo amminoacidi a sistema L.
Classificazione degli amminoacidi Gli amminoacidi possono essere classificati in 5 classi principali in base alle proprietà dei gruppi R utilizzando in particolare la polarità: cioè la tendenza ad interagire con l’acqua. Un'altra classificazione distingue gli amminoacidi essenziali e non essenziali. Quelli essenziali non sono sintetizzabili attraverso il metabolismo e quindi devono essere introdotti con la dieta. -gruppi R alifatici non polari: in questo gruppo ci sono gli amminoacidi con gruppi R non polari e quindi idrofobici. Le catene laterali di: ALANINA, VALINA, LEUCINA e ISOLEUCINA tendono a raggrupparsi all’ interno della proteina stabilizzando la struttura con interazioni idrofobiche. La GLICINA invece ha la struttura più semplice e la sua piccola catena laterale non contribuisce alla formazione di interazioni idrofobiche. La METIONINA è uno dei due amminoacidi non polari contenente zolfo (l’altra è la cisteina) e la PROLINA invece ha una caratteristica struttura ciclica. -gruppi R aromatici: sono tre e sono: FENILANINA, TIROSINA e TRIPTOFANO, con le loro catene aromatiche sono relativamente non polari e possono intervenire nelle interazioni idrofobiche. -gruppi R polari non carichi: i gruppi R di questi amminoacidi sono solubili in acqua perché contengono gruppi funzionali che formano legami a idrogeno con l’acqua. Comprende: SERINA, TREONINA, CISTEINA, ASPARAGINA E GLUTAMMINA. La polarità della serina e treonina è dovuta al loro gruppo ossidrilico, quella dell’asparagina e glutammina ai loro gruppi amminici mentre quella della cisteina è molto modesta ed è dovuta al gruppo solfidrilico. -gruppi R carichi positivamente (basici): sono la LISINA, l’ARGININA e l’ISTIDINA -gruppi R carichi negativamente (acidi): sono l’ASPARTATO e il GLUTAMMATO. GLI AMMINOACIDI POSSONO COMPORTARTI DA ACIDI O DA BASI Allo stato puro gli amminoacidi sono sostanze ioniche cristalline, ma in soluzione acquosa i gruppi carbossilici COOH e quelli amminici NH2 degli amminoacidi insieme con i gruppi R ionizzabili si trovano in forma ionizzata. Quando un amminoacido che non possiede un gruppo R ionizzabile viene sciolto in acqua si comporta sia da base che da acido debole, diventando così ione dipolare o zwitterone. I composti che hanno questa doppia natura (acido-base) sono detti anfoliti. 1
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
Ad esempio un semplice amminoacido mono amminico e monocarbossilico come l’alanina quando protonato diventa un acido in quanto possiede due gruppi funzionali che possono cedere protoni. Il PH caratteristico la quale la carica elettrica è zero è detta punto isoelettrico
LE PROTEINE Le proteine sono i polimeri degli amminoacidi i quali posso variare tra 3 fino a migliaia di residui. Due amminoacidi si legano covalentemente attraverso un legame detto peptidico. Questo legame avviene tra il gruppo carbossilico di un primo amminoacido con il gruppo amminico di un secondo e porta all’ eliminazione di una molecola d’acqua attraverso una reazione di condensazione. Il legame peptidico è molto stabile. Quando il numero degli amminoacidi è relativamente piccolo viene detto oligopeptide, se invece gli amminoacidi sono tanti viene detto polipeptide. L’ amminoacido con cui inizia la catena che ha il gruppo amminico libero è detto ammino terminale mentre l’estremità finale con il gruppo carbossilico libero è detto carbossiterminale. Alcune proteine sono costituite da una singola catena polipeptidica, mentre altre chiamate proteine multi subunità o multimero hanno due o più polipeptidi associati in modo non covalente. Un multimero formato da poche subunità è anche detto oligomero. Le catene polipeptidiche presenti in una proteina multi subunità possono essere identiche o diverse tra loro. Se almeno due sono identiche, la proteina viene detta oligomerica e le unità identiche sono chiamate protomeri. L'emoglobina per esempio ha quattro sub-unità polipeptidiche: due catene alfa identiche e due catene beta identiche. Molte proteine invece sono costituite soltanto da amminoacidi e nessun altro gruppo chimico queste sono considerate proteine semplici. Altre proteine presentano oltre agli amminoacidi altri gruppi chimici addizionali associati permanentemente e sono chiamate proteine coniugate. La parte non amminoacidica della proteina coniugata viene detta gruppo prostetico. per esempio, le lipoproteine contengono lipidi o glicoproteine che contengono zuccheri. Ogni proteina ha un'unica sequenza amminoacidica che le conferisce una particolare struttura tridimensionale ed in base alla struttura e quindi al tipo ripiegamento le proteine hanno determinate funzioni: funzione di trasporto: emoglobina e albumina ecc. funzione catalitica: enzimi funzione strutturale: cheratine e collagene ecc.… funzioni specializzate: immunoglobuline La disposizione spaziale degli atomi di una proteina è detta CONFORMAZIONE, le conformazioni possibili di una proteina o di un suo segmento corrispondono a tutte le strutture che la proteina può assumere senza la rottura dei legami covalenti e quando si trovano nel loro stato conformazione funzionale (ovvero il ripiegamento che gli permette di svolgere le proprie funzioni specifiche) le proteine sono dette native. In una proteina la stabilità infatti è definita come la tendenza a mantenere la conformazione nativa. Le interazioni chimiche che garantiscono questa stabilità sono: i ponti di solfuro (covalenti), e interazioni deboli come forze di Wan der walls legami a idrogeno, interazioni idrofobiche e ioniche. 2
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
1-Per quanto riguarda i ponti di solfuro non sono molti e si trovano principalmente nelle proteine secrete dall’ ambiente extracellulare (es. insulina) 2-Le interazioni idrofobiche invece sono predominanti. Proprio perché la proteina che si trova in acqua presenta delle molecole non polari le quali tenderanno a raggrupparsi all’ interno della proteina lontano dall’ acqua e ad associarsi l’un l’altra. 3-Anche i legami a idrogeno svolgono un ruolo fondamentale nel ripiegamento delle proteine in particolar modo nelle strutture secondarie. 4-Le interazioni ioniche invece limitano la flessibilità della struttura e le conferiscono una forma caratteristica. 5-Nell’ ambiente altamente compatto della proteina hanno un effetto molto significativo anche le interazioni di van der walls. Poiché quando gli atomi si avvicinano l’un l’altro, questo tipo di interazione dipolo-dipolo genera una forza attrattiva che agisce a livelle delle piccole distanze intermolecolari. Queste interazione prese singolarmente sono deboli, ma in una proteina il numero di queste interazioni può essere molto consistente. IL LEGAME PEPIDICO I legami peptidici hanno un ruolo importante nel determinare la conformazione di un polipeptide. Alla fine degli anni 30 due scienziati pauling e corey gettarono le basi per la comprensione della struttura delle proteine partendo proprio dalle proprietà del legame peptidico. Attraverso esperimenti i due scienziati osservarono l’esistenza di una parziale condivisione di una coppia di elettroni tra l’ossigeno carbonilico e l’azoto-ammidico. L’ ossigeno infatti ha una parziale carica negativa e l’azoto una parziale carica positiva, generando così un piccolo dipolo elettrico. Per questo i 6 atomi del gruppo peptidico giacciono sullo stesso piano. I legami C-N a causa del loro parziale carattere di doppio legame non possono ruotare liberamente, è invece permessa la rotazione ai legami N-C alfa e C alfa-C. Per questo lo scheletro di una catena polipeptidica può essere immaginato come una serie di piani rigidi in cui hanno in comune un punto di rotazione in corrispondenza di C alfa. La conformazione quindi del peptide ha 3 angoli diedrici chiamati (phi), (psi) e (omega).
RIPIEGAMENTI INVERSI Spesso nelle proteine alcuni residui amminoacidici si trovano in ripiegamenti o anse dove la catena polipeptidica inverte bruscamente la sua direzione. Sono di due tipi e sono costituiti da quattro residui amminoacidici, vengono stabilizzati da un legame a idrogeno tra i gruppi peptidici 1 e 4 LA STRUTTURA DELLE PROTEINE Nella struttura tridimensionale delle proteine si possono distinguere 4 livelli di complessità strutturale. La struttura primaria La sequenza degli amminoacidi in una catena polipeptidica rappresenta la struttura primaria di una proteina. La struttura secondaria Si riferisce ad un segmento polipeptidico della proteina e descrive l’organizzazione spaziale della catena principale senza tener conto della conformazione delle catene laterali. I legami che stabilizzano questo tipo di struttura sono i legami a idrogeno che si instaurano tra i gruppi NH e OH di gruppi peptidici diversi. Le principali strutture sono ad alfa elica e configurazione beta. 3
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
1-struttura alfa elica: è una struttura elicoidale, dove lo scheletro carbonioso si avvolge strettamente intorno ad un asse immaginario dove le catene laterali si trovano all’ esterno della struttura. Ogni giro dell’elica contiene mediamente 3,6 residui amminoacidici. L’ alfa elica destrorsa è la forma più comunemente presente. La struttura è stabilizzata da legami a idrogeno che si formano tra l’atomo di idrogeno legato all’azoto e l’ossigeno legato al carbonio di un altro gruppo peptidico distante 3 residui amminoacidici. La prolina a causa della sua struttura non può essere contenuta in una struttura ad alfa elica. La glicina a causa dell’assenza di catene laterali raramente si trova in questo tipo di struttura. 2-struttura beta: è una forma più estesa della catena polipeptidica definita dalla disposizione degli atomi dello scheletro secondo specifici angoli diedrici. Nella conformazione beta lo scheletro della catena si estende a zig zag, e la disposizione di diversi segmenti tutti nella conformazione beta l’uno accanto all’altro è detta foglietto beta. Anche questa struttura è stabilizzata da legami a idrogeno tra il gruppo carbossilico (CO) di un gruppo peptidico e l’idrogeno di un gruppo amminico (NH2) di un altro gruppo peptidico. I gruppi R di amminoacidi adiacenti sporgono dalla struttura a zig zag in direzioni opposte creando un’alternanza sopra-sotto. Inoltre le catene polipeptidiche adiacenti possono essere parallelo o antiparallele. Sono abbastanza simili ma orientate in direzioni opposte e la disposizione dei legami a idrogeno è diversa. La struttura terziaria Descrive la posizione di tutti gli atomi della proteina nello spazio, la struttura terziaria a differenza di quella secondaria tiene conto delle relazioni a lungo raggio nella sequenza amminoacidica. Gli amminoacidi che si trovano lontani in una sequenza polipeptidica che fanno parte di differenti strutture secondarie, possono infatti interagire tra loro nella forma completamente avvolta della proteina tipica della struttura terziaria. La struttura terziaria è stabilizzata da diversi tipi di interazioni che si instaurano tra le catene laterali dei residui amminoacidici, anche quelli già organizzati nella loro struttura secondaria. Queste interazioni sono: interazioni di van der valls, legami a idrogeno, interazioni dipolo-dipolo, interazioni ioniche, interazioni idrofobiche e ponti di solfuro. La struttura quaternaria Si verifica quando diverse catene polipeptidiche con strutture terziarie indipendenti (che possono essere uguali o diverse) si associano, e le diverse catene vengono definite subunità che solitamente si dispongono in maniera simmetrica. Viene stabilizzata dagli stessi legami responsabili delle strutture terziarie fatta eccezione per i ponti di solfuro
Considerando i livelli strutturali si possono definire due gruppi con cui classificare le proteine: proteine fibrose che hanno catene polipeptidiche disposte in fasci o in foglietti e proteine globulari che hanno catene polipeptidiche ripiegate che assumono forme sferiche. PROTEINE FIBROSE: le proteine fibrose sono costituite in gran parte da un unico tipo di struttura secondaria ripetuta. Sono insolubili in acqua a causa della elevata concentrazione di amminoacidi idrofobici. Esse hanno come funzione quella di determinare la resistenza e l’elasticità, la forma e la protezione esterna della cellula. Tra le proteine fibrose ricordiamo: 4
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
le alfa cheratine: sono i principali componenti degli stati epidermici e delle appendici ad esse derivate come unghie, capelli ecc. L’ alfa elica dell’alfa cheratina è destrorsa e si avvolgono due catene con stessa direzionalità l’una sull’ altra per formare un super avvolgimento (coiled coil). Le due eliche sono tenute insieme da interazioni idrofobiche e i loro gruppi R si inseriscono l’uno vicino all’ altro con un’alternanza perfetta. La struttura fibrosa viene ottenuta dalla formazione di un protofilamento in cui si instaurano interazioni deboli tra l’estremità carbossiterminale e ammino-terminale di ogni dimero avvolto. I protofilamenti dimezzano a loro volta formando protofibrille e l’ associazione di 4 protofiblille porta alla formazione di microfibrille. Inoltre la presenza di cisteine favorisce la presenza di ponti di solfuro. Le beta cheratine: è una proteina molto ricca di residui di piccole dimensioni (Gly, Ala, Ser) ed è priva di cisteina. Sono più rigide delle alfa cheratine per l'assenza della reversibilità dei Ponti disolfuro. È prevalentemente costituita da strutture beta. Le catene laterali di glicina e di alanina (o Serina) sono disposti in maniera alternata. I Gruppi laterali di una catena si adattano perfettamente a quelli della catena adiacente. Inoltre, tra le catene laterali dei residui più ingombranti, si instaurano interazioni idrofobiche. Il collageno: è una delle proteine più abbondanti nei mammiferi. E ‘costituita da fibre insolubili che hanno una elevata resistenza alla tensione. La sua composizione in amminoacidi è particolare: -un residuo su tre è glicina ,molto ricco in prolina(circa 15%) ,presenza di amminoacidi modificati La presenza abbondante nel collageno di prolina e glicina impedisce la formazione di strutture ad alfa-elica. Però questa proteina assume comunque una conformazione elicoidale dovuta alla configurazione dei residui di prolina. Tre catene polipeptidiche diverse sono super-avvolgono una sull'altra generando cosi una tripla elica. La tripla elica viene stabilizzata da legami ad idrogeno tra i gruppi peptidici di residui appartenenti ad eliche diverse. Le diverse triple eliche si uniscono tra loro mediante legami covalenti trasversali ma senza ponti disolfuro in quanto in questa proteina mancano residui di cisteina. Questi legami coinvolgono i residui di lisina, idrossilisina e istidina. PROTEINE GLOBULARI: le proteine globulari sono formate da strutture terziarie complicate e contengono più tipi di strutture secondarie all’ interno della catena polipeptidica. Fanno parte di questa classificazione gli enzimi e le proteine regolatrici le immunoglobuline ecc.. la struttura delle proteine globulari è molto complessa e i primi passi verso la comprensione di tale struttura furono fatti jhon kendrew attraverso esperimenti sulla mioglobina. I suoi esperimenti hanno rivelato la posizione precisa di ogni gruppo R, ciascuno infatti riempie tutto lo spazio esistente all’ interno della catena che non è stato occupato. Da ciò si possono trarre conclusioni rilevanti e cioè che la posizione dei gruppi R è dovuta principalmente da interazioni idrofobiche. Infatti la maggior parte dei gruppi R non polari solo localizzati all’ interno della molecola lontani dal contatto con l’ acqua mentre quelli polari sono localizzati sulla superficie esterna e sono tutti quindi idratati. In questo ambiente così compatto le interazioni deboli di wan der walls diventano più salde e si rinforzano a vicenda. E l’ intera struttura terziaria così compatta è anche stabilizzata da alcune interazioni ioniche e legami a idrogeno. Questo genere di struttura costituito da un’ avvolgimento polipeptidico caratteristico e ben riconoscibile formato da due o più elementi di struttura secondaria e da elementi di connessione tra essi è detto MOTIVO STRUTTURALE o RIPIEGAMENTO; un esempio più essere il barile beta. Inoltre i polipeptidi di grandi dimensioni (più di 200 residui) sono organizzati in unità strutturalmente indipendenti dal resto della proteina e di per sé stabili, chiamate domini. I domini proteici presentano la caratteristica struttura di piccole proteine globulari. E possono svolgere ognuno funzioni diverse. DENATURAZIONE DELLE PROTEINE Il continuo mantenimento di un insieme di proteine cellulari attive necessarie in determinate condizioni è chiamato proteostasi. Questo processo cellullare richiede un funzionamento coordinato delle vie di sintesi e di ripiegamento delle proteine , e in tutte le cellule questi intrecci di vie coinvolgono centinaia di enzimi e proteine specializzate. È per questo che la vita di una proteine comprende molto di più della fase di sintesi e di degradazione. Non appena le proteine vengono sintetizzate sui ribosomi devono assumere immediatamente la loro conformazione nativa per adempiere in modo specifico alle proprie funzioni. Le proteine però si sono evolute per svolgere le proprie funzioni nelle particolari condizioni ambientali della cellula, per questo in ambienti diversi possono andare 5
Riassunto Introduzione alla biochimica di Lehninger diviso per argomenti
incontro a variazioni strutturali che determinano la perdita di funzione. Questo fenomeno è detto DENATURAZIONE. La maggior parte delle proteine si denatura al calore , che produce conseguenze sulle interazioni deboli specialmente i legami a idrogeno. Se la temperatura aumenta lentamente in genera la conformazione della proteina rimane intatta , fino a che la sua struttura non cambia bruscamente. La rapidità del cambiamento di struttura induce a pensare che la perdita della struttura nativa sia un processo cooperativo: la perdita della struttura in una regione favorisce la destabilizzazione di altre. Le proteine si denaturano anche pressione alta , a PH estremi o attraverso detergenti ecc.… È stato dimostrato però attraverso alcuni esperimenti che la denaturazione di alcune proteine è reversibile. Certe proteine denaturate riescono a riacqu...
Similar Free PDFs

Riassunto biochimica di lehninger
- 54 Pages

I principi di biochimica di lehninger
- 114 Pages

Biochimica e principi di biochimica
- 17 Pages

3- Proteine - Riassunto Biochimica
- 36 Pages

Biochimica
- 6 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu