Farmacognosia CTF Pisa PDF

| Title | Farmacognosia CTF Pisa |
|---|---|
| Author | Talissa Peonia |
| Course | Farmacologia e farmacognosia |
| Institution | Università di Pisa |
| Pages | 29 |
| File Size | 949.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 39 |
| Total Views | 147 |
Summary
Download Farmacognosia CTF Pisa PDF
Description
FARMACOGNOSIA Lara Testai
• • •
Droga delle piante Struttura droghe Funzionalità farmaceutica
Esame orale: domande su parte generale e parte speciale (4/5 piante) Vedi portale omero per programma Testo: Farmacognosia … - Francesco Capasso
01/03/2017 FARMACOGNOSIA Φαρμάκων + γνώσις → conoscenza del rimedio «Ha il compito di descrivere e riconoscere dal punto di vista botanico, chimico e farmacologico delle sostanze naturali (piante, minerali, animali) impiegati nella preparazione dei medicamenti» Affonda le sue radici nella medicina greca ed araba, quando gli unici metodi erano appunto l’utilizzo delle sostanze di origine naturale. Dal XIX secolo avviene l’identificazione e purificazione delle sostanze terapeutiche, dividendo così la farmacologia dalla farmacognosia Farmaci di origine naturale: ❖ Morfina ❖ Chinina ❖ Salicina ❖ Acido clavulanico ❖ Taxolo ❖ Monacoline strutturalmente analoga della statina ⟹ attività ipocolesterolizzante …. → diversi aspetti in comune con la nutraceutica LA DROGA Nel linguaggio comune è indicata una sostanza d’abuso, che modifica lo stato psichico, oppure le spezie In farmacognosia: «La droga è un corpo vegetale, animale o minerale o una parte di essi che contiene, insieme agli altri componenti inattivi, una o più sostanze farmacologicamente attive, detti principi attivi» Pianta medicinale: contiene delle sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici, come tale, oppure la sintesi di comporti attivi Esempio: ❖ Cinchona succirubra estraggo composti per ottenere antimalarico ❖ Salix estrazione salicina per ottenere acido acetil-salicilico Pianta medicinale ≠ Pianta officinale pianta usata nelle officine (industria farmaceutica, cosmetica, liquoristica…) Droghe animali: ❖ Sanguisughe ❖ Insulina ❖ Melatonina ❖ Mosca di Spagna Droghe minerali: ❖ Bastoncini d’allume ❖ MgSO4 ❖ Na2S Droghe organizzate alla base della droga c’è la struttura cellulare (es. foglie, radici, corteccia, sanguisughe...) Droghe non organizzate no struttura cellulare (secrezioni, trasudati etc…)
1
RICONOSCIMENTO DI UNA DROGA 1. Se la droga è intera si ricorre all’analisi dei caratteri morfologici e organolettici (riconoscimento macroscopico) 2. Se la droga è triturata, polverata o non organizzata, si deve necessariamente ricorrere ad analisi a livello microscopico e colorimetriche 3. Se si ha a che fare con dei principi attivi si deve ricorrere a tecniche cromatografiche o spettrofotometriche e dosaggi biologici (per la quantificazione dei principi) Saggi d’identificazione delle droghe ❖ Autoptico: riconoscimento morfologico macroscopico della droga ed eventuale analisi organolettica Valutazione della forma, dimensioni, colore, caratteristiche superficiali della droga Analisi organolettica: Sapore (salicilati = acri, tannini= astringente, saponine = irritanti) e Odore Le più rappresentative in commercio sono le foglie ⟹ riconoscimento dei vari tipi di foglia ▪ Semplice → forma → apice → margine → nervatura → attacco → fillotassi (posizione) ▪ Composta Altrimenti ci sono le radici: ▪ A fittone: radice unica che affonda perpendicolarmente nel terreno (primaria + radichette secondarie) ▪ Fascicolata: primaria è atrofizzata e le radici secondarie molto sviluppate (esempio Valeriana officinalis) ▪ Tuberosa: tessuto parenchimatico molto sviluppato (harpagophitum procumbens = artiglio del diavolo) I fiori: ▪ Infiorescenza isolata o composita ▪ Pedicellata ▪ Sessile ▪ Aspetti anatomici → colorazione non sempre rilevante Frutti: ▪ Carnosi: sono distinguibili le 3 parti del pericarpo + mesocarpo polposo ▪ Secchi: unico strato di pericarpo • Deiscente a maturità si apre • Indeiscenti Seme: ▪ Descrizione guscio ▪ Descrizione mandorla ❖ Microscopico: consiste nella valutazione e studio delle caratteristiche cellulari della droga Necessaria quando il materiale non è intero Sfruttati solventi che idratano la droga e danno turgore, come acqua e glicerolo Mi devo soffermare su: ▪ Presenza di peli (protettori, ghiandolari…) e struttura (uni o pluricell.) ▪ Depositi caratteristici, inclusioni, presenza di stomi (struttura, organizzazione cellule di guardia e indice stomatico =
𝑠⋅100 𝐸+𝑠
con s=n^
stomi, E = n^ cellule epidermiche) ❖ Chimico-fisico: utilizzazione di agenti coloranti che mi permettono di capire quelle caratteristiche particolari che natura hanno. ▪ Pareti cellulari cellulosiche: tratto cellule con ZnCl2 iodato + H2SO4A = BLU ▪ CaCO3: si sciolgono con effervescenza in CH3COOH ▪ CaC2O4: si scioglie in HCl ▪ Amido: con aggiunta di I ⟹ colorazione bluastra 2
▪ ▪ ▪ ▪
Idrossiantrachinoni: reagiscono con NaOH/KOH assumendo colorazione rossastra Mucillagini: si usa nero di china oppure saggio specifico Tannini: coloro con goccia di FeCl3 → vaia da blu→ verde→ nero Olii essenziali: colorati di rosso con Sudan III
❖ Biologico 08/03/2017 ESAME CHIMICO FISICO - Saggio dell’indice di rigonfiamento adatto per droghe a mucillaggini, pectine o emicellulose. Si esegue pesando 1g di materiale vegetale polverizzato o tagliato o intero che viene inserito in un cilindro graduato e addizionato con acqua; quindi viene agitato ripetutamente per 1 ora e poi lasciato a riposo. Il tempo di riposo varia e lo dice la farmacopea. il grado di rigonfiamento corrisponde al volume in ml occupato dalla droga con mucillaggine. Ogni droga ha un suo indice di rigonfiamento specifico. - Saggio per determinazione dell’indice di schiumeggiamento adatto a droghe contenenti saponine. Si esegue pesando 1g di droga polverizzata, tagliata, e viene messa in 100 ml di acqua e portata ad ebollizione per 30 minuti. Questo tempo serve per favorire l’estrazione delle saponine dalla droga. Si filtra il filtrato e si posiziona in 3 provette dove sarà diluito in concentrazioni diverse. Nella prima 1/10, nella seconda 1/100, ecc. Poi si mette un tappo in cima alla provetta e agitata longitudinalmente. Si vedrà una schiuma detta“a nido d’ape“. Si prenderà in considerazione la diluizione che ha prodotto una schiuma alta 1cm. L’indice di schiumeggiamento viene calcolato dividendo 1000 per la diluizione che ha schiumato 1cm. L’indice di schiumeggiamento è direttamente proporzionale alle saponine presenti nella droga. I.SCH= 1000/a SAGGIO BIOLOGICO si fa per il riconoscimento di una droga che non è nota. Si esegue andando a valutare/dimostrare le proprietà farmacologiche di una pianta medicinale attraverso il “saggio bio-guidato”. Si esegue sulla base di esperimenti in vivo (animale a fini sperimentali), vitro (su colture cellulari o preparati) o ex vivo (su organi isolati ma che mantengono ancora la loro identità). Questo tipo di saggio ha la funzione di capire quale è la parte della pianta che può essere considerata droga, quindi la parte che ha maggior principio attivo e, quale è il principio attivo responsabile. FATTORI CHE INFLUENZANO IL CONENUTO IN PRINCIPI ATTIVI DI UNA PIANTA MEDICINALE - NATURALI sono riconducibili alla pianta e si dividono in: endogeni-genetici (dipendenti dalla pianta fornitrice). Sono: 1. Il primo fattore è il tempo balsamico, definito come il momento dell’arco della vita della pianta medicinale in cui la droga ha il massimo numero di principi attivi a livello della droga. Eccezioni: esempio della digitalis purpurea è una pianta biennale che ha il suo tempo balsamico al primo anno perché le sue foglie hanno il numero massimo di glicosidi attivi. Tuttavia nel primo anno di vita la pianta è poco sviluppata e quindi preferisce fare la raccolta al secondo anno, in modo da avere più materiale vegetale su cui lavorare. Quindi per una pianta annuale il tempo balsamico è a completo sviluppo, per le piante biennali nel secondo anno di et e per le piante perenni aumenta con l’età. La raccolta della droga va fatta in una stagione specifica per la droga.
•
•
Calendario di Raccolta Fusto si raccoglie in inverno, prima della gemmazione. Si raccoglie i fusti dei rami. Corteccia in primavera (perché si stacca facilmente dal resto del fusto). Questa si raccoglie facendo dei riquadri a livello della corteccia in modo tale che la pianta soffra il meno possibile. Radici/rizoma/bulbi (parti ipogee) in autunno-inverno. Sono in fase di quiescenza. Gemme si raccolgono alla fine dell’inverno/inizio primavera 3
• •
•
Foglie si raccolgono 2-3 ore dopo il levar del sole, prima della fioritura. Ci sono eccezioni: per esempio le foglie della belladonna si raccolgono 3 volte, anche a luglio e ad agosto. Fiori e Infiorescenze si raccolgono al mattino, a completa fioritura. Eccezione: camomilla o arnica montana vengono raccolte quado sono ancora chiuse. I fiori che contengono metaboliti volatili si raccolgono al mattino per non farli evaporare. Frutti: quelli 1. carnosi si raccolgono a completa maturità, quelli 2. secchi indeiscenti prima ella completa maturità, quelli 3. deiscenti a maturità completa prima dell’apertura. Semi: si raccolgono 1. a maturazione dei frutti secchi, 2. prima della maturità dei frutti carnosi
2. Selezione della specie si può parlare di: -
-
selezione massale si esegue selezionando da una coltivazione ampia solo quei semi delle piante che hanno i requisiti ottimali e cioè alto contenuto di principio attivo, ma anche maggiore resistenza alle condizioni ambientali (acqua, patogeni). Questo porta nel tempo a colture di élite, in cui tutti gli individui di quella coltivazione hanno le stesse caratteristiche. Una selezione di questo tipo ha portato al raddoppiamento del numero dei principi attivi del “papaver somniferum” che dal 10% al titolo alcaloide, siamo passati al 18-20%. La selezione di particolari semi ha portato ad un incremento della resa del numero di metaboliti attivi. selezione genealogica si fa in modo analogo alla massale e consiste nel selezionare gli individui con il materiale cromosomico di nostro interesse. Si apportano mutazioni al materiale cromosomico e si selezionano individui con quelle determinate caratteristiche cromosomiche per propagare colture con identiche caratteristiche desiderate.
3. Ibridazione: si esegue incrociando piante dello stesso genere e di specie diverse, in modo da ottenere delle entità ibride con caratteristiche desiderate (alto contenuto di principio attivo, concentrazione di patogeni, ecc.) Un esempio è la menta piperita o lavandula officinalis. Queste entità ibride per mantenere le loro condizioni cromosomiche intatte devono essere ibridate attraverso il taglio (talea) e non attraverso l’impollinazione. 4. Poliploidia consiste nell’aumentare il numero di cromosomi o aumentarne la grandezza. Si fa esponendo la droga a colchicina a caldo. Questo porta alla produzione di un corredo genetico che può essere raddoppiato, quadruplicato, ecc. si ottiene piante più grandi con una droga molto più sviluppata e quindi anche una resa molto più elevata di principi attivi. Lo svantaggio è che si arriva ad ottenere piante più delicate. Esogeni-ecologici (dipendenti dall’ambiente) Questi sono: 1. Esposizione alla luce. Piante come la belladonna, lo stramonio, ecc., che contengono alcaloidi del nucleo tropanico 2. Nutrizione tramite fotosintesi. La latitudine è importante per la composizione in lipidi. L’altitudine influenza la composizione in PA 3. Diminuzione di esposizione luce Aumento del titolo di principio attivo (es achillea) basse t minori oli essenziali altitudine in montagna aconito meno velenoso, la valeriana più ricca di PA Alcune piante sono velenose in pianura e non lo sono in montagna. 4. Esposizione luce Aumento del contenuto di glicosidi digitalici/alcaloidi isochinolinici/alcaloidi tropanici 5. ALTE T favorito accumulo alcaloidi tropanici - belladonna. La produzione di acidi grassi tende a spostarsi da acidi grassi monoinsaturi a produzione di acidi grassi saturi. Le piante che crescono bene nei climi tropicali, infatti, producono acidi grassi saturi (olio di palma, ecc). Le piante che crescono bene nei climi mediterranei producono acidi grassi insaturi. Ad esempio, la pianta dell’olivo. 4
Le piante che crescono nei climi freddi producono acidi grassi insaturi. latitudine da climi freddi a caldi aumenta il contenuto di acidi grassi saturi ESEMPI Aconito coltivato in Italia è velenoso, nei paesi del nord è innocuo. Cicuta velenosa nei paesi caldi ma perde tossicità in paesi freddi Timo e menta ricchi di PA in pianura… 1. Composizione del terreno le piante ad essenza richiedono terreni sabbiosi, aridi (come salvia) se coltivate nel terreno umido perdono l’aroma - La valeriana e l’altea sono poco ricche in pa quando crescono in terreni umido-paludosi - La camomilla predilige terreni acidi. Il papavero non li tollera. - Terreni umidi le ombrellifereae perdono aroma, le solanaceae il titolo in alcaloidi. - L’azoto ha un effetto positivo per la valeriana e la genziana. È negativo per la camomilla. - La digitale è ricca di principi quando coltivata in terreni ricchi di manganese e ne è povera in terreni calcarei. 2. Allopatia condizionamento nella produzione di principi attivi da parte di un’altra pianta che cresce vicino ad essa. Inizialmente era considerato un termine negativo, ma può essere anche considerato come positivo, infatti: le ombrellifereae producono furcramine che hanno una funzione difensiva. Gli insetti arrotolavano la foglia così da poter continuare a vivere sulla pianta mangiando la foglia della parte inferiore. L’arnica montana non sopravvive in monocoltura, lo stramonio predilige la coltura vicino al lupino e la belladonna cresce bene vicino all’assenzio. -
ARTIFICIALI sono legati alla raccolta, preparazione e conservazione della droga.
15/03/2017 Fattori artificiali che sono correlati con quella procedura definita preparazione di una droga: 1. Raccolta: personale specializzato, lavata, rimozione di agenti contaminanti a. Foglie: con picciolo (tolto successivamente), in buone condizioni b. Fiore: con peduncolo, tolto successivamente 2. Essicazione: fatta in casi in cui la droga non serva fresca (tinture madri, olii essenziali) → riduzione della maggior parte dell’acqua presente nella droga ❖ Può dare reazioni che portano ad alterazioni o demolizione dei metaboliti secondari ❖ Porta a deterioramento organolettico della droga 3. Stabilizzazione della droga 4. Sterilizzazione conservazione Tecniche di essicazione → inibizione enzimatica reversibile (per alcuni tipi di droghe si può pensare anche ad una procedura di tipo irreversibile) • Essicazione su graticci: tecnica economica, ma necessita di lunghi tempi (esposizione al calore solare) Tecnica utile in luoghi con climi temperati e poco umidi Droghe come foglie e fiori → T =20-40 °C ⟹ buona tecnica Droghe come cortecce o parti ipogee → T= 60-70 C ⟹ X Importante che il processo non sia né troppo veloce, né troppo lento → Il rischio di questa tecnica è che sia troppo lento + bisogna periodicamente spostare la droga in quanto deve essere tutta esposta al calore • Essiccazione in serre schermate + auto riscaldamento (≅ ≅): pannello solare cattura energia → riscalda aria → circolazione calore al suo interno (la serra fa lo stesso, ma in più grande) Possono raggiungere massimo 30-40 C. Il vantaggio del piccolo essiccatoio è che a differenza della serra non subisce escursione di umidità fra giorno e notte. Ovviamente la cosa si è evoluta in dei 5
• •
veri e propri carrelli che vengono trasportati dentro una grande stufa che si può regolare → più costosa, ma la più pratica Essiccatori dinamici: grandi rulli trasportano la droga dentro un ambiente uniformemente riscaldato alla temperatura desiderata Essicazione per sublimazione: unica alternativa quando si parla di principi attivi termolabili. Utilizzata di prassi da alcune aziende in quanto è la più efficiente. Si ottiene una droga molto porosa che va conservata in condizioni tali da non esporla all’umidità. Consiste nel abbassare la pressione al punto da trasformare l’acqua allo stato gassoso dallo stato solido(liofilizzazione)
Tecniche d’inibizione irreversibile → STABILIZZAZIONE È un processo che si opera sulla droga ancora fresca ed esistono diverse tecniche: ❖ Bourquelot : si mette a contatto la droga fresca con acqua o alcool bollenti ❖ Perrot- Goris: esporre la droga ad un macchinario specifico, l’autoclave a vapori di etanolo. Tecniche che possono portare ad una parziale estrazione dei principi attivi ❖ Goris-Arnould: sfrutta sempre autoclave MA a vapori acquosi → minore probabilità d’estrazione in quanto meno polare di etanolo ❖ Esposizione a calore secco: 80-100 C ❖ Stabilizzazione a raggi UV: si può utilizzare solo con droghe non termolabili, senza succhi o lattici ad oggi queste tecniche non sono molto usate, in quanto si usano droghe fresche!!! (vedi problemi già’ affrontati) ⟹ necessaria ulteriore essicazione ⟹allungamento dei tempi STERILIZZAZIONE: spesso si preferisce non farla in quanto sono: ❖ Esposizione droga a ossido di etilene ❖ Esposizione a raggi γ → la droga può parzialmente assorbire questi due divenendo invendibile ⟹ si ricorre alla sterilizzazione solo quando ci si rende conto che la carica microbica è troppo alta (controllo qualità) CONSERVAZIONE: ❖ Luogo fresco e asciutto: il sottovuoto sarebbe il top, altrimenti contenitori a chiusura ermetica ambrati o di ceramica (schermati) e con all’interno agenti idroscopici: ▪ Calce essudata ▪ Gel di silice ❖ Conservanti: anidride solforosa o solfiti ❖ Antiossidanti: evitare la perdita di fenoli TUTTAVIA un deterioramento dato dal tempo di conservazione ci sarà sicuro ⟹ consigliato cambiare e rinnovare la droga almeno ogni anno CONTROLLO QUALITA’: prima d’immettere una droga in commercio è opportuno assicurarsi della sua identità, qualità e quantità dei principi attivi in essa presenti, allo scopo anche di scongiurare eventuali sofisticazioni o adulterazioni della droga. Fondamentale anche dal punto di vista legislativo. Tutti questi accorgimenti hanno anche un interesse terapeutico ovviamente In cosa consiste? [immagine scheda] 1. Controllo morfologico: è l’esame autoptico della droga (anche al microscopio) 2. Esami al microscopio 3. Controllo chimico-analitico: consiste nell’eseguire esami chimico fisici semplici e anche specifici: a. Saggio dell’umidità: consiste nel prendere una quantità esattamene pesata di droga posta in una capsula tarata in stufa, per 1h a 100 C capsula presa e pesata ripetuta finche’ non si hanno due pesate successive uguali Posso risalire alla percentuale iniziale di umidità b. Saggio delle ceneri: purezza prodotto e presenza di sofisticazioni. Quantità esattamente pesata di droga → capsula tarata → inserimento in muffola (temperatura di 800-1000 C) →dopo 1h si pesano le ceneri → ripetere fino ad avere due pesate successive delle ceneri identiche. Indica la presenza di sofisticazioni 6
c. Valutazione di agenti contaminanti: pesticidi, metalli pesanti presenti entro certi limiti stabiliti per legge 4. Controllo biologico: a. Valutazione della carica batterica b. Attività biologica 22/03/2017 SPECIAL SECTION: PIANTE MEDICINALI AD AZIONE SIMPATICOMIMETICA [Vedi anatomia e fisiologia per sistema simpatico, parasimpatico ed enterico (sempre parasimpatico)] Fibre pre-gangliari → rilascio acetil-colina Post gangliari: sono lunghe e numerose → rilascio noradrenalina (eccezione midollare del surrene: adrenalina per il 75%, noradrenalina per 25% → NB: le libera come ORMONI) ∃ anche la dopamina → ma usata soprattutto a livello … Recettori adrenergici [vedi fondamenti] α 1 → livello vascolare = vasocostrizione β 1 → cuore aggiungi a fondamenti β 2 → bronchiale/polmonare β 3 → tessuto adiposo = gestione glicolisi Livello post gangliare Noradrenalina: è una catecolammina → contiene catecolo + è un’ammina primaria. La sua sintesi parte dalla tirosina → in cellule incontra tirosina idrossilasi → convertita a DOPA (diidrossifenilalanina) → DOPA-decarbossilasi converte in dopamina (ritenzione in vescicole, se no in citosol verrebbe rapidamente degradata) → dopamina-idrossilasi inserisce -OH in posizione β rispetto a gruppo amminico → noradrenalina (in corticale va’ avanti fino ad adrenalina) Uscita da vescicole: o COMT metilano la noradrenalina ⟹ metabolita i...
Similar Free PDFs

Farmacognosia CTF Pisa
- 29 Pages

Farmacognosia - Apuntes
- 126 Pages
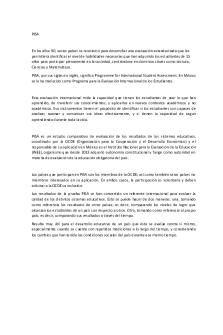
PISA - ¿Qué es PISA?
- 1 Pages

CTF Tutorials
- 10 Pages

Legislazione CTF
- 98 Pages

Tabla Farmacognosia
- 9 Pages

Taninos - Farmacognosia
- 7 Pages

Leonardo de Pisa
- 3 Pages

Examen PISA 5TO
- 109 Pages

Modulo 1 CTF Informatica Generale
- 144 Pages

Comparacion PISA Y Estandares
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




