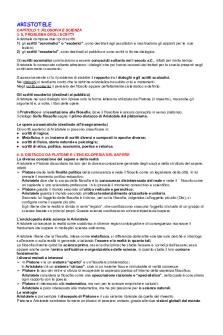Attesa di Dio - Riassunto dell\'opera della mistica francese PDF

| Title | Attesa di Dio - Riassunto dell\'opera della mistica francese |
|---|---|
| Course | Filosofia morale |
| Institution | Università degli Studi di Firenze |
| Pages | 9 |
| File Size | 162.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 39 |
| Total Views | 147 |
Summary
Riassunto dell'opera della mistica francese...
Description
Simone Weil – Attesa di Dio Introduzione. Attesa di Dio contiene innanzitutto sei lettere, dei primi mesi del 1942, indirizzate a padre Perrin, il religioso di Marsiglia con cui Simone fu in amichevole contatto, in cui spiega le ragioni che le impediscono di entrare nella Chiesa cattolica. Vi sono poi sei saggi, più o meno coevi, essenzialmente dedicati al tema dell’amore di Dio, tra i quali almeno due, Forme dell’amore implicito di Dio e L’amore di Dio e la sventura, sono tra le cose più belle e significative della Weil. Non a torto perciò Cristina Campo, nella Introduzione (firmata con lo pseudonimo di Benedetto P. d’Angelo) a una precedente edizione, definiva questo libro “un libro immenso. Un grande classico cristiano, o, più esattamente forse, un grande classico precristiano.” La dimensione dell’attesa (nel raccoglimento, nella vigilanza, nell’ attenzione) costituisce uno degli elementi essenziali del pensiero weiliano. L’ attesa/attenzione presuppone infatti che si sia lasciata ogni altra occupazione e ogni altro fine e si sia tutti rivolti a ciò che deve o può (av)venire. Presuppone dunque un completo distacco, una completa libertà da tutto ciò che non riguardi quella stessa attesa/attenzione, lasciando “il proprio pensiero disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto”. L’attenzione è condizione necessaria per la ricerca, perché quello che si richiede è solo “uno sguardo attento, in cui l’anima si svuota di contenuto proprio per accogliere in sé” quella realtà che solo così “essa vede nel suo aspetto vero.” L’attesa/attenzione di cui Weil parla non serve i nostri interessi e presume dunque un’onestà intellettuale, perciò anche la fine di ogni nostro pregiudizio, la libertà da ogni opinione, e, nello specifico caso del divino, la fine di ogni “immaginazione riempitrice di vuoti.” Proprio il vuoto, nel suo senso di purezza e disponibilità ad accogliere la luce, è uno dei termini-chiave dell’esperienza religiosa di Weil, che perciò giustamente Gaeta, nel saggio che chiude il volume in oggetto, iscrive in un “cristianesimo mistico,” ovvero in
quella “autentica ispirazione cristiana conservata, secondo Simone Weil, soltanto dalla mistica.” Weil giunge al cristianesimo per una libera ricerca intellettuale e dunque non gravata dalla precomprensione indotta dalle Chiese. Per lei è chiaro che l’insegnamento essenziale di Gesù è quello dell’abrenuntiare se ipsum, rinunciare a se stessi, odiare la propria anima, perché solo così essa si rende capace di accogliere Dio. Dunque la conversione non consiste nell’assumere una nuova credenza, ma in una “radicale trasformazione dell’anima” che passi dal nature egoismo umano all’amore soprannaturale di Dio – dove Dio non è l’oggetto amato, ma il soggetto che ama. Considerata la distanza infinita che separa la necessità dal Bene, che è platonicamente sempre al di là dell’essere, all’uomo non è concesso infatti di “conoscere Dio” e neppure di “amare Dio”: ciò che può e deve fare è soltanto rifiutare di assumere idoli al posto di Dio e di amare cose che Dio non sono. Pati divina, dunque, souffrir Dieu, ossia lasciare che Dio agisca in noi. Questo il nucleo mistico del pensiero religioso della Weil, esemplificato da due elementi: lo straordinario rilievo che ha la sventura, il malheur (così scrive nei Quaderni: “parola mirabile; senza equivalenti in altre lingue. Non se n’è tratto profitto”); la sostanziale indipendenza, anzi, distacco, da tutte le Chiese. La sventura è infatti una cosa a sé, specifica, irriducibile, tutt’altro dalla semplice sofferenza: è qualcosa che “si impadronisce dell’anima e le imprime in profondità il suo marchio, quello della schiavitù.” Si tratta della schiavitù intrinseca dell’uomo, la pesanteur che rende l’uomo una cosa, al pari delle foglie o dei sassi. La sventura “sradica dalla vita, equivale, più o meno, alla morte,” per cui l’anima colpita dalla sventura è come la farfalla appuntata viva su un album, che si dibatte senza poter far nulla. Nello stesso tempo, però, la sventura rivela all’uomo con indiscutibile chiarezza la sua soggezione alla necessità,
smontando le sue illusorie pretese di libertà, intorno alle quali si erge la tronfia costruzione dell’io, ovvero l’ostacolo essenziale alla discesa di Dio nell’anima. D’altra parte la sventura non impedisce all’anima di mantenere il suo amore, ovvero il suo orientamento verso la verità, verso il Bene (“bisogna soltanto sapere che l’amore non è uno stato d’animo, ma un orientamento”), per cui l’anima che resta orientata verso Dio mentre è trafitta dal chiodo della sventura si trova ormai affrancata dalla pesanteur “alla presenza stessa di Dio.” Sotto questo profilo “la sventura è una meraviglia della tecnica divina.” L’esperienza della Weil, per quanto vicina al cristianesimo e in particolare alla figura del Cristo, è inconciliabile con l’appartenenza ecclesiastica. Proprio le lettere a padre Perrin presenti in questo libro mostrano che ella non accetta, per onestà, le pretese della Chiesa di essere unica depositaria della verità e unica mediatrice di salvezza. Infatti la luce di Dio risplende in ogni tempo e in ogni luogo e non ha bisogno di mediazioni: le basta trovare un’anima vuota e in attesa di riceverla. Al cattolicesimo Simone rimprovera poi di aver fatto propria quell’“idolatria sociale” che era per un verso dei Romani e per altro degli Ebrei, mettendo in secondo piano il suo autentico spirito di verità, che gli proviene invece dalla “fonte greca” e che è apparso soltanto nella civiltà catara. “Viviamo in un’epoca che non ha precedenti e nell’attuale situazione l’universalità, che una volta poteva essere implicita, deve essere pienamente esplicita.”
Lettere. Esitazioni davanti al battesimo. Nelle prime due lettere indirizzate a padre Perrin, Simone Weil espone le sue perplessità circa il possibile ingresso formale nella religione cristiana attraverso il battesimo (ella era stata cresciuta in modo laico). La prima esitazione si fonda principalmente sul fatto che Weil non si sente pronta a ricevere i sacramenti, in quanto essi – oltre a possedere un significato sociale, come evidenziato dall’antropologia di Durkheim – sono spirituali in un senso accessibile soltanto
ad alcuni privilegiati fedeli, che, per obbedienza, diventano “strumento” della volontà di Dio che li accoglie nel suo amore. La seconda lettera è di carattere prettamente politico: alcuni santi hanno sostenuto le Crociate o l’Inquisizione e perché dunque Weil – che si ritiene moralmente inferiore a loro – dovrebbe aggregarsi a un movimento sociale collettivo che ha sbagliato, in preda alla sua foga quasitotalitaria, così tante volte in passato? Weil è attenta a sottolineare che le sue rimostranze non sono causate da un carattere individualistico, bensì dalla genuina preoccupazione che il sociale sia “dominio del demonio” (come insegna il Vangelo) e soprattutto dall’eventualità che, una volta compiuto un battesimo “forzato,” uno possa essere travolto dall’orrore di non aver agito per obbedienza.
Autobiografia spirituale. In questa lettera, spedita a padre Perrin poco prima di partire per gli Stati Uniti nel 1942, Simone Weil ricostruisce la sua infanzia e la sua adolescenza ricercando segni di quel cristianesimo che si sarebbe rivelato soltanto più tardi nella sua vita. Weil racconta come, a quattordici anni, sia caduta in depressione a causa di un complesso di inferiorità intellettiva verso il fratello André (poi celebre matematico), per poi trovare la speranza di accedere a “quel regno trascendente dove entrano solamente gli uomini di autentico valore” attraverso il perseguimento costante e paziente della verità. Allora il concetto non era connesso con la “bellezza, la virtù e ogni sorta di bene,” in quanto Simone non aveva ancora letto il Vangelo. La filosofa fa poi un resoconto delle varie esperienze spirituali-mistiche che l’hanno cristianamente formata prima dei sacramenti: l’esperienza di lavoro in fabbrica, che le mostra la sofferenza umana in tutta la sua miserabile medietà; l’ascolto dei canti funebri in un piccolo paese di pescatori portoghesi;
un viaggio di due giorni ad Assisi nel 1937, in cui si sente “spinta” a inginocchiarsi pregando nella cappella di Santa Maria degli Angeli; un viaggio di dieci giorni a Solesmes nel 1938, in cui scopre i Poeti metafisici tramite un giovane cattolico inglese. È proprio nelle opere dei Poeti metafisici che Simone Weil troverà un’implicita formulazione della sua relazione mistica con Dio, in particolar modo nella poesia Amore di George Herbert (1593-1633), dove la spiritualizzazione metaforica di questo sentimento (i.e., forse Dio?) accoglie l’anima del poeta, che non si sente però all’altezza; si instaura dunque un gioco dialettico in cui il poeta alla fine si concede gioiosamente al contatto con Amore. Weil riflette poi sulle ragioni per cui non vuole, in definitiva, diventare un membro “sociale” della Chiesa: quella centrale è che l’anathema sit è stato troppo spesso impiegato per negare l’intrinseca e innegabile universalità del messaggio cristiano. In secondo luogo, la Chiesa (in quanto istituzione) è protettrice di un dogma (una serie di precetti, etc.) che interessa tre facoltà peculiarmente individuali: l’amore, la fede, l’intelligenza. Un’altra ragione per cui Weil non vuole entrare nella Chiesa è che Dio ha affermato che “Dovunque due o tre di voi saranno uniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro” – implicando una natura fondamentalmente confessionale del sentimento religioso: Cristo è, per dirla con Eliot, il “terzo che ci cammina sempre a fianco.” Dio si dà nella “parola segreta.”
Ultimi pensieri.
L’essere umano è testimone dell’amore di Dio essenzialmente in due forme, cioè quando prova gioia o quando è colto dalla sventura: “ciò che importa è solo questo contatto, non il modo in cui avviene.” Weil dice che, anche se si fosse comportata perfettamente nel mondo
terreno e successive fosse finita all’inferno, sarebbe comunque grata nei confronti di Dio per averla comunque creata in quanto “oggetto mal riuscito.” L’uomo è dominato da una “necessità meccanica” che lo spinge a riconoscere la mutilazione dell’animalità dell’Altro e a “beccarlo come una gallina fa coi suoi simili”: sottrarsi da questa dimensione dell’esser-uomo significa accettare la bontà sovrannaturale di Dio. Riflettendo ancora sulla sua evoluzione di pensiero riguardo a Dio, Weil nota di essere stata educata in modo agnostico e che è contenta di ciò; ciò nonostante, ella è sempre stata consapevole del fatto che i suoi peccati non erano causati dall’ignoranza, bensì da una scelta consapevole di perseguire il Male (qui Weil si avvicina all’intellettualismo etico socratico: la “verità greca” del Vangelo). In definitiva, Simone rimane fuori dal cristianesimo perché ama anche ciò che sta al di fuori di esso – ad esempio, crede che la “virtù stoica sia tutt’uno con quella cristiana” e avanza la possibilità che un contadino spagnolo che non ha ricevuto i sacramenti sia “quasi un santo.” La Weil ha decisamente una visione non ortodossa della composizione moralesovrannaturale di un individuo ed è per questo che si dichiara “addolorata” dal fatto che padre Perrin, in una conversazione privata, abbia una volta equivalso non ortodosso a falso. Per Weil, l’ortodossia è l’accettazione acritica del dato, un “surrogato della verità.” A Perrin, la filosofa imputa la colpa di non essere capace di abbandonare la Chiesa in quanto “patria terrena” (e non come contatto con Dio), collettività che opprime l’intelligenza e che non può imporre l’obbligo di amare. I cristiani devono avere come patria l’intero “quaggiù,” imitando la “distribuzione indiscriminata” della luce nello spazio – il Vangelo ci ricorda che l’amore cristiano è anonimo e universale, come nel caso del buon Samaritano. Per concludere la lettera, la Weil chiede a Perrin di conservare i suoi pensieri, in quanto valgono molto più di chi li ha pensati.
Scritti.
Riflessione sull’utilità degli studi scolastici al fine dell’amore di Dio. Simone Weil avanza una concezione assolutamente personale dell’utilità dello studio (ad es., liceale). Per la filosofa francese, l’obiettivo primario dello studio non è tanto il padroneggiare la disciplina in esame (che sia essa la matematica, il greco o le belle lettere), bensì creare quella specifica disposizione spirituale all’attenzione che caratterizza una genuina conversazione o preghiera con Dio. Certo: lo sforzo darà i suoi frutti anche in ambito accademico (e spesso “per vie misteriose,” come quando comprendiamo meglio Racine in virtù di un antico tentativo di risolvere una disequazione). Weil rimarca l’importanza di credere che lo studio migliorerà il livello complessivo di attenzione – se uno non ci crede, significa che il suo spirito non sarà autenticamente disposto ad aprirsi alla verità e perciò alla comprensione. Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attenzione, lo sforzo – che per un apprendista manuale è fondamentale – diviene tutto sommato irrilevante in forza del ruolo del desiderio. Weil dice che sono meglio venti minuti di studio intensi e privi di fatica piuttosto che tre ore debilitanti ma non arricchenti: occorre desiderare la Verità senza ricercarla. Lo studio motivato da questo desiderio fa sviluppare la facoltà dell’attenzione, necessaria per farsi oggetto della volontà divina, etc. Weil afferma che l’intelletto umano deve essere come quell’esploratore che, dal cocuzzolo di una montagna, osservi le vallate e pianure sottostanti e, senza gettarsi su di esse, le tiene ferme. Alla fine, “ogni esercizio scolastico assomiglia a un sacramento.” Ma perché l’attenzione è così importante per Dio e per l’uomo? Il servo ama il suo padrone e dunque lo obbedisce, ma fino a quando egli non è attento ai suoi immediati bisogni, allora il padrone non lo farà sedere alla sua tavola. Amare Dio è insufficiente: dobbiamo metterci in attesa e in ascolto della sua parola, così come dobbiamo diventare sensibili alla sventura che marchia ogni uomo nella sua individualità
(perciò: non soffrire “sventurati”).
per
la
L’amore di Dio e la sventura.
categoria
astratta
degli
Quando Weil parla di “sventura” (malheur), non intende la generica sofferenza fisica-psicologica che si può manifestare attraverso un mal di denti o un’afflizione spirituale passeggera. La sventura marchia il suo possessore come la schiavitù; e, come uno schiavo nell’antica Roma, lo sventurato perde figurativamente metà della sua anima. Weil sostiene che la sofferenza non sia così misteriosa: ci sono state pulizie etniche sistematiche, campi di concentramento e guerre; ma sappiamo che l’uomo a volte è malvagio. Un interrogativo molto più grande è: “Perché Dio sembra abbandonare gli sventurati?” La sventura ha costretto Cristo a supplicare di essere risparmiato e un uomo perfetto come Giobbe a imprecare contro Dio. “Il libro di Giobbe,” ci dice Weil, “è dall’inizio alla fine una pura meraviglia di verità e di autenticità. Se si parla di sventura, tutto ciò che si discosta da quell’esempio è, più o meno, macchiato di menzogna.” Weil svolge una breve ma acuta analisi fenomenologica della sventura. Allo sventurato pare impossibile amare perché Dio ha svuotato di senso il cosmo; per di più, come detto supra, lo sventurato si sente “marchiato” dalla stessa onta di un assassino e il suo cuore è completamente indurito. A eccezione dei santi, siamo tutti in una qualche misura disgustati dallo sventurato – esattamente come la gallina ferita viene rimbeccata dalle compagne. A questo punto, lo sventurato interiorizza questo odio e (nel caso in cui non intervenga l’amore soprannaturale) la sua concezione del mondo viene filtrata da esso, rendendolo inerte ed eventualmente avvelenato contro chi voglia aiutarlo. Lo sventurato è a una distanza massimale da Dio: si trova ai piedi della Croce. La sventura è costitutivamente casuale: chi è perseguitato per ragioni che (ovviamente non condivide ma) comprende non è sventurato, bensì sofferente. Essa ci spinge alla stessa domanda che si è
posto Gesù nel giardino dei Getsemani: “Dio, Dio, perché mi hai abbandonato?” Per Weil, gioia e dolore sono due modalità independenti e complementari attraverso cui all’uomo viene svelata l’obbedienza cieca e meccanica del creato a Dio – la gioia è l’apprensione intellettiva di questo rapporto, mentre il dolore ne è quella fisica. Dobbiamo fare uso di entrambe le esperienze se vogliamo testimoniare in toto l’obbedienza e la docilità della natura. Lo sventurato, in questo senso, è colui cui capiti una sventura e che non accetti questo elementare principio di obbedienza – se lo facesse, ricondurrebbe la sua sventura a una forma motivata di sofferenza fisico-psicologica e ritornerebbe in quello stato di attesa/attenzione per Dio e la sua infinita bontà di cui parla Weil. Ecco svelato cosa significhi “rinnegare se stessi”: rinunciare ai nostri sentimenti per lasciare spazio all’amore intratrinitario di Dio per Dio. Sotto questa luce, Weil rivede la sventura come una possibilità di cui dispone l’uomo per concentrare in se stesso – sul suo corpo e nella sua degradazione sociale e morale – l’infinita distanza percorsa dal Figlio che, allontanandosi da un Padre piangente, discende e si sacrifica per redimerci dai peccati che abbiamo commesso. Attraverso la sventura, l’uomo può “ripetere” la Passione della Croce....
Similar Free PDFs

Morte di Dio - Nietzsche
- 1 Pages

Riassunto letteratura francese
- 29 Pages

Riassunto letteratura francese 600
- 14 Pages

Riassunto Letteratura Francese II
- 24 Pages

Francese III - riassunto 600
- 24 Pages

Esercizi di grammatica francese.
- 2 Pages

Esercizi di grammatica francese
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu