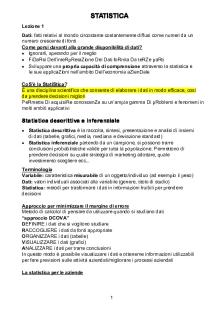Riassunto completo per preparare l’esame scritto del prof Furini PDF

| Title | Riassunto completo per preparare l’esame scritto del prof Furini |
|---|---|
| Author | Manuela Riccio |
| Course | Laboratorio di comunicazione multimediale |
| Institution | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| Pages | 59 |
| File Size | 8.2 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 69 |
| Total Views | 153 |
Summary
Riassunto completo in cui ho accorpato gli appunti (parola per parola, riguardati e sistemati) più tutti gli argomenti del libro del prof Furini “comunicazioni multimediali”. Il documento è completo, non è necessario studiare ne sul manuale ne prendere appunti. Consiglio vivamente comunque di seguir...
Description
Lezione 3 4
Capitolo 1 LO SCENARIO DIGITALE Il telegiornale che abbiamo visto stamattina, la musica che abbiamo ascoltato mentre andavamo in stazione, le telefonate che abbiamo ricevuto ee sono attività molto diverse tra loro che però hanno in comune una cosa: sono composte da una lunga sequenza di numeri. Questo è lo scenario digitale in cui tutti i contenuti sono rappresentati mediante sequenze di bit. In questo capitolo analizzeremo questo scenario digitale soffermandoci in particolare su: x x x
la comunicazione multimediale (1); la rappresentazione delle informazioni (2); le reti di comunicazione (3).
(1) La comunicazione multimediale x
La comunicazione è sempre più multimediale: se analizziamo i contenuti di un qualsiasi sito web troviamo presenza di video ma anche di testo e di immagini; se pensiamo poi alla comunicazione con altre persone ritroviamo di nuovo presenza di video, di testo, di immagini (fotografie ma anche ce)
x
La comunicazione multimediale è sempre più utilizzata: le industrie utilizzano contenuti audio/video per pubblicizzare prodotti, il settore turistico fa largo uso di immagini e video per pubblicizzare i propri territori, le amministrazioni usano la comunicazione multimediale e anche gli istituti didattici (DAD, nuove forme di insegnamento).
Leeea ccaa quindi sta cambiando. Quali sono stati i motivi che hanno portato a questa situazione? x
I progressi scientifico-tecnologici: gli strumenti software che abbiamo oggi a disposizione e le tecnologie di networking ci consentono di produrre comunicazioni multimediali in modo semplice. Oggi abbiamo software che, se usati bene, possono aiutarci a produrre immagini, audio e video di una qualità eccezionale con uno sforzo molto inferiore rispetto a quello era richiesto agli stessi software una decina di anni fa. Una decina di anni fa per produrre un video serviva un intero pomeriggio, oggi basta una mezzoretta e fra qualche anno basteranno solo 10 minuti. Per noi adesso è assurdo il fatto che anni fa non esistessero software così facili da utilizzare; fra 5 anni, ai nostri colleghi, sembrerà assurdo invece che oggi tutti noi impieghiamo ore per fare certe cose. Il progresso scientifico tecnologico va avanti molto rapidamente così come vanno avanti le tecnologie di rete (di networking). Una decina di anni fa sembrava impensabile avere una home page di un sito web con dei filmati video come sfondo perché questi richiedevano un utilizzo di banda molto elevato che allora non era disponibile. Adesso la banda a disposizione è sempre di più e quindi si utilizzano molto spesso i video. Dieci anni fa i video in automatico sulla pagina del Corriere non li mettevano perché appesantivano la pagina, adesso invece li mettono sempre. Il progresso continua ad avanzare e oggi ci permette di utilizzare tanta banda e quindi di utilizzare moltissimo i media.
x
Lefficacia dellintegraione di diversi media: utilizzare più media per comporre un messaggio aumenta la possibilità che questo venga ricordato perché il messaggio diventa più simile al nostro modo di pensare. Noi non pensiamo testuale ma pensiamo multimediale, ci ricordiamo delle canzoni, dee a, dee cee Inoltre, la presenza di media alternativi al testo ci permette spesso di esprimere concetti che altrimenti a parole sarebbero troppo complicati da illustrare. Si sente dire spesso: con un’immagine si esprime un concetto molto più facilmente che con 1.000 parole; embra una banalità ma è vero! Immaginiamoci di tornare a casa, nostra madre ci chiede con chi siamo stati e noi le rispondiamo che eravamo con Luca e Gianni; nostra madre però non si ricorda chi sono e allora noi, per aiutarla, iniziamo a descriverglieli. Se noi invece di perdere del tempo nella descrizione avessimo fatto vedere a nostra madre una foto di Luca e Gianni, lei molto probabilmente se
li sarebbe ricordati subito perché con quella foto/immagine noi esprimiamo un concetto che è molto più difficile da esprimere a parole. Questi due motivi ci portano quindi al grande utilizzo dei media. Però, è tutto veramente così facile come sembra? È davvero così semplice creare comunicazioni/contenuti multimediali? La risposta è NO, non è tutto così facile come sembra. La grande disponibilità e facilità di utilizzo dei software molto spesso può portare a credere che la produzione di comunicazioni multimediali sia alla portata di tutti ma questo è sbagliato. Per affrontare al meglio la produzione e la gestione di una comunicazione multimediale è necessario conoscere e capire le caratteristiche di ogni media che compone la comunicazione. Per produrre unefficace comunicazione ogni media deve essere analizzato sotto 5 diversi punti di vista che sono: 1. percezione Æ come vengono percepite le informazioni daeee a? Se domani noi andiamo al lavoro e il nostro capo ci chiede di creare una campagna pubblicitaria o informativa, la prima cosa che dobbiamo cedec : ce e ecee ee ce daee ae? Se ee ae ecece a a ccae a a e ce cce ad? Se il video fosse proiettato su un grattacielo di New York avrebbe senso che io mi concentrassi sulla comunicazione orale? No, mi devo concentrare sulla comunicazione visiva. Mi devo sempre chiedere come percepisce le informazioni il mio target, la persona a cui io mi rivolgo. Altro esempio: il nostro capo ci chiede di fare una foto, questa foto poi verrà stampata e messa su dei cartelloni vicino a una strada. Se noi ci fermiamo a queste informazioni sicuramente produrremo una campagna comunicativa cattiva. Perché? La strada è una strada di quartiere? È una super strada? È aada? Se a a caaa ccaa cead ae per dei cartelloni che la gente vede camminando a piedi, è una cosa; se ae a de vedere persone che sfrecciano in autostrada a 130 km/h, aa ca ec e ce dedca aa e d ea caaa pubblicitaria è diverso, hanno una percezione diversa della mia campagna pubblicitaria. Se la campagna è dedicata allaada e ce, ad esempio, devono essere molto più grandi, non posso permettermi delle scritte piccole, pec e ce ee dedca aa e dea a ae ee rispetto a quello che dedica alla stessa immagine in un quartiere pedonale; 2. rappresentazione Æ le informazioni multimediali sono sempre più gestite dai computer e quindi è importante capire come avviene la loro rappresentazione ae d e d. I caratteri vengono codificati diversamente dalle immagini; le immagini vengono codificate diversamente rispetto al segnale audio; il segnale audio viene codificato in modo diverso rispetto al modo in cui vengono codificati i video. Io devo sapere anche queste cose; 3. presentazione Æ a ccae edae ee da e eee eeaa aee ae. Il nostro capo ci chiede di realizzare una campagna pubblicitaria con un bel video. Noi siamo inesperti ma comunque non ci facciamo perdere dal panico, andiamo nel nostro ufficio, impieghiamo una settimana per produrre il video, produciamo un bel video orizzontale da proiettare nei cinema e in tv (16:9), lo portiamo al nostro capo e il nostro capo si arrabbia e ci dice ma come faccio io a proiettare un video orizzontale su un grattacielo? La colpa in questo caso è SOLO nostra. Quando il capo ci dice che dobbiamo fare un video, se noi ci fermiamo lì senza chiedere siamo morti. Noi dobbiamo chiedergli: un video per cosa? Netflix? La tv? Il cinema? I social? Dove lo facciamo vedere? A quel punto il nostro capo ci dce è un video per un grattacelo. Sapere dove il video che noi dobbiamo produrre verrà presentato per noi è importantissimo: nel caso del grattacielo il video dovrà essere verticale e non orizzontale. Stessa cosa vale per la comunicazione su carta: se il nostro capo ci dice fammi unimmagine che la dobbiamo stampare, e noi ci fermiamo lì e non chiediamo se la stampa è per un flyer (volantino) o per un cartellone autostradale rischiamo di finire di nuovo nei guai; 4. memorizzazione Æ quanto spazio occupa la mia comunicazione? È importante capire questo perché tendenzialmente le immagini oltre ad essere memorizzate devono essere anche trasmesse. Se ci fermiamo alla memorizzazione uno potrebbe fare un discorso molto opportunistico e dire io so che se vado da Mediaworld con 30 euro mi danno un hard disk da 5 terabyte, io compro questo intanto poi se mi dovesse servire dela
spazio me ne compro un altro. Questo ragionamento va bene finché non mi ritrovo a dover anche trasmettere la mia comunicazione; in quel caso mi si presentano dei problemi in più, mi si richiede un ragionamento in più; 5. trasmissione Æ come vengono fatte le trasmissioni, specialmente dei video? Quando produco una comunicazione multimediale, e ce ee ecea e edee a a ae de ragionevole? Mettiamo che io produca la foto/immagine più bella del mondo, la pubblico sul sito web deaeda, dopo un po accorgo che nessuno visita più il sito. C cce? I capo mi risponde ce daaa ae e cacae ae e 30 ecd. Risultato: nessuno scaricherà mai la mia immagine perché ee arriverà nella pagina web, aspetterà tre secondi poi, vedendo che non viene fuori nulla, se ne andrà. In questo caso non abbiamo ragionato sul tempo. Quando abbiamo a che fare con la trasmissione dobbiamo sempre tener presente da un lato che lee a ee e a d aeae e daa non dobbiamo mai dimenticare che la nostra esperienza personale non vale niente: se noi dobbiamo fare una comunicazione e facciamo i conti solo sulla nostra rete di casa, sbagliamo. Noi non possiamo ragionare con la nostra esperienza. Se noi abitiamo in una città abbiamo una quantità di banda che sicuramente è molto più grande rispetto a chi abita in zone rurali. In Italia abbiamo delle zone dove la banda c, e sono tendenzialmente le grandi città, e poi abbiamo dee e de a bada c aa a aca. Questo comporta che non siamo tutti uguali. Il 60% degli italiani, secondo una statistica dello scorso anno, e e de c a bada aa, de e aede ae e ec ae a ea investire. Se la nostra comunicazione, che sia essa unimmagine, un audio o un video implicitamente suppone ce ee abba a bada aa, abbiamo perso il 60% di potenziali clienti e il nostro capo non sarà contento di noi. La banda, quindi, è un altro discorso molto importante che bisogna tenere presente. Senza analizzare i media da questi 5 punti di vista rischiamo di creare una comunicazione multimediale che imbocca la strada del fallimento.
(2) La rappresentazione delle informazioni a) Il bit Le informazioni - siano esse composte da testo, immagini, brani musicali, video - gestite da un computer devono essere rappresentate c a ecca da baaa d eee: bit. Noi siamo esseri umani, parliamo e scriviamo con un alfabeto di 21/26 caratteri; la matematica ci dice che 1 + 1 = 2. Per il ce ea ca dce perché il computer non ha idea di cosa sia una lettera, così come non ha idea di cosa sia un numero. Il computer sa una sola cosa e cioè sa che esistono i bit. Il bit (binary digit) permette di definire due possibili alori, in alternatia luno allaltro. Il computer non sa che 1 + 1 = 2 perché 2 non sa cosa sia; il computer sa che 1 + 1 = 10; 10 non è dec come noi lo leggiamo ma è 1 - 0, cioè tu prendi un bit gli aggiungi un altro bit e il computer sa che il risultato è una sequenza di due bit che è uguale a 1 e 0. Noi quindi ragioniamo in un modo, e il computer ragiona in un altro. Siccome però noi dobbiamo governare il computer dobbiamo capire come questo ragiona. Il computer non è una macchina intelligente, il computer è una macchina stupida con un grande pregio: sa fare i conti alla velocità della luce ed è grazie a questo che noi riusciamo a fargli fare delle cose meravigliose. Queste cose che sono meravigliose il computer le fa perché è veloce e non perché è intelligente. Leea ce a ce ce ha perché gliela diamo noi. Bit Æ unità minima che può assumere due stati: 0 - 1 Questo bit che può assumere due stati il pc lo utilizza per tutti i suoi ragionamenti. Il computer utilizza un sistema di numerazione binario e cioè un sistema a due stati (0 - 1); se utilizzasse una numerazione decimale avrebbe 10 stati diversi. Perché noi usiamo il decimale e il computer no? Perché noi abbiamo 10 dita e quindi contiamo in base 10. Il pc non ha le dita e quindi conta in base due. È possibile passare da un sistema binario a un sistema decimale e viceversa? Sì. sistema binario Æ 1001 = 9 Å sistema decimale
1001: sequenza di 4 bit. Questa sequenza ha per il computer un significato (1001) e per noi un altro (9); 1001 e 9 in realtà sono la stessa cosa perché per noi si scrive 9 e per il computer si scrive 1001. Come si fa a convertire da numero binario a decimale?
A cosa mi serve questa roba? Se il computer non sa nulla ma sa solo in 0 e 1 come fa a farmi vedere tutti quei video, immagini? Lo fa attraverso i bit. Il ragionamento che si fa è questo: abbiamo visto che esistono delle sequenze di bit (1001). Se io ho una sequenza di un solo bit, ho un solo bit che può assumere o il valore 1 o il valore 0. In questo caso io posso dire al mio computer che lo zero, ad esempio, aeea bac e 1 e.
Con un bit io posso già insegnare al computer ad usare due colori, il bianco e il nero. Che i due colori sono bianco e nero quella è una cosa che decido io; i colori potrebbero anche essere rosso e verde, o verde acqua e marrone scuro. Quello che interessa al computer è sapere che ci sono due cose diverse poi sta a me, essere umano, decidere e dirgli, attraverso dei software, che lo zero equivale a un colore e 1 equivale ad un altro colore. Il colore è solo un esempio perché se io fossi in un altro ambiente potrei digli che 0 = acqua fredda e 1 = acqua calda o che 0 = cappuccino e 1 = caffè. Lae cae ce computer capisce che ci sono due cose diverse, quali sono queste due cose diverse lo decido io. Uno potrebbe però dire, mi sembra che però sul computer ci sia qualcosa in più del bianco e nero, mi sembra che ci sia un qualche colore in più.
Come facciamo a fare i colori in più? Possiamo aggiungere dei bit alla sequenza di prima.
In generale la regola è che se abbiamo una sequenza di bit lunga n, per sapere quanti colori/stati diversi possiamo avere, dobbiamo fare 2 elevato alla n; con una sequenza di n bit io posso rappresentare 2 alla n stati/colori diversi.
Quindi, se io ho una sequenza di n bit posso calcolare il numero di colori che posso avere/rappresentare. Ora facciamo il gioco contrario: io devo rappresentare 65 diversi colori. Qual è il numero minimo di bit che devo avere? noi partiamo sempre da:
questo comporta che:
quindi:
Si può anche pensare però di procedere in un altro modo e fare cioè di prove:
Con questi giochi abbiamo capito due cose importanti ossia che: x x
con una sequenza di n bit io posso rappresentare 2 alla n stati (colori) Æ se io ho la lunghezza della sequenza di bit (n bit), posso calcolare il numero massimo di colori (stati) che io posso rappresentare; se io ho il numero di colori che devo rappresentare (N), posso calcolare il numero minimo di bit che devo avere tenendo presente che .
b) Il byte I b abba ca ce c, a l byte? Ce c be? Il byte altro non è che una sequenza di 8 bit.
Con 1 byte (8 bit) io posso rappresentare 256 colori/stati diversi. Attenzione alla scrittura! D BIT dca c a b cca Æ 8b = 8 bit. Se troviamo invece indicato 8B = 8 BYTE, e 8 BYTE = 8B * 8b = 64b. 32b = 4B, infatti, 4B * 8b = 32b Se devo rappresentare 65 diversi colori, qual è il numero minimo di byte che devo avere?
Risposta:
oppure:
Possiamo avere a che fare anche nella vita con bit e byte e conoscerne la differenza ci può aiutare a fare delle scelte. Ad esempio, se un operatore telefonico ci vende un piano mensile di 3 gigabit a euro 5,00 e un altro ce ne vende uno di 2 gigabyte a euro 5,00, quale ci conviene scegliere? Quello di 2 gigabyte.
Bit e byte non sono però le uniche unità di misura:
Se volessimo esprimere queste unità di misura in bit? 1KB (ICT) = b? Æ 1024B * 8b = 8192b 1KB (SI) = b? Æ 1000B * 8b = 8000b La dee d ae, e ae de ee, eee eea be (KB) eabe (MB); la velocità di una connessione può essere espressa in megabit (Mb); lo spazio di un hard disk eee ede de gigabyte (GB) o dei terabyte (TB).
(3) Le reti di comunicazione Il principale canale di distribuzione dei contenuti multimediali, e quindi anche della comunicazione, è Internet. Internet è la porta di ingresso che ci consente di accedere ad una grande quantità di contenuti multimediali.
La rete internet Internet: x x x
x
è la più grande rete di comunicazione al mondo; nasce negli anni 60 da e d ceca aa daaea aee DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) con il nome di ARPANET; a a host (dispositivi) erano collegati ad Internet. Oggi internet connette miliardi di dispositivi chiamati end-system, end-host o semplicemente host in tutto il mondo (parliamo d d o di host e d ce ec a, e a 60, solo i computer erano collegati ad internet ma adesso sono collegati ad internet tv, cellulari, computer, tablet, automobili ); supporta il funzionamento di applicazioni che sfruttano la rete per comunicare (Skype, Googlemeet, il browser, gmail, il web sono tutte applicazioni che senza rete non funzionano).
Internet nasce negli anni 60. In quegli anni i computer erano grandi quanto stanze e costavano tantissimo per cui pochi centri di ricerca potevano permetterseli. Lbbe de e DARPA ea e d creare una rete di comunicazione ad d ceee ce ee ae d e e d ceca. Il progetto, con il nome di ARPANET, nel 1969 divenne operativo, una realtà. Le caratteristiche di ARPANET erano molto diverse da quelle della rete internet di oggi: ARPANET metteva in comunicazione quattro computer, uno situato a Los Angeles, uno situato a San Francisco, uno in Utah e uno a Santa Barbara. Da questa rete hanno iniziato poi a svilupparsi una serie di applicazioni: Nel 1972 nasce la posta elettronica (e-mail): viene introdotta la possibilità di mandare messaggi a persone attraverso la rete. Nel 1973 ace ftp (applicazione che consentiva il trasferimento di file da ce aa).
Nel 1978 nasce BBS (bacheche degli annunci): in quegli anni non esistevano ancora i siti web ma esistevano dei posti in internet dove si potevano mettere degli annunci digitali. Nel 1979 nasce news: ci si connetteva ad un certo host nel mondo e grazie a questo poi si potevano leggere d notizie. C eade dea ee cresceva la necessità di avere delle regole ben definite per gestire le trasmissioni. Nel 1983 nasce il protocollo di comunicazione che noi utilizziamo tuttora, il protocollo TCP/IP. Dal 1983 tutti i computer dovevano parlare il linguaggio TCP perché altrimenti non sarebbero stati in grado di comunicare tra loro. Nel 1987 è stato sviluppato GIF. Nel 1988 nascono MPEG (MP3) e Internet Replay Chat (IRC), il primo programma per chattare in rete. Nel 1989 a HTML nei laboratori del CERN di Ginevra; questo a e ceae acae World Wide Web che nacque ufficialmente nel 1991. Nel 1992 nasce JPEG. Nel 1993 nascono MPEG1 e Mosaic X, il primo browser a livello mondiale che ha premesso a quelli che erano gli studenti di allora di informatica di accede...
Similar Free PDFs
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu