Riassunto de i trucchi del mestiere becker PDF

| Title | Riassunto de i trucchi del mestiere becker |
|---|---|
| Course | Sociologia |
| Institution | Università di Bologna |
| Pages | 14 |
| File Size | 384.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 41 |
| Total Views | 136 |
Summary
riassunto i trucchi del mestiere...
Description
I TRUCCHI DEL MESTIERE – Becker CAPITOLO 1 – TRUCCHI Becker racconta come Hughes non aderisse al concetto di teoria. Ad esempio la definizione di gruppo etnico canonico è data dalla distinzione di tratti fisici e religiosi… Secondo Hughes un gruppo è etnico quando le persone all’interno e quelle all’esterno sanno che lo è sono modi di stabilire chi è dentro e chi è fuori. Sta tutto nel riconoscere che non si può studiare il gruppo etnico isolatamente, e che bisogna invece individuare la sua etnicità nella rete di relazioni con altri gruppi dalla quale essa emerge. questo è un trucco, ovvero uno stratagemma semplice che aiuta a risolvere un problema. Nelle scienze sociali sono espedienti maturati dall’esperienza. Ogni mestiere ha i suoi trucchi, le sue soluzioni ai problemi che lo contraddistinguono. Un trucco è un’operazione specifica che mostra un modo per aggirare qualche difficoltà comune, suggerendo una procedura che risolve con relativa facilità quello che altrimenti sembrerebbe un problema impossibile e persistente. Sono modi per pensare a ciò che conosciamo o che vogliamo conoscere aiutandoci a interpretare i dati e a formulare nuove domande basate su quanto abbiamo trovato. Spesso questi trucchi porteranno a formulare cose più difficili e complesse, i trucchi infatti sono modi di ribaltare la situazione, di vedere le cose in modo diverso, al fine di creare nuovi problemi di ricerca, nuove possibilità di comparare casi. Tutto questo significa lavoro in più. In ogni capitolo si affronta il tema delle convenzioni (sociali e scientifiche) come uno dei principali nemici del pensiero sociologico. Spesso si parlerà di situazioni che sono già state studiate da altri ricercatori e che i nuovi studiosi sono portati ad adottare queste idee convenzionali senza metterle in discussione. CAPITOLO 2 – IMMAGINI Come è fatto il lavoro dello scienziato sociale? Come si formano le nostre immagini sul mondo? Come pensiamo a ciò che ci prepariamo a studiare prima della ricerca? Blumer rimproverava ai sociologi di porre a fondamento del proprio lavoro un immaginario manifestatamente incompatibile con ciò che si viveva nella realtà quotidiana, perché solitamente il ricercatore non partecipa alla sfera di vita sociale che si propone di studiare e non è in relazione stretta con le persone coinvolte in quella sfera. Per studiare bene il fenomeno, secondo Blumer, bisognava conoscere bene l’ambito di vita sociale di ciò che si andava studiando. Prima di studiare la realtà noi costruiamo l’immagine che abbiamo di essa (anche attraverso dati statistici che abbiamo di quella realtà). Secondo Blumer l’operazione fondamentale nello studio della società è la produzione e il perfezionamento di un’immagine di ciò che stiamo studiando. Qualsiasi persona vede qualsiasi area sociale non familiare attraverso immagini che già possiede. In questa fase prendono il controllo le immagini stereotipate: se un ricercatore non vive la situazione sarà portato ad attribuire significati alle situazioni analizzate che derivano dal proprio vissuto e questo porta al pericolo di sbagliare. Un ricercatore in scienze sociali usa anche un altro insieme di immagini prestabilite. Queste immagini sono costituite dalle sue teorie, dalle credenze correnti… Quando manca la conoscenza vera, il nostro immaginario prende il sopravvento. Secondo Molotoch l’esperienza diretta è qualcosa di importantissimo per la ricerca: senza una conoscenza basata su esperienza di prima mano e una partecipazione più completa nella società non sappiamo dove
1
guardare per trovare cose interessanti e non sappiamo identificare ciò che non ha affatto bisogno di lunghe ricerche e dimostrazioni. Siccome siamo scienziati sociali di solito facciamo ricerche per vedere se abbiamo ragione o meno, facciamo indagini, raccogliamo dati e costruiamo ipotesi e teorie. Questo è uno stereotipo non comune ma condiviso da un gruppo professionale. L’immaginario professionale è un immaginario che fa emergere qualità astratte che solo i professionisti possono intravedere. Creare una teoria o una spiegazione scientifica accettabile vincola in due modi l’elaborazione della storia che racconteremo. La storia deve funzionare: deve aver senso. Deve essere conforme ai fatti che abbiamo scoperto. NON ACCETTIAMO STORIE CHE NON SONO CONFERMATE DAI DATI CHE ABBIAMO A DISPOSIZIONE. Non accettare una storia significa credere che il suo modo di immaginare come le cose funzionano è sbagliato in qualche aspetto importante: dobbiamo provare a cambiare la storia per renderla più coerente o cambiare la storia per renderla più conforme ai fatti? Dovremmo fare entrambe le cose e le facciamo. Il problema è quando farle e se fare prima l’una e poi l’altra o viceversa. A volte estendiamo le nostre storie al resto del mondo altre volte cerchiamo situazioni che confermino storie già trovate da altri. È la partecipazione a un mondo professionale di scienziati sociali che ci offre questi paradigmi. - 1° TRUCCO: il TRUCCO DELL’IPOTESI NULLA. Non è sempre necessario che il nostro immaginario sia accurato. Le immagini inesatte che ci creiamo, a patto che poi vengano verificate nella realtà, possono essere utili perché ci mostrano come andrebbero le cose in circostanze che siamo più o meno certi non sussistano. ATTRIBUZIONI CASUALI. Il trucco consiste nel porre un’ipotesi nulla, ossia un’ipotesi che il ricercatore pensa sia falsa. Provare che l’ipotesi nulla è sbagliata significa anche provare che qualcos’altro dovrà essere vero, anche se non dice cosa sia. Si afferma così che due variabili sono correlate solo dal caso. Il trucco dell’ipotesi nulla è una versione qualitativa o teorica del procedimento statistico. Si comincia con l’osservare che ogni evento sociale è generato dall’attività congiunta di tante persone. Questo trucco consiste nel supporre che la selezione dei partecipanti sia casuale, che ogni membro del più vasto insieme dei potenziali partecipanti avesse la stessa probabilità di essere scelto. Si finge che vi sia una selezione casuale proprio per vedere come il gruppo scelto per partecipare differisce da quello che sarebbe scaturito da una selezione casuale.si suppone che ci sarà una differenza e si vuole sapere quale sarà. Un “problema ben definito” è un problema per il quale abbiamo già escluso di prendere in considerazione tutta una serie di processi potenzialmente molto interessanti. Non c’è ragione di limitare l’uso del trucco alla selezione delle persone: per esempio si può usare il trucco sulle scelte delle persone. I vincoli sono le circostanze che hanno spinto l’attore a fare una certa scelta. Un’analisi scientificamente adeguata di una situazione illustrerà l’intera gamma di vincoli lì operanti, ma per fare ciò dobbiamo conoscere la gamma completa di possibilità dalla quale le scelte che osserviamo sono state operate. Cosa ci fa una brava ragazza come te in un posto come questo? Un’altra ipotesi nulla può essere quella sulla follia: le persone spesso definiscono qualcosa come folle perché non lo approvano o perché non ne comprendono il senso. Presupponendo che una pratica che reputiamo folle sia perfettamente sensata ci si può accorgere come questa pratica, per alcuni folle, può avere un senso per altri. Bisogna considerare che le cose spesso si presentano come una buona idea perché le loro conoscenze non sono visibili quando l’azione viene compiuta. Le cose spesso ci appaiono 2
incomprensibili semplicemente perché siamo troppo lontani dalla situazione per conoscere le condizioni contingenti reali in cui l’azione è stata decisa. Solo quando le circostanze sono rese intellegibili si può comprendere effettivamente il senso dell’azione e del comportamento per quella persona. È sempre meglio supporre che un’azione abbia un senso per poi cercare di capire quale sia. Un altro tipo di immagine utile è la nozione di COINCIDENZA: le cose non sono mai totalmente casuali ma nemmeno totalmente determinate. Si potrebbe dire che esse coincidono. La coincidenza spesso è il termine adatto per descrivere un accaduto, per rispondere alla domanda perché proprio io e non qualcun altro? Tutti usiamo il caso e la coincidenza come spiegazione. Le cose non accadono e basta ma si producono in una serie di tappe: processi o storie. Il percorso che porta a un dato evento può essere descritto come la successione di eventi che sono contingenti reciprocamente (cambia la tua vita con un click, sliding doors). Tutto ciò che ci capita non dipende solo dalle nostre azioni ma anche dalle azioni di chi ci sta accanto intercontingenza. La società come macchina il trucco: la società è una grande macchina è appropriato per un contesto reale ripetitivo: la maggior parte delle organizzazioni sociali presenta aspetti ripetitivi. Quando è in gioco qualcosa di importante i sociologi dimenticano le proprie teorie. Omettono di seguire le chiare istruzioni che quelle teorie implicano e di considerare tutte le persone e le organizzazioni che contribuiscono a produrre un risultato. Il trucco della macchina è pensato per questo tipo di problema: per spingerci a non lasciar fuori qualche elemento cruciale della situazione. Per applicarlo bisogna pensare al sociologo come un ingegnere che vuole che la sua macchina funzioni. Bisogna accertarsi di aver incluso tutte le parti e tutte le descrizioni dei materiali e delle loro qualità necessarie per ottenere il risultato voluto. Se il prodotto non aggrada bisogna fare quello che gli informatici chiamano “ingegneria a ritroso”, cioè smontare la macchina e scoprire come funziona, quali sono le sue parti, come si connettono e cosa succede dentro la scatola nera. Ci accorgeremo che i fenomeni sociali sono connessi in così tanti modi e a così tante condizioni ambientali che non si sarà mai in grado di ricreare un progetto perfettamente adeguato. Immaginare una tale macchina ci dà una ragione per includere quello che altrimenti avremmo potuto lasciare fuori. La macchina non funzionerà se non c’è tutto quello che serve per farla funzionare. La società come organismo utile quando si vuole sottolineare l’aspetto di interconnessione rispetto a quello della ripetizione: si pensa che le cose non restino immutate ma che un giorno saranno tutte connesse tra loro. Connessione significa anche variazione: c’è una cosa che varia e un’altra che di conseguenza subirà anch’essa una qualche variazione. L’input viene da qualcosa e poi si trasforma in output dei sotto-processi che diventerà input per altri processi. La società come organismo in cui ci sono connessioni tra i vari sistemi di attività sociale che contribuiscono al risultato che ci interessa. Questa idea di società funziona quando vogliamo tenere conto delle variazioni indipendenti di interi sottosistemi di fenomeni né totalmente privi di legami né strettamente correlati. Da questa idea derivano due trucchi: - pensare alle PERSONE COME ATTIVITà, cioè i tipi di attività che le persone svolgono. Offre un sostituto all’abitudine dei sociologi di creare tipologie di persone (devianti e non devianti per esempio) che permette loro di prevedere il comportamento, in quanto si pensa che le persone agiscano sempre in base al personaggio a loro attribuito. Bisogna passare dal tipo di persona la tipo di attività, in modo da rendere il problema più gestibile: presupporre che le persone cambino modo di comportarsi in base alla situazione (studio del comportamento indipendente e non delle persone indipendenti - Lindesmith). Fare una 3
certa attività porta le persone a reagire in modo tale da rendere più probabile il continuare a fare quell’attività. Fa avviare una serie di processi che renderebbero più probabile continuare a fare l’attività. Concentrarsi sulle attività piuttosto che sulle persone spinge a interessarsi al cambiamento piuttosto che alla stabilità, a pensare in termini di processi piuttosto che di struttura. - LE COSE NON SONO ALTRO CHE PERSONE CHE AGISCONO INSIEME: spesso gli studiosi sostengono che gli oggetti sociali hanno proprietà e scopi sociali e che queste proprietà sono vincolanti alle azioni delle persone. A volte però gli oggetti non assumono quelle proprietà definite (la droga che non fa fare trip) Gli oggetti continuano ad avere le stesse proprietà finché le persone continuano a pensarli e definirli nello stesso modo. Il trucco analitico consiste nel vedere nell’oggetto fisico davanti a noi tutte le tracce di ciò che lo ha portato a diventare quello che è. - OGNI COSA AVVIENE DA QUALCHE PARTE: mantenere segrete le identità delle persone che si studiano è ritenuto fondamentale dai sociologi. Però danno una breve descrizione del contesto della loro ricerca, il luogo da cui provengono i loro dati. Agli scienziati sociali piace fare generalizzazioni, amano minimizzare ciò che rende il loro caso diverso dagli altri, affermando che il loro caso è rappresentativo. Questo in parte è sbagliato perché spesso sottovaluta la presenza e la rilevanza del luogo, dello sfondo. Infatti le condizioni contestuali di un evento o di un’organizzazione o di un fenomeno sono cruciali perché esso accada o esista nelle forme che effettivamente assume. Quindi piuttosto che provare ad ignorare o controllare le variabili locali/ le condizioni contestuali, dovremmo trovare queste peculiarità locali e includerle nei nostri risultati. Ciò porta a due trucchi: ogni cosa avviene da qualche parte: guardare da vicino le caratteristiche fisiche e sociali del luogo; includere ciò che non può essere tralasciato: è impossibile sapere e tener conto di tutto a proposito di tutto, quindi bisogna pensare a ciò che si studia cercando di notare quali caratteristiche del posto di invocano come spiegazioni ad hoc. A ciò si aggiunge il fatto che proprio come tutto deve accadere in qualche luogo, ogni cosa avviene in un qualche momento. Narrazione: parte del processo di costruzione di una narrazione è una continua ridefinizione di cosa la teoria sta spiegando. CHIEDERE COME NON PERCHE’: quando si chiede perché alle persone queste solitamente si mettono sulla difensiva, dando risposte brevi e guardigne. Quando si chiede come le persone danno risposte lunghe, con dettagli interessanti. Queste domande danno più margine e sono meno vincolanti, sono domande che non hanno una risposta giusta: le persone possono rispondere come vogliono. Mostrano una curiosità senza scopo e disinteressata. Serve per conoscere tutto: sequenze e dettagli dell’evento. Le persone hanno la libertà massima di parlare di ciò che vogliono e di dire cose a cui il ricercatore non aveva pensato. PROCESSO: si suppone che l’argomento che si voglia studiare abbia più una storia che delle cause. Questo approccio ci fa capire come accadono gli eventi mostrandoci le tappe del processo che li ha generati, piuttosto che le condizioni che li ha resi necessari. I ricercatori cercano storie tipiche, storie che più o meno si sviluppano nello stesso modo. Gli scienziati sociali chiamano queste storie processi. Gli eventi non sono causati da nient’altro che dalla storia che li ha portati a essere come sono. Ad esempio per capire perché due persone si separano è importante sapere/conoscere le fasi del processo di separazione anziché i fattori attorno alle circostanze. Le narrazioni di processo non hanno uno scopo predeterminato: possono finire in modi diversi e in alcuni casi questi non producono ciò che vogliamo studiare. Questa teoria destabilizzerà chi invece pensa che la causa A
4
porta sempre a B, alle condizioni C, D, E: vogliono poter dire che una certa cosa doveva succedere perché c’è una legge sociologica che ne mostra la necessità logica. CAUSE: ultimo tipo di immaginario è la causalità: qualcosa causa qualcos’altro. Queste procedure spesso sono descritte con il linguaggio delle variabili dipendenti e indipendenti, i risultati poi verranno utilizzati per una grande quantità di casi simili. La definizione di causa è covarianza. In questo modello le cause operano contemporaneamente e simultaneamente per la produzione di un effetto. In questo caso i soggetti non sono persone o organizzazioni ma sono variabili che producono un effetto o una qualche variazione misurabile nella variabile dipendente. I risultati sono destinati ad essere generalizzati. Un altro approccio, descritto da Ragin ha un’immagine di causalità alquanto diversa: riconosce che le cause non sono in generale veramente indipendenti e che esse non danno ciascuna il proprio contributo indipendente al vettore che produce il risultato complessivo nella variabile dipendente le cause sono efficaci solo quando operano insieme. CAPITOLO 3 – CAMPIONAMENTO Consiste nella selezione di casi da un universo più grande di casi. Cosa includere: Campionamento e sineddoche: la sineddoche rappresenta il tutto da cui è stata selezionata. Qualunque sia l’oggetto che ci interessa, non si possono studiare tutti casi. Ogni impresa scientifica si prefigge di scoprire qualcosa che si possa applicare a tutti i casi di un certo tipo dopo averne studiato qualche esempio, dal momento che il risultato della ricerca è generalizzabile a tutti i membri di quella classe di oggetti. Il campione deve quindi mostrare in modo convincente che sappiamo qualcosa sull’intera classe. Il campionamento è un tipo di sineddoche, ovvero una parte di qualcosa che rinuncia ad un tutto, il suo scopo però è persuadere, non studiare/ricercare. A prima vista il problema sembra essere che le caratteristiche della parte selezionata non rappresentano la totalità dei casi. Campionamento casuale: una soluzione perfetta (per alcuni problemi). Attraverso il campionamento causale si scelgono i casi in modo tale che ogni membro della popolazione abbia una probabilità nota di essere scelto per il campione. Comunque sia la relazione tra il valore di una variabile nel campione e il suo valore nella popolazione è un problema ma non è l’unico problema del campionamento. Un altro problema si riferisce a stabilire che tipo di organizzazione costituisce il tutto di cui l’oggetto che abbiamo studiato non è che una parte. Poniamo queste domande perché vogliamo conoscere quali sono tutti i membri della classe cui le nostre generalizzazioni intendono riferirsi. Vogliamo evitare di presupporre che alcune caratteristiche contenute nel campione siano naturalmente presenti in tutti i membri della classe e quindi non richiedono spiegazione. Prima di parlare dei trucchi per trovare la sineddoche giusta si vuole riportare un sogno comune a molti sociologi: anziché prendere in considerazione un campione, prendere la “totalità delle cose” il caso dell’etnomusicologia: mira a migliorare la musicologia tradizionale liberandola dal suo etnocentrismo, per questo vuole risolvere il problema del campionamento raccogliendo tutta la musica che esiste ed è esistita. Alla fine si nota che c’è così tanta musica che si fa fatica ad andare oltre la raccolta, quindi ci sarebbe per forza un principio di selezione. Cosa possiamo tralasciare? Nulla se abbiamo proceduto secondo questa linea. Bisogna quindi creare le sineddoche del campionamento come metodi i cui risultati devono essere valutati rispetto all’ideale di descrizione totale e completa di tutto ciò che è e potrebbe essere rilevante per quello che vogliamo dire con sicurezza su un dato fenomeno sociale. Quanto dettaglio? Quanta analisi? Quando Becker insegna ricerca sul campo dice agli studenti di prendere nota di TUTTO, questo per fare un resoconto dell’universo di ciò che è pertinente. Il compito è irrealizzabile anche su piccola scala, non si può prendere nota di tutto. Questo però non 5
significa che non si possa scrivere molto di più di quanto non facciano di solito gli studenti. Richiede di fare anche una descrizione senza interpretazioni. Trovare la giusta proporzione tra descrizione e interpretazione è un vero problema che chiunque vuole descrivere il mondo sociale deve risolvere o saper affrontare. Non esiste una descrizione pura, ma il fatto che non ci si possa mai liberare della necessità di fare una selezione non significa che non esistano diversi gradi di interpretazione, che alcune descrizioni possono essere meno interpretative di altre. L’enumerazione non è un’arte facile. Bisogna capire cosa significa enumerare senza mai commentare. Una descrizione complessa, senza mai scendere nelle interpretazioni è in grado di far comprendere la situazione e scaturire nel lettore un’interpr...
Similar Free PDFs

I trucchi del mestiere (Becker)
- 14 Pages

I trucchi del mestiere
- 10 Pages

Riassunto arte come mestiere
- 7 Pages

Factura Becker
- 3 Pages

Outsiders Becker
- 14 Pages
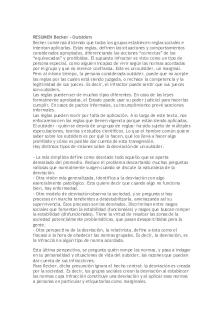
Resumen Becker
- 7 Pages

I terremoti - riassunto schede
- 2 Pages

Iliade riassunto libro I
- 2 Pages

Riassunto teoria Fisica I
- 30 Pages

I TEST PSICOLOGICI RIASSUNTO
- 32 Pages

Riassunto I TEST Psicologici
- 47 Pages

Riassunto I processi cognitivi
- 50 Pages

Synthèse sur Howard Becker
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


