Riassunto - Sorvegliare e Punire - Michel Foucault PDF

| Title | Riassunto - Sorvegliare e Punire - Michel Foucault |
|---|---|
| Course | Ergonomia |
| Institution | Università degli Studi di Torino |
| Pages | 15 |
| File Size | 237.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 117 |
| Total Views | 155 |
Summary
Download Riassunto - Sorvegliare e Punire - Michel Foucault PDF
Description
Michel Foucault – Sorvegliare e punire: nascita della prigione Parte 1 – SUPPLIZIO
1 – Il corpo del condannato Tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 tutta l’economia del castigo viene ridistribuita in Europa e negli Stati Uniti: una nuova teoria della legge e del crimine, nuova politica del diritto di punire. Fra tante modificazioni: la sparizione dei supplizi. Il corpo suppliziato è scomparso: E’ scomparso il corpo come bersaglio della repressione penale. Due processi: 1 scomparsa dello spettacolo nella punizione che diventa la parte più nascosta del processo penale (certezza, non visibilità) (è poco glorioso punire) 2 è la presa sul corpo ad allentarsi. Cambia il rapporto castigo corpo: nei sistemi moderni le pene sono fisiche ma per la privazione della libertà: dalle sensazioni insopportabili (dolore fisico) ad una economia dei diritti sospesi (dal boia ai medici, sorveglianti, psichiatri) Esempio del doppio processo: l’esecuzione capitale moderna (per tutti, stessa morte. Un istante che tocca la vita piuttosto che il corpo). Altro esempio: l’ultima traccia dei supplizi sono i veli per nascondere il corpo. Lo strumento: la ghigliottina (visibile ma istantanea, un lampo, nessuno scontro). La sparizione dei supplizi può definirsi acquisita 1830-48 ma l’evoluzione è irregolare: piccole trasformazioni e modifiche, resistenze. Abbiamo delle tracce del supplizio sia per lo spettacolo che per la presa sul corpo anche in tempi successivi al 1840: nei meccanismi moderni permane un “fondo suppliziante”, non ancora dominato, ma avvolto da una penalità dell’incorporeo.
Attenuarsi della severità penale: a lungo un fenomeno quantitativo (intensità, meno dolore e crudeltà, più rispetto e umanità) ma abbiamo un cambiamento qualitativo , di obiettivo: non più il corpo ma l’anima. 1 Cambia la natura del reato: l’oggetto delitto viene modificato. Sia perché molti crimini non esistono più (blasfemia) ma soprattutto: la qualità, natura e sostanza dell’elemento punibile; si giudicano istinti, passioni, anomalie, infermità, perversioni, aggressività e non per chiarire il fatto delittuoso, ma per giudicare queste ombre. Entrano in scena attenuanti, passato e aspettative: la conoscenza del criminale, qualificare l’individuo; in sostanza si giudica qualcosa di diverso dai reati: l’anima. Ma la giustizia non si occupa solo di giudicare: nasce un altro tipo di elaborazione della verità, un complesso scientifico-giuridico che riguarda esperti (psichiatrici, psicologia, educatori, funzionari penitenziari) che illuminano la decisone del giudice riguardo: amministrazione pena , necessità, utilità e efficacia; una prescrizione del trattamento medico-giudiziario; il potere di giudicare si trasferisce, in parte, ad istanze diverse dai giudici. La funzione è: non semplicemente punire legalmente, ma guarire e discolpare il giudice dall’essere colui che castiga.
Analizzare i sistemi punitivi come fenomeni sociali. Rapporto fra sistemi punitivi e sistemi di produzione da cui essi ricavano i loro effetti (epoca feudale - pene corporali, economia servile - schiavitù “civile”, sistema industriale - detenzione correttiva.) Perciò i sistemi punitivi sono inseriti in una “economia politica” del corpo: un investimento politico del corpo che è legato alla sua utilizzazione economica (corpo come forza utile se è produttivo e assoggettato). Non si tratta di una appropriazione del corpo, ma una strategia (disposizioni, manovre, tattiche,funzionamenti) che investe i corpi per mezzo loro e attraverso loro. Cosi le tecniche punitive devono essere intese nella loro funzione sociale e politica: si collocano in un rapporto tra potere e produzione di sapere (attraverso il corpo): il potere produce sapere. Il soggetto che conosce, gli oggetti da conoscere e le modalità della conoscenza sono effetti del potere; allo stesso modo non esiste potere senza un campo di sapere correlativo (a cui è applicato). Un esempio che richiama tutti i concetti (corpo, punizione, politica, potere e sapere): alla morte 1
il corpo del Re simboleggia il “più di potere” e il corpo del condannato indica il “meno di potere”, e la diversità emerge nei cerimoniali, nei riti: uno gloria, l’altro supplizio; (il condannato è la figura simmetrica e inversa del Re).
2 – Lo splendore dei supplizi
Il supplizio è una pena corporale, dolorosa, più o meno atroce: una tecnica e non un atto selvaggio. La punizione deve far splendere agli occhi di ciascuno il crimine in tutta la sua durezza, deve portare alla luce la sua atrocità. I supplizi propriamente detti erano il 10% nella seconda metà del 700 ma le pene più comuni come il bando o l’ammenda erano accompagnate da una dimensione di supplizio (esposizione,gogna, frusta, marchio). 3 criteri del supplizio: 1. Deve produrre una certa quantità di sofferenza: c’è un arte quantitativa, è calibrata con la gravità del crimine (numero colpi, zona, lunghezza, tipo di mutilazione). 2. E’ un rituale che assolve due esigenze: essere marchiante (rendere infame) e non riconciliante (segni incancellabili). 3. Essere clamoroso: eccesso di violenza che indica trionfo, gloria, manifestazione di potere di chi punisce.
Il supplizio si inserisce in un cerimoniale giudiziario che deve produrre la verità del crimine Il sapere era privilegio dell’accusa, del magistrato; egli costruiva da solo e segretamente una verità e con pieni poteri la consegnava al giudice (rinvia al principio che il sovrano ha un potere assoluto). Ma c’erano delle regole, un modello rigoroso di dimostrazione della natura e efficacia delle prove: queste erano distinte in prove piene, semipiene e leggeri indizi perché avevano un effetto giudiziario diverso, e queste si combinavano con calcoli precisi (aritmetica penale). Scritta, segreta, e con regole, l’istruttoria penale produce verità in assenza del condannato. La procedura tende alla confessione (anche se non è strettamente necessaria). La confessione presenta due ambiguità: è una prova forte ma non basta e richiede un’istruttoria che porti alla condanna, e si forza un’autocondanna in un contesto formale (tribunale) per dimostrare la sua spontaneità. La confessione è cosi importante che si utilizzano due mezzi: il giuramento (alla legge e a Dio) e la tortura. E’ in questo meccanismo che troviamo la quaestio ossia una indagine sulla verità tramite la tortura: con regole e procedure ben codificate (momenti, durata, strumenti, lunghezze, cunei, interventi); quasi una sfida tra il giudice e il condannato in cui alla fine uno vince; anche il giudice che la richiede rischia: non solo la morte del condannato, ma se non ottiene la confessione deve abbandonare l’accusa e il condannato ottiene uno sconto. Una battaglia, scontro fisico, un duello che produce verità. La tortura è in questo sistema sia una punizione (rituale punizione), sia un atto istruttorio (rituale verità). Nel cerimoniale del castigo il corpo è suppliziato per mostrare la verità in un’esecuzione pubblica. Diversi aspetti: 1. che il condannato proclami e attesti la propria condanna, la verità, sul suo corpo (cartelli, letture, esposizione). 2. perseguire ancora la confessione: riconoscimento spontaneo e nuove rivelazioni vengono attese. 3. stabilire una relazione tra delitto e supplizio: esposizione ed esecuzione nel luogo del delitto, supplizi simbolici che rinviano al delitto (lingua-bestemmiatore). Rendere pubblico delitto per “annullarlo” col la propria morte. 4. lentezza del supplizio e sofferenza: maggiori le grida, l’intensità del dolore, e più costituiscono prova di verità. Effetti clamorosi, maggior splendore.
2
Il ciclo è chiuso: dalla quaestio all’esecuzione, il corpo ha prodotto e riproduce la verità del crimine. Il supplizio deve essere inteso anche come rituale politico. Il potere si manifesta. L’infrazione reca offesa a colui che fa valere la legge, attacca il sovrano, personalmente (è la sua volontà) e fisicamente (la legge è la sua forza). La sua replica col supplizio è sia una riparazione (disordine provocato è ripristinato con l’esempio) e sia una vendetta (guerra ai nemici). E’ perciò un cerimoniale per ricostruire la sovranità ferità, per ostentare forza invincibile. Se la riparazione del danno causato è proporzionata e la sentenza è equa, l’esecuzione è enfatica e si abbatte sul corpo. Non ristabilisce giustizia, riattiva il potere. Alcuni caratteri della liturgia dei supplizi in questa ottica: 1. ostentare il fasto in pubblico e il trionfo della legge (sfilate, soste, letture, inginocchiamenti, pentimento) 2. la giustizia si mostra armata con l’apparato militare (cavalieri, ufficiali, soldati, arcieri): sia per impedire un moto di simpatia/rabbia del popolo ma anche ricordare il rapporto di forza contro i nemici del principe. 3. rapporto criminale-sovrano con due facce: vittoria e lotta. La vittoria scontata e la distruzione del nemico (dissimmetria di forze), e lo scontro è dato dal carnefice che adopera la forza: il boia è il campione del re, ma non ha potenza sovrana e condivide col condannato l’infamia (ecco lo scontro “pari”). L’esistenza dei supplizi ha una funzione precisa: è rivelatore di verità e operatore di potere. Il rapporto verità-potere si inserisce nel cuore di tutti i meccanismi punitivi. L’atrocità che ossessiona i supplizi in questo senso ha appunto il doppio ruolo: comunica la pena, esaspera il castigo: assicura lo splendore della verità e del potere. E’ nel secolo 1800 che si cercherà di mettere distanza tra verità e violenza, la punizione è sì una conseguenza, ma non deve essere un crimine più grande di quello che castiga. Nei supplizi invece la meccanica del potere non si nasconde: si esalta e rinforza, e non tramite una sorveglianza ininterrotta, ma facendo risplendere ritualmente la propria realtà di superpotere. Perché le pene passano dall’essere atroci a “umane”? la ragione si trova nei supplizi e in particolare nel suo funzionamento che incute terrore; l’ elemento protagonista è lo spettatore, il popolo. Egli rivendica il suo diritto di inserirsi, prendervi parte. La partecipazione è accettata dal re perché è la sua vendetta e dimostra fedeltà e obbedienza, ma è anche limitata per segnalare la distanza dai suoi privilegi. Il popolo non assiste e sostiene semplicemente: attraverso lo spettacolo può coagulare il suo rifiuto per il potere punitivo: impedire condanna, inseguire e assalire gli esecutori, schiamazzare, sentire il condannato che inveisce contro il potere, i giudici, la religione e le leggi. Il disordine è creato per diversi motivi (pene ingiuste, differenze pene per classi sociali, pene troppo pesanti) e in generale è frutto di malcontento; questo si esprimeva nei supplizi in cui si accendevano focolai di illegalità (lavoro si interrompeva, furti, ingiurie, violenze, ci si impadroniva del condannato) e tutti gli inconvenienti costituivano un pericolo politico: il popolo si sentiva vicino ai condannati, minacciato da una violenza legale senza misura. Queste agitazioni provocano quindi di una inversione dei ruoli: i criminali vengono trasformati in eroi e il potere è beffato. I Riformatori del 700 e 800 avevano come obiettivo la rottura di questa solidarietà. La giustizia aveva bisogno che la sua vittima autenticasse in qualche modo il supplizio che subiva. Un esempio sono i discorsi da patibolo: il condannato prendeva parola per testimoniare? Un buon numero di volte, ma spesso i discorsi venivano fatti circolare in seguito attraverso i fogli volanti, documenti apocrifi di propaganda utilizzati per legittimare il supplizio. L’effetto però era equivoco: il condannato veniva eroicizzato dall’ampiezza dei suoi delitti (amplificati): l’eroe positivo. Il tentativo di controllo ideologico di incontra con una volontà popolare, un interesse politico. I Riformatori eliminarono i fogli volanti e in seguito nasce una nuova letteratura del crimine: quest’ultimo è glorificato (astuzie, sottigliezze, acume) e c’è bellezza; non ci sono più gli eroi popolari, si è cattivi ma intelligenti, se si è puniti non si deve soffrire.
3
Parte 2 – PUNIZIONE
1 – La punizione generalizzata
Nella seconda metà del 700 inizia la protesta contro i supplizi da parte di filosofi, giuristi, teorici del diritto, parlamentari. E’ necessario che la giustizia penale, anziché vendicarsi, finalmente punisca. Il castigo senza supplizio nasce sia in virtù di una umanità ricercata (indignazione), e sia come limite al diritto: frontiera legittima del potere di punire; un uomo-misura del potere. Come si articolano i due elementi di una penalità addolcita: “misura” e “umanità”? la nascita della “dolcezza”.
La riforma giudiziaria del 700 va inserita in un doppio processo per cui durante questo periodo, i crimini sembrano perdere parte della loro violenza (non numerosità) e le punizioni reciprocamente si alleggeriscono di intensità (ma gli interventi si moltiplicano). I crimini si “addolciscono” verso la fine del 600, calano i delitti di sangue e i delitti alla proprietà sembrano dare il cambio a quelli violenti (dal corpo ai beni e frode); delinquenza abile e più “individuale” ossia gruppi piccoli piuttosto che grandi organizzazioni. Perché? Innalzamento livello di vita, incremento demografico, moltiplicazione ricchezza e proprietà. E la giustizia? Si appesantisce (rigore e meticolosità) in quanto la delinquenza aumenta e con lo spostamento delle pratiche illegali c’è un affinamento delle pratiche punitive (più controllo, sorveglianza, più tecnica e informazioni). Uno sforzo di adattamento con meccanismi di potere che portano a interventi penali più tempestivi e più numerosi (verso i delitti economici aumentati). La critica dei Riformatori alla giustizia tradizionale è l’eccesso dei castighi: un eccesso legato a una cattiva economia del potere (non perche nuova sensibilità). Non abuso di potere, ma irregolarità nella giustizia penale: troppe istanze che la gestiscono (signorili, reali, amministrative, di polizia, il Re); La rendono lacunosa (procedure, competenze, interessi politici e economici che ogni istanza difende) e mal distribuita, talvolta indulgente, talvolta severa. Pertanto il vero obiettivo dei Riformatori è fondare un nuovo diritto di punire, non per avere principi più equi, ma stabilire una nuova economia del potere di castigare (distribuito, omogeneo, continuo, regolare, efficace, dettagliato, poco costoso economicamente e politicamente). Fare della punizione una funzione regolare, non punire meno ma punire meglio, severità attenuata ma più universale, inserita nel profondo del corpo sociale. Schematicamente sotto l’Ancien Regime i diversi strati sociali avevano il proprio margine di illegalismo tollerato: non-applicazione della regola, inosservanza editti o ordinanze, facevano parte del funzionamento politico ed economico della società. L’illegalismo era radicato e tollerato e i tentativi di ridurlo provocavano agitazioni. Nei bassi ceti della società raggiungeva la criminalità e la alimentava (illegalismo fiscale e doganale, contrabbando, saccheggio, lotta armata). E fra caste sociali? In linea generale differenti illegalismi: appoggio reciproco, complicità ma anche conflitti di interesse, rivalità e concorrenza. Ma nella seconda metà del 700 avviene il cambiamento: se aumentano le ricchezze il bersaglio principale dell’ illegalismo popolare diventano non più i diritti ma i beni: ruberie e furti sostituiscono il contrabbando e lotta armata. La borghesia non sopporta l’illegalismo dei beni in quanto tocca i diritti della proprietà (privata, commerciale, industriale) e si accanisce contro la parte povera della popolazione: questo illegalismo non è più tollerato, necessita repressione sistematica e armata. Si apre progressivamente una crisi dell’illegalismo popolare. Soluzione? Controllare e ricodificare tutte le pratiche illecite. L’economia degli illegalismi si è ristrutturata con lo sviluppo della società capitalistica e ricopre opposizione di classe (illegalismo beni-popolare e dirittiborghesia). Ecco la grande ridistribuzione degli illegalismi con la borghesia che domina uno e controlla
4
l’altro: un sistema penale come meccanismo per gestire gl’illegalismi in modo differenziato e non per sopprimerli tutti. Insomma, la riforma penale è nata nel punto di giunzione tra la lotta contro il superpotere del sovrano e quella contro l’infrapotere degl’illegalismi conquistati e tollerati; ecco perché la critica dei supplizi è cosi importante per la riforma: si congiungevano il potere illimitato del sovrano e l’illegalismo del popolo.
La riforma penale del 700 costruisce una nuova economia ed una nuova tecnologia del potere di punire: nuove tattiche, nuovo bersaglio, nuovi principi. Tali principi formulati nella teoria generale del contratto: il cittadino accetta le leggi della società, il criminale rompe il patto; tutti accettano la pena perché è la difesa della società (non più il sovrano); il castigo penale è dunque una funzione generalizzata, coestensiva al corpo sociale e a tutti i suoi elementi. E le pene? moderate e differenti da quelle del sovrano, eccessive; ma per un discorso di “umanità”? non proprio; la misura è data da una sensibilità che comporta calcolo di chi fa le leggi: si voglio evitare effetti di ritorno del castigo (indurimento, ferocia, o indulgenza non fondata) sull’istanza che punisce, si regolano gli effetti del potere. Il torto che il criminale fa alla società è il disordine che vi introduce (scandalo, esempio, incitamento, generalizzazione): cambia la relazione tra delitto e punizione. Non più un rapporto qualitativo (stesso orrore) ma un calcolo in ottica futura: principio della prevenzione. Anche in passato il castigo era esemplare ma con una meccanica diversa: era una replica del crimine; ora la punizione rinvia al crimine in modo discreto per evitare la sua ripetizione. La semio-tecnica della riforma riposa su 6 regole principali del rapporto delitto-castigo: 1. regola della quantità minimale; la pena deve produrre uno svantaggio sufficientemente più grande del profitto ottenuto col crimine. 2. regola dell’idealizzazione sufficiente; è più importante la rappresentazione dello svantaggio atteso, l’idea della pena, piuttosto che la sua realtà corporale. 3. regola degli effetti laterali; la pena deve produrre gli effetti più intensi sugli innocenti, non sul colpevole. 4. regola della certezza perfetta; ad ogni delitto un castigo: leggi, pene e procedure chiare e pubbliche. 5. regola della verità comune; la verifica del delitto deve obbedire ai criteri della verità: dimostrazione completa, provata, ricerca empirica, altrimenti innocenza (non mezze verità, mezza colpevolezza). 6. regola della specificazione ottimale; tutte le infrazioni qualificate, classificate, riunite, con un codice esaustivo ed esplicito. Vediamo sorgere assieme alla classificazione dei delitti e dei castighi, la necessità di una individualizzazione delle pene, conformi ad ogni criminale. E’ differente dal passato in cui le variabili erano la circostanza e l’intenzione; ora ci si riferisce al soggetto che commette, la sua natura, modo di vivere e pensare, al suo passato. I primi indizi di come il sapere psicologico darà il cambio alla giurisprudenza casistica. Ma come individualizzare? Entrano in scena nuove forme: la recidiva e il delitto passionale sono due esempi.
2 – La dolcezza delle pene
L’arte di punire deve riposare su tutta una tecnologia della rappresentazione. Se nei supplizi abbiamo i marchi-vendetta ora ci sono i segni-ostacoli (simboli e idee). Pena come rappresentazione, pena-effetto, pena-segno e discorso, pena-funzione. Come funziona? 6 regole. 1. instaurare una relazione naturale tra delitto e pena: immediatezza per analogia, somiglianza, prossimità; comunicazione simbolica che rinvia rapporti esatti (la morte per l’assassinio). 2. agire sul desiderio di delinquere, diminuendolo. Se la pena è temibile, l’interesse si abbassa.
5
3. modulazione temporale; utilizzare il tempo come operatore della pena: un esempio di uso del tempo è l’intensità regressiva della pena; una pena definitiva non serve; 4. il castigo deve essere conveniente per la società: il condannato diviene un bene sociale, di utilità pubblica attraverso il servizio allo stato. Rende la pena visibi...
Similar Free PDFs
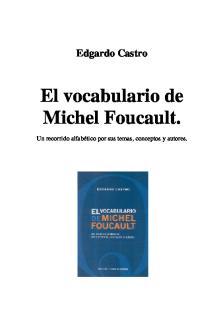
El Vocabulario De Michel Foucault
- 608 Pages

Michel Foucault fiche de lecture
- 3 Pages

Michel de montaigne - RIASSUNTO
- 5 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu












