DA Boncompagni A Casati PDF

| Title | DA Boncompagni A Casati |
|---|---|
| Course | Scienze della formazione primaria |
| Institution | Università degli Studi della Basilicata |
| Pages | 9 |
| File Size | 281.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 24 |
| Total Views | 146 |
Summary
Download DA Boncompagni A Casati PDF
Description
DA BONCOMPAGNI A CASATI: LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA SCOLASTICO NAZIONALE; Dagli anni ’40 vi fu una progressiva presa di coscienza riguardo al ruolo dell’istruzione. Giacomo Giovanetti infatti incaricato da Carlo Alberto pensava che la prosperità di uno Stato dipendeva dall’educazione ed istruzione, di qui l’importanza della scuola nella formazione di un cittadino in vista dell’unità nazionale ed industrializzazione, perciò lo Stato decise di intervenire nella gestione dell’istruzione sino a quel momento monopolio della Chiesa. Fu un processo graduale: 1844 FERRANTE APORTI SCUOLE DI METODO A TORINO(capitale del regno) corsi per gli aspiranti maestri (sostituite dopo dalle scuole normali con Casati). L’interesse verso l’istruzione portò il Magistrato della Riforma a cui era affidata l’istruzione in Piemonte ad estendere l’esperimento ad altre province del regno per preparare gli aspiranti insegnanti elementari ; 1) LEGGE BONCOMPAGNI(1848) in quegli anni vennero introdotte le Regie Patenti con cui Carlo Alberto istituiva il Ministero della Pubblica Istruzione; con la legge venne riorganizzato il sistema scolastico sotto l’egemonia dello Stato e venne ampliato il corso primario. Essa venne approvata senza essere discussa poiché in corso la prima guerra d’indipendenza e vi era l’obiettivo di raggiungere la libertà ed unità nazionale. La legge escludeva totalmente la chiesa e fu definita antireligiosa, ma non venne limitata la libertà religiosa ai privati. Il Ministro insieme al consiglio superiore della pubblica istruzione era affiancato da organi collegiali in cui vi erano insegnanti e autorità scolastiche che garantivano competenze pedagogiche. L’assetto amministrativo garantiva così uniformità e autonomia di gestione. La scuola elementare venne prolungata fino a 4 anni e vennero aggiunte altre materie per iniziare a poter competere con altre potenze europee. Importante era la lingua strumento per l’identità nazionale (Tommaso Valluri accento su grammatica e latino). Venne posto l’accento anche sul coinvolgimento di tutte le forza sociali per la lotta contro l’analfabetismo; 2) LEGGE LANZA(1857) il Ministro Carlo Farina propose una revisione della Legge Boncompagni molto più centralistica costituendo 3 organi: il Consiglio per le scuole universitarie, per le scuole secondarie e per le scuole primarie, rischiando di eliminare la coesione e continuità dei Consigli. Perciò la commissione parlamentare rivendicava maggiori garanzie e così venne rinominato Boncompagni che ritirò la proposta di Farina. Essi si contrapponevano rispettivamente il primo auspicava ad un modello che lasciava ampi spazi alle iniziative locali e il secondo invece ad un modello totalmente accentratore. Una nuova proposta venne proposta da Giovanni Lanza e prevedeva la limitazione dell’intervento legislativo alla sfera amministrativa ed una progressiva centralizzazione nel controllo dell’istruzione pubblica con rafforzamento dell’autorità ministeriale. Egli aveva previsto solo 2 organi rappresentativi in aiuto del Ministro e del provveditore: il consiglio superiore della pubblica istruzione per questioni didattiche/organizzative e la deputazione provinciale per affari di minor rilievo. Si venne a formare una struttura gerarchica su tre livelli (MINISTRO proponeva deliberava leggi-ISPETTORE GENERALE E CONSULTORE UNIVERSITARIO coordinamento e controllo-REGIO PROVVEDITORE longa manus del governo nelle realtà locali). Lancia si pronunciò negativamente circa la libertà d’insegnamento poiché vedeva nello Stato il principale esclusivo promotore dell’istruzione nazionale(Domenico Berti si oppose e la libertà era l’unica garanzia per un’istruzione basata sulla cooperazione). Per questo ebbe difficoltà nel promuovere la legge e per questo Lanza spiegò che il regno sardo rappresentava l’Italia e perciò era indispensabile l’accentramento totale. Importanza ebbero storia e l’italiano e i libri di testo adottati erano uniformi in tutto lo stato. Focus era anche la preparazione dei maestri, visti come sacerdoti laici col ruolo di educatori nazionali e la loro preparazione era responsabilità statale per ciò si preferivano scuole statali rispetto a quelle provinciali. La religione venne circoscritta ai corsi primari, solo perché Lanza dovette moderarsi e non poté escluderla. 3)LEGGE CASATI(1859) con cui prese avvio l’ordinamento della scuola italiana. Al termine della seconda guerra d’indipendenza (trattato di pace di Zurigo) il nuovo ministro Gabrio Casati elaborò una legge di riordinamento della pubblica istruzione che rifletteva la volontà di unificazione. La formazione del maestro viene svalutata visto ora come mero esecutore di contenuti. I piani di studi divennero più tecnici e lasciavano poca iniziativa e libertà al docente. Venne promossa la prospettiva di ampliamento ulteriore del regno e ciò portò all’investimento di maggiori risorse nell’istruzione pubblica col fine di formare cittadini del nuovo stato. La scuola continuò ad esser vista unico strumento valido raggiungere fini di unificazione, integrazione, e perciò venne introdotta l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria(rilevante novità). Furono preservate storia, geografia, italiano che forniva la connotazione nazionale. Le scuole di metodo vennero chiamate scuole normali che vennero notevolmente incrementate ma non si modificarono nel piano didattico e durata. Casati rafforzò il controllo statale nell’amministrazione scolastica aumentando il numero dei membri e inserendo tre ispettori per ogni ramo dell’istruzione. Quest’accentramento burocratico era bilanciato da una libertà d’insegnamento, circoscritta all’istruzione pubblica, quelle private vincolate. Tuttavia la libertà del docente era molto sacrificata e si rischiava il licenziamento qualora non si fosse attenuto ai principi dello stato. Questa scarsa libertà era dovuta ai conflitti tra stato e chiesa perciò si era diffidenti nel lasciare ampi spazi nel settore d’istruzione. Il clero affrontava il problema attraverso conferenze episcopali circa il campo educativo e la classe dirigente temeva che solo quest’ultimo potesse istituire scuole di concorrenza. La legge casati ricevette molti dissensi perché lamentavano di una prospettiva molto accentratrice che rischiava di penalizzare le scuole provinciali (Terenzio Mamiani nel 1859 tentò di rivedere il decreto ma fallì; manifestò in favore della libertà locali e private; voleva applicare la legge Casati in un’ottica più liberale ma la forte presenza del clero vissuta come una minaccia per l’accentramento nazionale dello stato divenne causa di timore nei confronti di un’autonomia che avrebbe potuto portare difficoltà e poca stabilità nazionale).
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIO ED ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE; L’obbligatorietà dell’istruzione primaria divenne la logica premessa per l’allargamento del suffragio poiché qualsiasi riforma non si sarebbe avuta senza un’adeguata alfabetizzazione. Dalla creazione del Regno d’Italia alla caduta della destra il numero delle scuole elementari, maestri e gli alunni iscritti aumentarono. Alla luce che in quegli anni si ebbe un aumento della popolazione, se ne deduce che vi fu un abbassamento dell’analfabetismo. La legge Casati dopo aver reso gratuita la scuola elementare ne fece gravare il peso finanziare anche sui comuni, anche se i corsi superiori venivano istituiti solo con 4000abitanti. La visione polemica di Aristide Gabelli era dovuta al fatto che c’erano 209 comuni nel 1862 senza alcuna scuola. Bisogna però dare atto che si volle diffondere l’alfabeto per permettere allo Stato il controllo sociale attraverso l’istruzione e non attraverso l’ignoranza del popolo. Nel 1868 sotto il ministro Broglio venne creata una commissione d’inchiesta per la scuola elementare in cui venne analizzato il numero mancante di scuole(soprattutto al Sud) e il livello degli stipendi dei maestri(min 500 lire scuole rurali e max 1200 per quelle urbane) e così si arrivò ad una legge che aumentasse le retribuzioni. I problemi della classe magistrale erano dipesi anche dalla loro non adeguata qualificazione. Nel ’69 Broglio venne sostituito da Correnti e ordinò ad una commissione di studiare la situazione delle scuole e questa elaborò una legge che prevedeva: -obbligatorietà della scuola elementare (altrimenti avrebbero dovuto pagare un’ammenda e colpiti da una serie di restrizioni); -possibilità da parte di comuni in difficoltà di dividere la spesa con la rispettiva provincia. Il progetto non entrò mai in vigore ma venne riutilizzato in un nuovo progetto che proponeva un riordino generale sotto il ministero di Scialoja nel 1873; quest’ultimo prevedeva dei delegati che vigilassero nelle scuole, insegnamento di nozioni circa le istituzioni statali e i fondamenti della giustizia e della morale ma non venne votato, Scialoja si dimise e sostituito da Bonghi, ultimo ministro del quindicennio della destra. ETA’ LIBERALE 1861-1922 (destra 1861-1875/sinistra 1876-1898/ età giolittiana 1901-1914/ fascismo 1922-1943) ETA’ REPUBBLICANA 150 anni successivi (scuola media unica 1962, scuola materna statale 1968). Il primo ministro della sinistra fu Michele Coppino che preparò un progetto breve che riproponeva i principi essenziali come: obbligatorietà elementare da 6 fino a 9 anni(gli inadempienti colpiti da ammenda); gratuità; laicità. Consapevole della difficoltà di applicazione, propose uno stanziamento di fondi straordinario per permettere ai comuni meno facoltosi di aprire nuove scuole. La commissione che esaminò la sua legge nel 1877 approvò la sua prudenza ma mosse tre critiche: le pene troppo dure per gli inadempienti; i tempi di attuazione della legge; proporzione tra abitanti e docenti. Il dibattito (5 gg) vide protagonisti Petruccelli che criticava le pene e voleva l’abolizione della teologia, Sperino, Incagnoli, Berti ecc. Al termine il Ministro approvò la legge rendendo facoltativo l’insegnamento della religione. Le polemiche continuarono: alcuni preferivano la mancanza di scuole piuttosto che vederle una minaccia; i moderati si schierarono con Coppino; i cattolici vedevano l’obbligo come una restrizione della libertà naturale che Dio ha dato; i liberali difendevano il diritto dei genitori di educare i figli. L’iter di attuazione però proseguì e per i genitori fu possibile giustificarsi qualora inadempienti dell’obbligo con il sindaco (malattie, eccessiva distanza, povertà). Sulla scia di Coppino, vennero approvati altri provvedimenti: la legge di De Sanctis 1878 per agevolare i comuni nella costruzione di scuole obbligatorie; legge sull’istituzione del monte pensioni per gli insegnanti pubblici. Le regioni che poterono attuare la legge erano circa 80% del Regno, soprattutto settentrionali e ci fu bisogno di assumere insegnanti. Le regioni meridionali risentirono del divario con il centro-Nord. La legge avrebbe dovuto aiutare i comuni in difficoltà, non aumentare il divario già esistenze tra meridione e settentrione. Le difficoltà della legge Coppino era più profonde: negli anni ’80 si era indebolita la concezione che l’istruzione avrebbe migliorato la formazione del cittadino mentre si era rafforzato il timore che l’istruzione avrebbe aumentato il pensiero critico e quindi l’indebolimento della coesione della società.
LA SCUOLA TRA STATO E SOCIETÀ NEGLI ANNI DELL'ETÀ GIOLITTIANA; Il periodo giolittiano nella storia della scuola unita rappresenta uno dei momenti più importanti. Il sistema casatiano distingueva tre rami: istruzione superiore, istruzione classica, istruzione tecnica e scuola primaria. Università e istruzione classica (poche e frequentate da altre città) erano responsabilità dello stato, scuola primaria e istruzione tecnica a carico dei Comuni (perché distribuite in modo più capillare). La Casati imponeva a tutti i comuni l’obbligo di istituire almeno una scuola ma le risorse finanziarie erano poche e perciò vi fu lentezza nella diffusione della scuola. Le classi povere non erano entusiasti di mandare i loro figli a scuola poiché era fuori dalla loro portata, difficile da raggiungere, l’ignoranza del popolo si saldava con il disinteresse dello stato. Ma con la sinistra qualcosa cambiò poiché ampliarono l’azione dello Stato, aumentarono gli stipendi e nel 1877 fu approvata la legge Coppino che rendeva obbligatoria l’istruzione elementare promettendo sovvenzioni per alleviare i sacrifici di quegli enti locali. Inoltre la legge permetteva ai comuni di chiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per costruire edifici scolastici ma la legge sviluppava i comuni già attivi quindi non c’era molta differenza con la destra. Bisogna considerare che, con l’aumento delle scuole era andato di pari passo con l’aumento demografico ma le condizioni dei materiali risultavano insufficienti; vi erano forti squilibri anche tra Nord e Sud. Il paese alle soglie dell’età giolittiana non era in grado di garantire a tutti l’istruzione elementare di base. Si erano verificati alcuni fermenti nel mondo operaio a Nord (a Milano, genova, torino) poiché nel Mezzogiorno i ceti popolari non riuscivano a liberarsi dalla rassegnazione. I movimenti creati permisero la fondazione di società di mutuo soccorso, scuole serali, festive e cominciò il mondo operaio a organizzarsi sul piano sindacale per realizzare una società che liberasse gli uomini dall’ignoranza e dalla povertà e iniziarono ad usare l’arma dello sciopero. Cominciò a diffondersi la consapevolezza che l’istruzione era un’occasione per farsi valere e migliorare le proprie condizioni di vita. In una società fondata sull’agricoltura si poteva anche rimanere analfabeti, mentre con lo sviluppo delle industrie (rivoluzione industriale 1896) occorreva avere una determinata istruzione. Nonostante ciò accrebbe sempre più il divario Nord_Sud. Però la rivoluzione portò la diffusione delle informazioni, creazione di nuovi posti di lavoro e sempre più nuovi saperi ed istruzione. Si erano formati anche dei fenomeni magistrali che difendevano gli interessi dei maestri e riflettevano sui principali nodi della scuola. Dava voce ai docenti che assunsero un enorme peso elettorale. Infatti nell’età giolittiana furono approvate molte leggi sulla scuola ponendola come centrale questione. Nel VI congresso a Roma i socialisti inserirono molti punti circa la scuola: istruzione obbligatoria fino alla 5 elementare, istruzione complementare obbligatorie e gratuita per altri 4 anni, istruzione tecnica professionale, sovvenzioni per studenti privi di mezzi, autonomia universitaria e miglioramento condizioni dei maestri, laicizzazione della scuola. Anche la chiesa si interessò alla scuola. L’età giolittiana vide la fine dell’intransigentismo cattolico, ritorno alla vita politica con i moderati, nascita di lega democratica nazionale al nord e movimenti a capo di Luigi Sturzo in sicilia. Con giolitti vi fu un grosso impulso nella diffusione dell’istruzione nel paese. Essa intraprese una grande questione tra stato ed enti locali e l’età giolittiana si può dividere in due fasi: -all’inizio fino al 1904 (orlando) impostazione casatiana si ebbe un incremento del sostegno dello stato; -eliminò poi gli aiuti statali volgendosi a sostenere solo i comuni che ne avessero avuto bisogno. La legge Orlando 1904 rafforzò l’obbligo scolastico, fino a 12 anni, introduceva meccanismi di controllo, assistenza scolastica, scuole serali e festive per adulti, migliorava il trattamento economico dei maestri uomini e donne. Dato che tali misure avrebbero comportato nuove spese ed interventi statali per gli enti locali, contando su nuove entrate previste dall’aumento delle tasse delle iscrizioni. Era una spinta ancora maggiore all’istruzione popolare e adottava molti punti socialisti. Ma non ha mai combattuto contro la dicotomia delle due scuole per i lavoratori e per i figli della borghesia, sud e nord. I settentrionali erano affamati di istruzione e i meridionali vivevano nell’ignoranza. Così i socialisti tentarono di promuovere una graduale crescita civile delle classi popolari e vi furono provvedimenti a favore delle province meridionali presentati nel 1906 da Sonnino e ripresi da Giolitti. Predisposero l’istruzione per scuole a carico dello stato. Così si potè creare scuole statali. Verso il 1906 nella sinistra e nei socialisti si diffuse una grossa spinta anticlericale, poiché si sentì l’eco della vicina francia. Tra moderati e cattolici vi fu un avvicinamento e la chiesa divenne uno strumento di libera espressione. Uno dei momenti più significativi si ebbe quando i socialisti attaccarono l’insegnamento religioso nella scuola elementare, col regolamento Baccelli si prevedeva che i comuni lo istituissero qualora le famiglie lo richiedessero ( fogazzaro denunciava questo silenzio e tensione che avrebbe diviso stato e chiesa; egli auspicava un insegnamento morale-religioso e un’istruzione extra-scoastica, proposta ignorata). Le forze laiche proposero la soppressione definitiva della religione. Emblematica fu la convergenza tra Gentile e Salvemini che criticavano l’identificazione della scuola laica con una scuola antireligiosa. All’inizio del 1908 il governo varò un regolamento per la scuola detto Rava, ministro in carica col quale si arrivò al compromesso: i comuni erano tenuti ad assicurare la religione solo dietro richiesta e solo se approvata dalla maggioranza comnale; in caso contrario i padri avrebbero dovuto provvedere autonomamente. Tale compromesso scontentò tutti cattolici e sinistra che si mosse per la mozione Bissolati (stabilizzare la laicizzazione della scuola) per indebolire il goberno giolitti. Quest’ultimo denunciò la manovra e sottolineò che era la migliore soluzione per conciliare libertà dei comuni, degli insegnanti e delle famiglie. La mozione venne respinta e giolitti si mise contro la sinistra. L’atteggiamento di giolitti era dovuto dal fatto di non voler schierarsi contro la chiesa il cui appoggio era prezioso. L’espansione del sistema produttivo richiedeva un ampliamento delle competenze che non potevano soddisfarsi tra i banchi delle scuole elementari. Aumentarono così gli iscritti agli istituti tecnici ma non in modo uniforme: al sud e nelle isole l’industria non riusciva a decollare. I contadini non potevano garantire un’istruzione elementare mentre la borghesia settentrionale mirava a vedere i propri figli con la laurea.
Nelle zone del nord invece si preferivano scuole tecniche che non offrivano però una preparazione adeguate per carriere di commercio, banche, industrie. Perciò si ebbe la necessità di rinnovare gli studi secondari derivante dal cambiamento socioculturale del paese. Si volle far risaltare il sapere scientifico e si voleva creare una scuola media unica a carattere orientativo. Nel 1905 il ministro Bianchi elaborò un progetto che aboliva le scuole sostituendole con una scuola media quadriennale alla fine della quale uno studente avrebbe potuto scegliere tra scuola normale, tecnica o media di secondo grado col ramo classico e scientifico. La federazione magistrale era in disaccordo poiché manovra rischiosa in una società così in rapida trasformazione. Si arrivò ad accettarlo in via però sperimentale senza abolizione delle scuole. Nel 1906 fu approvata. Galletti e Salvemini si dimisero contrariati perché essa avrebbe dovuto andare incontro alle esigenze di formazione della maggioranza ovvero i più poveri. Gli studiosi così idearono un progetto che si avrebbe dovuto dividere la scuola in: popolare per una preparazione pratica; media cultura per studi professionalizzanti; alta cultura per proseguire con gli studi e alimentare la classe dirigente. Ritenevano inoltre che coloro che si fossero trovati in difficoltà avrebbero potuto abbandonare le scuole a favore di quelle meno elevate. Questo progetto contrastava Bianchi. Da quel momento Salvemini per la battaglia dell’alfabetizzazione delle masse compì vari interventi per il progetto con Galletti. Nei dibattiti del VII congresso emersero 3 posizioni: -prof. De Gobbis voleva una scuola media di primo grado unica generale; -Salvemini e Galletti distinguevano il corso preparatorio per scuola tecnica e scuola normale e il corso per l’università; - prof. Niccoli scuola media unica senza latino. La federazione approvò la linea salveminiana e la fondazione di un liceo moderno. Salvemini voleva premiare i poveri ma meritevoli attraverso sussidi; bisognava sottoporli a una selezione per non emarginare i ceti più poveri. Il focus era una forte ...
Similar Free PDFs

DA Boncompagni A Casati
- 9 Pages

LA Legge Casati
- 5 Pages

La legge Casati del 1859
- 81 Pages

A Importancia DA Biologia
- 1 Pages

A Cultura DA Cebola
- 68 Pages

DA IE A GMC
- 4 Pages

A eclosão da guerra fria
- 2 Pages

A legitimação da Educação Física
- 7 Pages

Resumo - A HORA DA Estrela
- 1 Pages
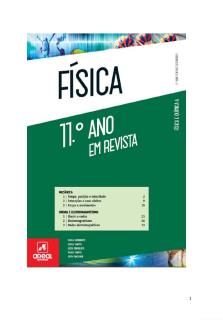
Resumo DA Física 11ANO A
- 38 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





