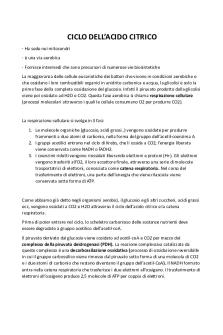Politche di discriminazione di prezzo PDF

| Title | Politche di discriminazione di prezzo |
|---|---|
| Course | Economia industriale |
| Institution | Università degli Studi di Udine |
| Pages | 8 |
| File Size | 406.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 263 |
| Total Views | 453 |
Summary
POLITICHE DI DISCRIMINAZIONE DI PREZZOLe politiche di prezzo sono politiche adottate dalle imprese con riferimento al prezzo dei propri prodotti. L’obiettivo è la massimizzazione del profitto MA tutte le politiche di prezzo si allontanano dal costo marginale. Perché ciò accade nella realtà e quali s...
Description
POLITICHE DI DISCRIMINAZIONE DI PREZZO Le politiche di prezzo sono politiche adottate dalle imprese con riferimento al prezzo dei propri prodotti. L’obiettivo è la massimizzazione del profitto MA tutte le politiche di prezzo si allontanano dal costo marginale. Perché ciò accade nella realtà e quali sono gli obiettivi delle imprese? Si riferisce alle imprese che possono definire il prezzo (price making), l’obiettivo convenzionalmente preposto alle politiche di prezzo nella teoria economica è la massimizzazione del profitto dell’impresa, ma ci sono anche altri obiettivi: Prezzo limite: si ostacola oggi l’ingresso di altre imprese ottenendo profitti minori oggi ma ipotizzando di ottenere maggiori profitti futuri. Prezzi discriminatori: si fissa un prezzo differente per consumatori differenti rompendo così la legge del prezzo unico. o Può esserci anche una discriminazione intertemporale fissando prezzi diversi in periodi diversi allo stesso consumatore. Prezzi predatori: se il p è utilizzato per scoraggiare imprese potenziali entranti o per incentivare l’uscita dei rivali. Prezzi di penetrazione: sono simili ai prezzi predatori ma il prezzo non è inferiore al costo medio minimo => è comunque molto basso poiché si ha l’obiettivo di entrare in un nuovo mercato. o Si lega al fatto che esistono vantaggi per quanto riguarda le economie di apprendimento. o Sono i classici prezzi lancio. o Ciò si lega al fatto che si aumenterà la quantità venduta nel tempo per ottenere una migliore scala e migliori economie di apprendimento. Vintage pricing: l’obiettivo è quello di definire un prezzo che consenta di rientrare dagli investimenti il più velocemente possibile; è un concetto simile a quello di “payback period”. Definizione tradizionale (Pigou, Robinson) Si definisce una politica di discriminazione di prezzo la vendita di più unità dello stesso prodotto a prezzi diversi (allo stesso consumatore o a consumatori diversi) contraddicendo alla legge dell’unico prezzo. La discriminazione di prezzo è la differenza di prezzo fra n unità dello stesso bene non giustificata da una equivalente differenza nei costi (esclusi i costi di trasporto). 1. NB se una differenza di prezzo deriva da una differenza di costo non si parla di discriminazione di prezzo => ad esempio libri in diversi formati o le auto nei diversi Paesi. 2. Non è sempre facile capire se un eventuale prezzo differente tra prodotti o consumatori è giustificato da un differenziale di costo o da discriminazione di prezzo. Condizioni per la discriminazione di prezzo Ci sono 3 condizioni per attuare una discriminazione di prezzo: Potere di mercato: l’impresa deve essere price-making => contesto che si allontana da quello di concorrenza perfetta e lontano anche dall’oligopolio alla Bertand (in entrambi i casi p=MC) ma anche da un contesto di mercati contendibili (p=Cmedio min). o Si è quindi in un contesto cournotiano in cui non valgono le condizioni di concorrenza perfetta. Assenza di arbitraggio: non deve essere possibile per i consumatori acquistare ad un prezzo più basso e rivenderlo ad altri [o si compra dall’impresa o non si compra]. o Ci deve essere quindi assenza di mercati secondari (transfer of commodity e transfer of demand).
o NB l’arbitraggio può riguardare: Rivendere il prodotto acquistato Spostarsi nel mercato in cui il prezzo è più basso => ad esempio ci possono essere diversi mercati geografici in cui il prezzo è differente [ciò viene ad esempio permesso da e-commerce che permette l’acquisto in altri paesi]. L’impresa conosce direttamente o può inferire la disponibilità a pagare dei consumatori e/o può spingerli a ad auto-selezionarsi sulla base della stessa. o In questo senso l’impresa può proporre un prezzo maggiore per il consumatore con più disponibilità a pagare e viceversa per un consumatore con minore diponibilità. o => se l’impresa non ha questa informazione direttamente, ha la possibilità di reperire informazioni spingendo i consumatori a comunicare la loro disponibilità a pagare sulla base dei loro comportamenti.
Tipologie di discriminazione di prezzo Ci sono 3 tipologie di discriminazione: Primo grado: [discriminazione diretta] si basa su informazione perfetta o L’impresa conosce i prezzi di riserva di tutti i consumatori o è in gradi di applicare a ciascuna unità di prodotto un prezzo esattamente pari al prezzo massimo che ciascun consumatore è disposto a pagare. o NB è un caso più teorico che pratico perché significa che l’impresa ha perfetta informazione sulle preferenze dei consumatori. Secondo grado: [discriminazione indiretta] o l’impresa non ha informazioni sui singoli consumatori o può acquisire l’informazione proponendo differenti combinazioni di prodotto a prezzi diversi (diversi menù tariffari) e lasciare che siano i consumatori stessi a rivelare la propria disponibilità a pagare (auto-selezione). Un esempio possono essere i diversi menù tariffari per quanto riguarda le promozioni sul mercato degli smartphone. Terzo grado: [discriminazione diretta] o l’impresa conosce la disponibilità a pagare di singoli gruppi di consumatori, ma non dei singoli consumatori all’interno dello stesso gruppo. Ad esempio nei servizi di trasporto (aereo o ferroviario): clientela business vs “normale” a seconda del momento in cui viene acquistato il biglietto. Discriminazione di primo grado NB viene presa a riferimento una situazione di monopolio perché più semplice, ma ciò varrebbe anche per oligopolio alla Cournot nel caso di un’impresa con ampio potere di mercato. Questo grafico rappresenta una situazione di monopolio con il surplus del consumatore (differenza tra la disponibilità a pagare e il prezzo del prodotto) del consumatore (differenza tra costo marginale e prezzo di vendita del prodotto) e la perdita secca (ovvero la perdita di surplus o benessere totale).
questo grafico rappresenta la situazione in cui 2 consumatori acquistano lo stesso prodotto ma pagando due prezzi diversi => si vede come in questo caso il surplus dei consumatori diminuisce, il surplus del produttore aumenta e la perdita secca rimane invariata.
in presenza di molti consumatori, se l’impresa monopolista è a conoscenza della disponibilità a pagare di ogni consumatore, praticherà un prezzo pari alla disponibilità a pagare di ogni consumatori => in questo modo si annulla il surplus dei consumatori e si massimizza quello dell’impresa. In questo caso però viene anche annullata la perdita secca perché l’impresa ha convenienza a vendere anche in quella zona => l’impresa infatti non pratica più un prezzo unico ma pratica un prezzo diverso per ogni consumatore. In questo caso si aumenta la quantità prodotta perché è conveniente per l’impresa dato che può abbassare il prezzo solo per chi non era disposto a pagare il prezzo di monopolio. La perdita secca si verifica in caso di monopolio con un prezzo unico poiché c’è una parte di domanda che non acquista a causa del prezzo troppo elevato. In questo modo il surplus del produttore sarà massimo (e pari all’intera area grigia), riuscendo ad estrarre l’intero surplus del consumatore. L’impresa ha quindi incentivo ad aumentare la produzione fino a quando costo marginale e ricavo marginale non si eguagliano => in questo modo produce una quantità pari a quella che verrebbe prodotta in un contesto di concorrenza perfetta. NB siccome viene prodotta la quantità di concorrenza perfetta, questa configurazione di mercato viene definita efficiente ma sorge un problema perché questa è una situazione in cui il consumatore sarebbe svantaggiato => problema in termini distributivi (esito negativo sotto il profilo della distribuzione del surplus). Discriminazione di prezzo di primo grado e benessere Nel caso di discriminazione di prezzo di primo grado il produttore estrae l’intero surplus dei consumatori. Potendosi appropriare dell’intero surplus netto, l’impresa è incentivata ad accrescere la produzione o NB vendita di una quantità addizionale di beni non ha effetti sul prezzo delle altre unità (ricavi marginali sono pari al prezzo e il monopolista produce fino a che questi non eguagliano il costo marginale).
Il monopolio con discriminazione di primo grado è una configurazione di mercato efficiente o Il monopolista che discrimina sceglie di produrre la stessa quantità di concorrenza perfetta (perdita secca di monopolio è interamente eliminata). In pratica, difficilmente riscontrabile nella realtà (ci dovrebbe essere perfetta informazione da parte dell’impresa sui consumatori).
Discriminazione di primo grado e prezzi non lineari La discriminazione di prezzo di primo grado può essere estesa anche a situazioni in cui i consumatori hanno identica curva di domanda e l’impresa può fissare una tariffa a due stadi in modo da estrarre l’intero surplus. Esempi: “Disneyland pricing” (Oi, 1971): l’impresa fissa una tariffa a due stadi o binomia [p*, A*] dove p*=Cmg e A* è pari al surplus di ciascun consumatore. “Take it or leave it”: l’impresa offre la quantità q* ad un prezzo T*=p*q*+A*. Discriminazione di primo grado con prezzi non lineari l’impresa fissa un prezzo non lineare tale per cui il prezzo è composto di 2 parti: Parte fissa => per accedere al servizio/prodotto Parte variabile => dipende dalla quantità. Ciò porta ad un cosiddetto sconto-quantità cioè il consumatore che acquista la quantità maggiore è quello che paga il prezzo minore per unità. Tariffa binomia [p*,A*] => in presenza di consumatori omogenei, si può realizzare in questo modo una discriminazione di primo grado. In questa tariffa binomia p=Cmg e A=surplus di ciascun consumatore. T=A+pq con A parte fissa e pq parte variabile; i consumatori omogenei hanno tutti la stessa curva di domanda. Se p*=Cmg la quantità prodotta q* sarà pari alla quantità di concorrenza perfetta. Inoltre se il prezzo è pari al costo marginale, l’area in grigio è il surplus del consumatore => per estrarre quel surplus l’impresa utilizza la parte fissa della tariffa pari a A*. Questa è ad esempio la modalità di tariffazione dei parchi divertimenti (Disneyland pricing). NB ciò si regge sull’ipotesi che i consumatori siano omogenei => ciò permette di estrarre l’intero surplus del consumatore attraverso una sola tariffa. Discriminazione di prezzo di secondo grado È un tipo di discriminazione indiretta. L’impresa conosce che i consumatori differiscono per qualche caratteristica rilevante per l’impresa (es. reddito) ma non è in grado di identificare individualmente i consumatori. [ci sono diverse disponibilità a pagare ma non si sa chi ha questa disponibilità] In questo contesto si pone un problema: ad esempio gli acquirenti con reddito elevato vorranno essere identificati come acquirenti con basso reddito al fine di pagare il prezzo più basso. Le tariffe a due stadi La discriminazione di prezzo di secondo grado si basa sul disegno di una price schedule tale che gli acquirenti: Siano introdotti a rivelare le loro caratteristiche.
Selezionino automaticamente il pacchetto prezzo/quantità definito per loro. Il più semplice meccanismo è una tariffa a due stadi che consenta di discriminare fra consumatori con elevata domanda e consumatori con bassa domanda. T=p*q+F Il prezzo unitario dipende dalla quantità acquistata: o F è la parte fissa. o p*q è la parte variabile in relazione alla quantità acquistata. o La somma pq+F è una funzione lineare della quantità acquistata MA ciò che rileva è il fatto che il prezzo unitario p+F/q non sia costante. Grafico: discriminazione di prezzo di secondo grado
Consideriamo preliminarmente due consumatori rappresentativi (1 e 2) con differenti elasticità della domanda rispetto al prezzo (ma per semplicità stesso prezzo massimo). Consumatore 1: bassa intensità di domanda Consumatore 2: alta intensità di domanda => a parità di prezzo, la quantità acquistata è maggiore. Supponendo che P=Pc (prezzo di concorrenza perfetta, quindi prezzo pari al costo marinale) uguale per entrambi. Se si fissa una parte fissa pari ad AGPc solo il consumatore 2 acquisterebbe il prodotto mentre il consumatore 1 decide di non acquistare in quanto vedrebbe estrarre un valore maggiore del surplus che realizzerebbe acquistando al prezzo Pc. In questo caso l’impresa rinuncia a servire il consumatore 1 => potrebbe essere un’opzione nel caso in cui il profitto che si ottiene da due è maggiore della perdita che si ottiene rinunciando a servire 1. L’area AFG è minore di AFPc quindi in questo caso l’impresa avrebbe maggiori perdite che guadagni se rinunciasse a servire il consumatore 1. L’impresa fisserà quindi la parte fissa della tariffa pari ad AFPc => in questo modo estrae completamente il surplus del consumatore 1. Il consumatore 2 si vede estratto parte del surplus (pari all’area AFPc) => 2 ottiene un vantaggio nell’acquistare il prodotto con questa tariffa => area AGF pari al surplus del consumatore. Con questa tariffa il profitto dell’impresa sarebbe pari a L’impresa può migliorare il suo profitto? Esiste una tariffa T2 migliore? Si fissa una parte variabile superiore al Cmg di un delta. Ora la parte fissa è pari a W ad un livello al quale acquistano entrambi i consumatori.
Profitto dell’impresa da 1: Profitto dell’impresa da 2: Profitto totale: Si nota come il profitto da T2 sia maggiore di quello da T1 => se l’area Z è maggiore dell’area Y, ciò consente all’impresa di ottenere un profitto maggiore fissando la tariffa in questo modo. All’impresa conviene quindi fissare la tariffa due, in corrispondenza della quale il prezzo è maggiore per la parte variabile, mentre per la parte fissa è pari al surplus del consumatore a bassa intensità. La discriminazione di secondo grado in questo caso consiste nello spingere il consumatore 2 ad acquistare una maggiore quantità di prodotto. Il fatto che l’impresa non conosca la disponibilità a pagare porta ad una perdita di efficienza, inoltre il monopolista non può estrarre l’intero surplus dal consumatore. La differenza con la discriminazione di primo grado è anche, quindi, dal punto di vista dell’efficienza allocativa data dalla mancata estrazione dell’intero surplus del consumatore. NB questo esempio è molto semplice ma ad esempio nel caso delle tariffe della telefonia mobile c’è un menù di tariffe. Nel caso di diverse tariffe, sorge un problema per quanto riguarda il fatto di capire se chi compra è un consumatore ad alta o bassa intensità di domanda. Consumatori eterogenei e tariffe multiple In presenza di consumatori eterogenei, l’impresa potrebbe avere convenienza a fissare tariffe multiple. Le tariffe multiple devono rispettare due vincoli: Vincolo di incentivazione: i consumatori di tipo i preferiscono la tariffa i alla tariffa j. o Bisogna strutturare le tariffe in modo che j non acquisti la tariffa i. Vincolo di partecipazione: ogni consumatore preferisce acquistare una quantità positiva piuttosto che non acquistare affatto. o Bisogna spingere più consumatori possibile ad acquistare. Menù ottimale di tariffe: Tariffa consumatori a bassa intensità di domanda: (parte fissa minore, parte variabile maggiore) Tariffa consumatori ad alta intensità di domanda: (parte fissa maggiore, parte variabile minore) NB ci possono essere tariffe ancora più complesse ad esempio in più parti o a scaglioni per spingere i consumatori ad auto-selezionarsi. [il presupposto è sempre quello che l’impresa non conosce chi sono i consumatori ad alta o bassa intensità di domanda] Si possono verificare casi di abbandono del consumatore se non è profittevole la discriminazione ma è più profittevole concentrarsi sul consumatore ad alta intensità di domanda. Caratteristiche della discriminazione di prezzo di secondo grado Caratteristiche essenziali: Estrae l’intero surplus dai consumatori con bassa domanda, mentre lascia una quota di surplus all’altro gruppo di consumatori. Offre meno della quantità socialmente ottimale ai gruppi di consumatori diversi da quelli a domanda elevata. Offre uno sconto-quantità. La discriminazione di prezzo di secondo grado converte il surplus del consumatore in profitti in maniera meno efficace della discriminazione di primo grado.
Qualche consumatore è “abbandonato” in modo da indurre i consumatori a elevata domanda ad acquistare maggiori quantità… ma ci potrebbero essere casi in cui è conveniente offrire solo ai consumatori a elevata domanda. Discriminazione di prezzo di terzo grado o group princing Tre elementi essenziali: 1. I consumatori differiscono per alcune caratteristiche facilmente osservabili (età, reddito, localizzazione, ecc.) che consentono all’impresa di raggrupparli in termini di differente disponibilità a pagare (segmentazione del mercato). a. A differenza della discriminazione di secondo grado c’è una caratteristica che indica all’impresa se il consumatore è ad alta o bassa intensità di domanda (età, reddito, localizzazione…) 2. Il monopolista è in grado di evitare l’arbitraggio fra gruppi. 3. Prezzi uniformi differenti sono richiesti ai diversi gruppi (group pricing). a. “kids are free” b. Abbonamento a riviste professionali c. Pricing internazionali => prezzi diversi in paesi diversi per lo stesso bene. d. Early-birds specials => esempio dei trasporti in cui si offrono biglietti a prezzi diversi a seconda del momento in cui si acquista. NB non è sempre facile capire se ci sono o meno differenze di costo che causano differenti prezzi. In ambito Antitrust questi casi sono numerosi e vengono sanzionati ma in questo ambito si considera anche la posizione dell’impresa nel mercato: Impresa con posizione dominante => questa politica di prezzo non è consentita. Impresa non in posizione dominante => politica di prezzo consentita. Un’altra discriminante può essere se queste politiche vengono applicate nell’ambito di un’intesa tra imprese del settore. Grafico: discriminazione di terzo grado
esistono due gruppi di consumatori (A e B) con le rispettive funzioni di domanda. La domanda del gruppo B è più elastica in ogni suo punto.
dal grafico si vede come i due gruppi reagiscano diversamente a variazioni di prezzo => se il prezzo aumenta si perde poca domanda da gruppo A ma molta di più dal gruppo B. Se si applicano due prezzi differenti ai due gruppi il prezzo che
massimizza il profitto si ha in corrispondenza dell’intersezione tra le curve di ricavo e costo marginale Rmg=Cmg. Regola dell’elasticità: in regime di discriminazione dei prezzi di terzo grado, l’impresa pratica un prezzo più basso a quei consumatori la cui domanda è più elastica: Si aumenta il prezzo nel gruppo in cui l’elasticità della domanda è minore. Si diminuisce il prezzo nel gruppo in cui l’elasticità della domanda è maggiore. Discriminazione di prezzo di terzo grado: regola dell’elasticità La condizione necessaria affinché siano massimizzati i profitti è che il ricavo marginale sia pari al costo marginale in ciascun segmento servito. Se il costo marginale è identico, ciò significa che i ricavi marginali sono gli stessi sull’ultima unità venduta in ciascun segmento. o RmgA=Cmg=RmgB o o o o L’impresa impone un prezzo più basso nel segmento caratterizzato da domanda più elastica. Discriminazione di prezzo di terzo grado: effetti sul benessere L’effetto netto in termini di benessere dipende da tre fattori: l’effetto sul profitto dell’impresa e l’effetto sui due gruppi di consumatori. [l’effetto complessivo in termini di efficienza è minore rispetto alla discriminazione di primo grado, ciò vale anche per il profitto dell’impresa] Se q* è la quantità venduta praticando un prezzo unico; in generale se: 1. => il benessere decresce. 2. => il benessere decresce comunque perché il medesimo output non è più distribuito in maniera efficiente. 3. Per avere un incremento di benessere l’output totale deve aumentare in maniera tale da compensare l’inefficienza creata dalla discriminazione. a. Se potrebbe aumentare il benessere (ma non sempre accade). Diverso è il caso in cui la discriminazione di prezzo consente di fornire un mercato in precedenza non servito (un prezzo unico di monopolio non consente ai consumatori con domanda elastica di acquistare il bene) => es. farmaci e paesi in via di sviluppo => migliora la situazione in termini di efficienza. VEDERE ALTRE SLIDE...
Similar Free PDFs

Politiche DI Prezzo
- 2 Pages

Strategia DI Prezzo
- 2 Pages

Stadi DI Sviluppo DI Erikson
- 4 Pages

Lezioni di Laboratorio di chimica
- 15 Pages

Atlante di neuroscienze di Netter
- 242 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu